
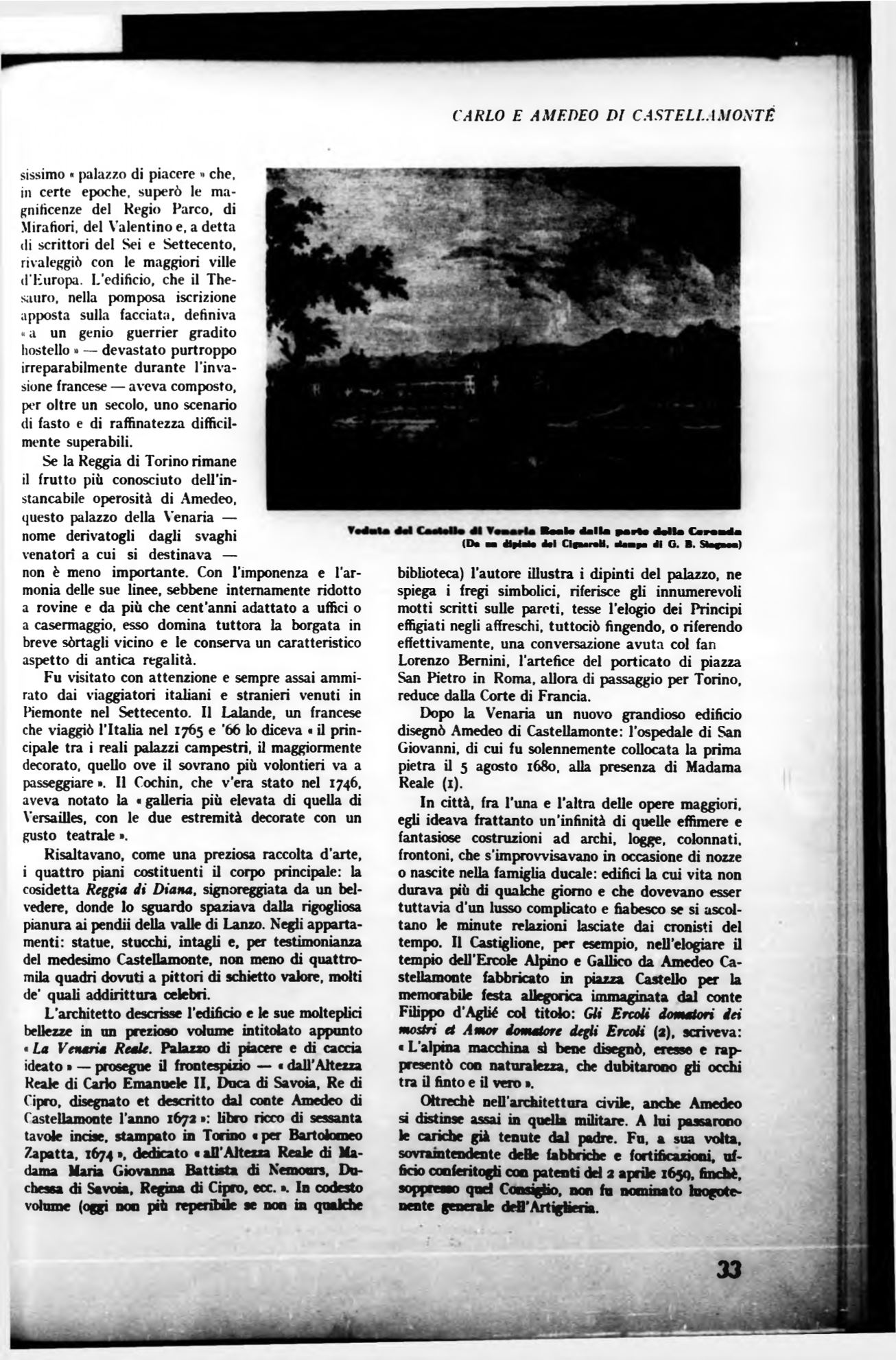
CARLO E AMEDEO D I C A S T E LI.
.1
M ONTÉ
sissimo «pala/zo di piacere »che,
in certe epoche, superò le ma
gnificenze del Regio Parco, di
Miratìori, del Valentino e, a detta
di scrittori del Sei e Settecento,
rivaleggiò con le maggiori ville
d’Europa. L ’edificio, che il The-
sauro, nella pomposa iscrizione
apposta sulla facciata, definiva
«a un genio guerrier gradito
hostello »— devastato purtroppo
irreparabilmente durante l'inva
sione francese — aveva composto,
per oltre un secolo, uno scenario
di fasto e di raffinatezza difficil
mente superabili.
Se la Reggia di Torino rimane
il frutto più conosciuto dell’in
stancabile operosità di Amedeo,
questo palazzo della Yenaria —
nome derivatogli dagli svaghi
venatori a cui si destinava —
non è meno importante. Con l ’imponenza e l’ar
monia delle sue linee, sebbene internamente ridotto
a rovine e da più che cent’anni adattato a uffici o
a casermaggio, esso domina tuttora la borgata in
breve sórtagli vicino e le conserva un caratteristico
aspetto di antica regalità.
Fu visitato con attenzione e sempre assai ammi
rato dai viaggiatori italiani e stranieri venuti in
Piemonte nel Settecento. Il Lalande, un francese
che viaggiò l’Italia nel 1765 e ’66 lo diceva «il prin
cipale tra i reali palazzi campestri, il maggiormente
decorato, quello ove il sovrano più volontieri va a
passeggiare ». Il Cochin, che v ’era stato nel 1746,
aveva notato la «galleria più elevata di quella di
Versailles, con le due estremità decorate con un
gusto teatrale ».
Risaltavano, come una preziosa raccolta d’arte,
i quattro piani costituenti il corpo principale: la
cosidetta
Reggia di Diana,
signoreggiata da un bel
vedere, donde lo sguardo spaziava dalla rigogliosa
pianura ai pendii della valle di Lanzo. Negli apparta
menti: statue, stucchi, intagli e, per testimonianza
del medesimo Castellamonte, non meno di quattro
mila quadri dovuti a pittori di schietto valore, molti
de' quali addirittura celebri.
L ’architetto descrisse l ’edificio e le sue molteplici
bellezze in un prezioso volume intitolato appunto
•
La Venaria Reale.
Palazzo di (Macere e di caccia
ideato »— prosegue il frontespizio — «dall’Altezza
Reale di Cario Emanuele II, Duca di Savoia, Re di
Cipro, disegnato et descritto dal conte Amedeo di
Castellamonte l’anno 1672 ■: libro ricco di sessanta
tavole incise, stampato in Torino «per Bartolomeo
Zapatta, 1674 », dedicato «all’Altezza Reale di Ma
dama Maria Giovanna Battista di Nemours, Du
chessa di Savoia, Regina di Cipro, ecc. ». In codesto
volume (oggi non più reperibile se non in qualche
B
m
I* d a lla parto «M ia Caram la
(Da
mm
«rialo del CloareU. -U-p. di G. B. SUooa)
biblioteca) l’autore illustra i dipinti del palazzo, ne
spiega i fregi simbolici, riferisce gli innumerevoli
motti scritti sulle pareti, tesse l ’elogio dei Principi
effigiati negli affreschi, tuttociò fìngendo, o riferendo
effettivamente, una conversazione avuta col fan
Lorenzo Bernini, l’artefice del porticato di piazza
San Pietro in Roma, allora di passaggio per Torino,
reduce dalla Corte di Francia.
Dopo la Venaria un nuovo grandioso edificio
disegnò Amedeo di Castellamonte: l ’ospedale di San
Giovanni, di cui fu solennemente collocata la prima
pietra il 5 agosto 1680, alla presenza di Madama
Reale (1).
In città, fra l ’una e l ’altra delle opere maggiori,
egli ideava frattanto un’infinità di quelle effimere e
fantasiose costruzioni ad archi, logge, colonnati,
frontoni, che s’improvvisavano in occasione di nozze
o nascite nella famiglia ducale: edifici la cui vita non
durava più di qualche giorno e che dovevano esser
tuttavia d’un lusso complicato e fiabesco se si ascol
tano le minute relazioni lasciate dai cronisti del
tempo. Il Castiglione, per esempio, nell’elogiare il
tempio dell’Èrcole Alpino e Gallico da Amedeo Ca
stellamonte fabbricato in piazza Castello per la
memorabile festa allegorica immaginata dal conte
Filippo d ’Aglié col titolo:
Gii Ercoli domatori dei
mostri et Amor domatore degli Ercoli
(2), scriveva:
«L ’alpina macchina sì bene disegnò, eresse e rap
presentò con naturalezza, che dubitarono gli occhi
tra il finto e il vero ■.
Oltreché nell’architettura civile, anche Amedeo
si distinse assai in quella militare. A lui passarono
le cariche già tenute dal padre. Fu, a sua volta,
sovramtendente deOe fabbriche e fortificazioni, uf
ficio conferitogli con patenti del 2 aprile 1650, finché,
soppresso quel Consiglio, non fu nominato luogote
nente generale deO’Artiglieria.
33


















