
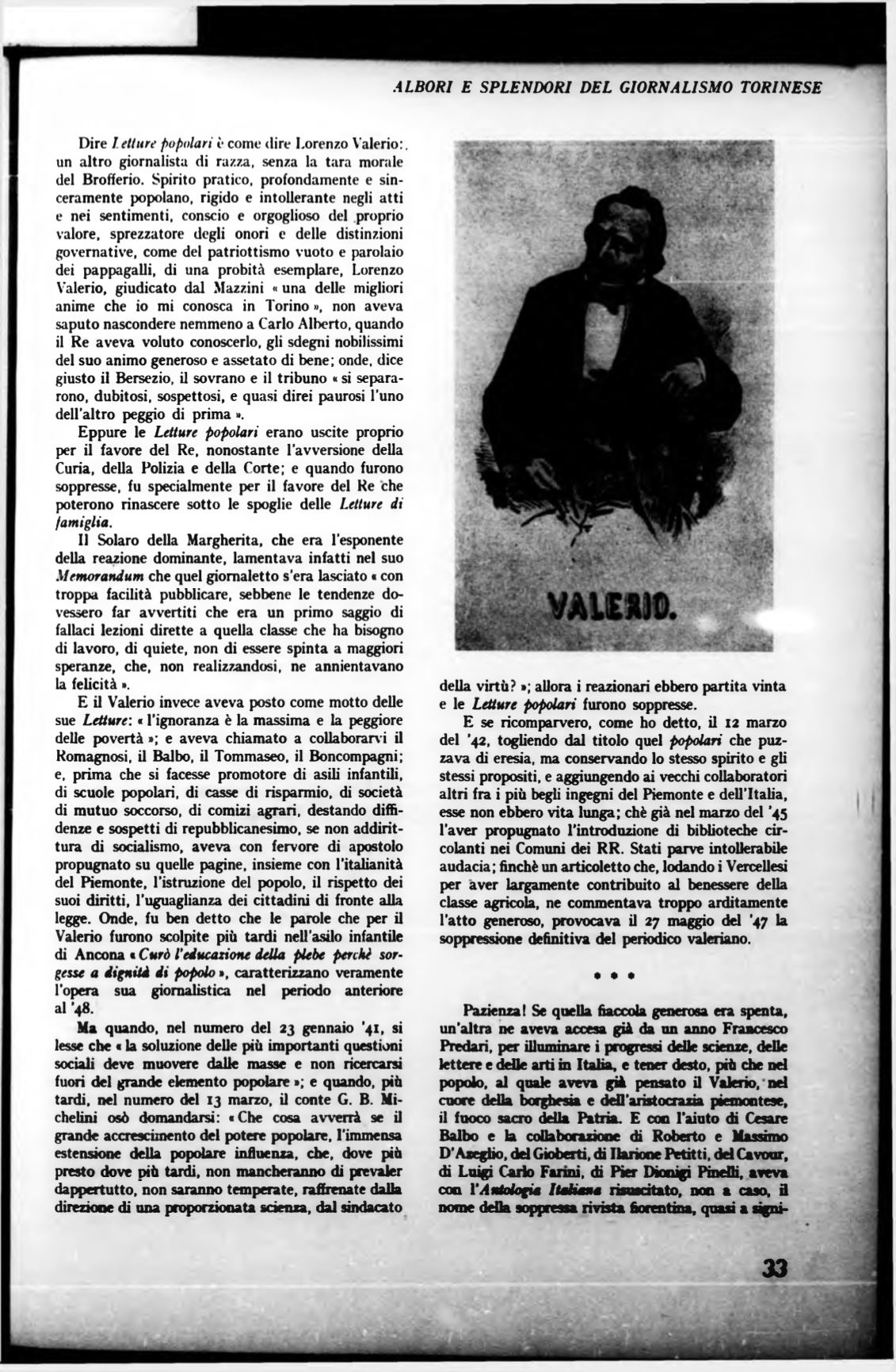
A L B O R I E S P L E N D O R I D E L G IO R N A L I S M O T O R IN E S E
Dire
letture popolari
è come dire Lorenzo Valerio:,
un altro giornalista di razza, senza la tara morale
del Brofferio. Spirito pratico, profondamente e sin
ceramente popolano, rigido e intollerante negli atti
e nei sentimenti, conscio e orgoglioso del proprio
valore, sprezzatore degli onori e delle distinzioni
governative, come del patriottismo vuoto e parolaio
dei pappagalli, di una probità esemplare, Lorenzo
Valerio, giudicato dal Mazzini «una delle migliori
anime che io mi conosca in Torino », non aveva
saputo nascondere nemmeno a Carlo Alberto, quando
il Re aveva voluto conoscerlo, gli sdegni nobilissimi
del suo animo generoso e assetato di bene; onde, dice
giusto il Bersezio, il sovrano e il tribuno «si separa
rono, dubitosi, sospettosi, e quasi direi paurosi l’uno
dell’altro peggio di prima ».
Eppure le
Letture popolari
erano uscite proprio
per il favore del Re, nonostante l ’avversione della
Curia, della Polizia e della Corte; e quando furono
soppresse, fu specialmente per il favore del Re che
poterono rinascere sotto le spoglie delle
Letture di
famiglia.
Il Solaro della Margherita, che era l ’esponente
della reazione dominante, lamentava infatti nel suo
Memorandum
che quel giornaletto s’era lasciato «con
troppa facilità pubblicare, sebbene le tendenze do
vessero far avvertiti che era un primo saggio di
fallaci lezioni dirette a quella classe che ha bisogno
di lavoro, di quiete, non di essere spinta a maggiori
speranze, che, non realizzandosi, ne annientavano
la felicità ».
E il Valerio invece aveva posto come motto delle
sue
Letture
: «l’ignoranza è la massima e la peggiore
delle povertà »; e aveva chiamato a collaborarvi il
Romagnosi, il Balbo, il Tommaseo, il Boncompagni;
e, prima che si facesse promotore di asili infantili,
di scuole popolari, di casse di risparmio, di società
di mutuo soccorso, di comizi agrari, destando diffi
denze e sospetti di repubblicanesimo, se non addirit
tura di socialismo, aveva con fervore di apostolo
propugnato su quelle pagine, insieme con l’italianità
del Piemonte, l ’istruzione del popolo, il rispetto dei
suoi diritti, l ’uguaglianza dei cittadini di fronte alla
legge. Onde, fu ben detto che le parole che per il
Valerio furono scolpite più tardi nell’asilo infantile
di Ancona «
Curò l’educazione della plebe perchè sor
gesse a dignità di popolo
», caratterizzano veramente
l’opera sua giornalistica nel perìodo anteriore
al '48.
Ma quando, nel numero del 23 gennaio '41, si
lesse che «la soluzione delle più importanti questioni
sociali deve muovere dalle masse e non ricercarsi
fuori del grande elemento popolare »; e quando, più
tardi, nel numero del 13 marzo, il conte G. B. Mi
chelini osò domandarsi: «Che cosa avverrà se il
grande accrescimento del potere popolare, l ’immensa
estensione della popolare influenza, che, dove più
presto dove più tardi, non mancheranno di prevaler
dappertutto, non saranno temperate, raffrenate dalla
direzione di una proporzionata scienza, dal sindacato
della virtù? »; allora i reazionari ebbero partita vinta
e le
Letture popolari
furono soppresse.
E se ricomparvero, come ho detto, il 12 marzo
del '42, togliendo dal titolo quel
popolari
che puz
zava di eresia, ma conservando lo stesso spirito e gli
stessi propositi, e aggiungendo ai vecchi collaboratori
altri fra i più begli ingegni del Piemonte e dell’Italia,
esse non ebbero vita lunga; chè già nel marzo del '45
l’aver propugnato l ’introduzione di biblioteche cir
colanti nei Comuni dei
RR.
Stati parve intollerabile
audacia; finché un articoletto che, lodando i Vercellesi
per aver largamente contribuito al benessere della
classe agrìcola, ne commentava troppo arditamente
l ’atto generoso, provocava il 27 maggio del '47 la
soppressione definitiva del periodico valeriano.
• * •
Pazienza! Se quella fiaccola generosa era spenta,
un’altra ne aveva accesa già da un anno Francesco
Predali, per illuminare i progressi delle scienze, delle
lettere e delle arti in Italia, e tener desto, più che nel
popolo, al quale aveva già pensato il Valerio, nel
cuore della borghesia e dell’aristocrazia piemontese,
il fuoco sacro della Patria. E con l’aiuto di Cesare
Balbo e la collaborazione di Roberto e Massimo
D’Azeglio, del Gioberti, di Ilarione Petitti, dd Cavour,
di Lnigi Cario Farmi, di Pier Dionigi PineUi, aveva
con
VAntologia Italiana
risuscitato, non a caso, il
nome della soppressa rivista fiorentina, quasi a signi-
33


















