
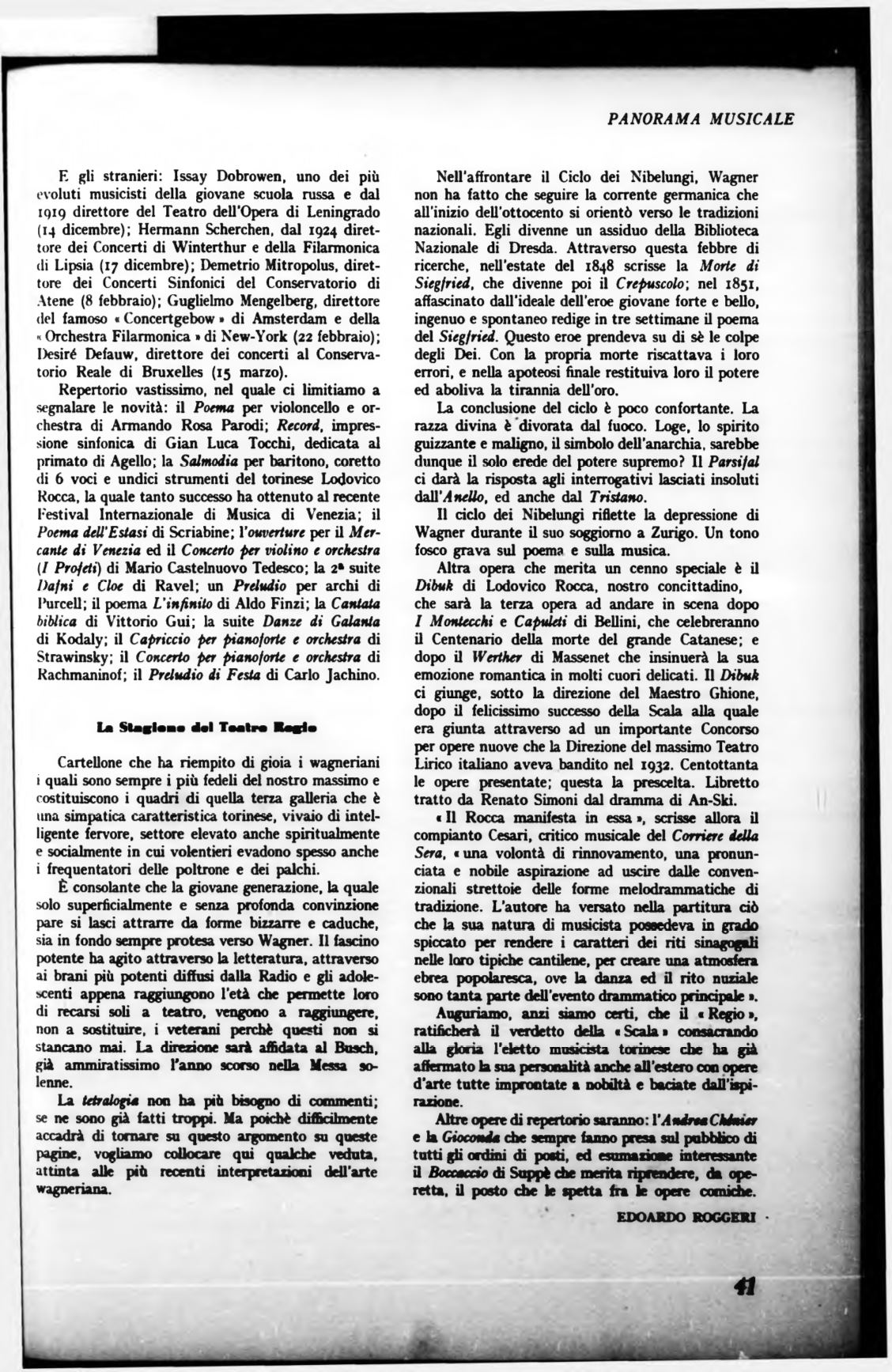
PANORAMA MUSICALE
E gli stranieri: Issay Dobrowen, uno dei più
evoluti musicisti della giovane scuola russa e dal
IQ19 direttore del Teatro dell’Opera di Leningrado
(14 dicembre); Hermann Scherchen, dal 1924 diret
tore dei Concerti di Winterthur e della Filarmonica
di Lipsia (17 dicembre); Demetrio Mitropolus, diret
tore dei Concerti Sinfonici del Conservatorio di
Atene (8 febbraio); Guglielmo Mengelberg, direttore
del famoso «Concertgebow » di Amsterdam e della
«Orchestra Filarmonica »di New-York (22 febbraio);
Desiré Defauw, direttore dei concerti al Conserva-
torio Reale di Bruxelles (15 marzo).
Repertorio vastissimo, nel quale ci limitiamo a
segnalare le novità: il
Poema
per violoncello e or
chestra di Armando Rosa Parodi;
Record,
impres
sione sinfonica di Gian Luca Tocchi, dedicata al
primato di Agello; la
Salmodia
per barìtono, coretto
di 6 voci e undici strumenti del torinese Lodovico
Rocca, la quale tanto successo ha ottenuto al recente
Festival Intemazionale di Musica di Venezia; il
Poema dell’Estasi
di Scriabine;
l’ouverture
per il
Mer
cante di Venezia
ed il
Concerto per violino e orchestra
(/
Profeti)
di Mario Castelnuovo Tedesco; la 2* suite
Dafni e Cloe
di Ravel; un
Preludio
per archi di
l'urcell; il poema
L'infinito
di Aldo Finzi; la
Cantata
biblica
di Vittorio Gui; la suite
Danze di Galanta
di Kodaly; il
Capriccio per pianoforte e orchestra
di
Strawinsky; il
Concerto per pianoforte e orchestra
di
Rachmaninof ; il
Preludio di Festa
di Carlo Jachino.
La S tag ione del Teatro Regio
Cartellone che ha riempito di gioia i wagneriani
i quali sono sempre i più fedeli del nostro massimo e
costituiscono i quadri di quella terza gallerìa che è
una simpatica caratteristica torinese, vivaio di intel
ligente fervore, settore elevato anche spiritualmente
e socialmente in cui volentieri evadono spesso anche
i frequentatori delle poltrone e dei palchi.
È consolante che la giovane generazione, la quale
solo superficialmente e senza profonda convinzione
pare si lasci attrarre da forme bizzarre e caduche,
sia in fondo sempre protesa verso Wagner. Il fascino
potente ha agito attraverso la letteratura, attraverso
ai brani più potenti diffusi dalla Radio e gli adole
scenti appena raggiungono l ’età che permette loro
di recarsi soli a teatro, vengono a raggiungere,
non a sostituire, i veterani perchè questi non si
stancano mai. La direzione sarà affidata al Busch,
già ammiratissimo l'anno scorso nella Messa so
lenne.
La
tetralogia
non ha più bisogno di commenti;
se ne sono già fatti troppi. Ma poiché difficilmente
accadrà di tornare su questo argomento su queste
pagine, vogliamo collocare qui qualche veduta,
attinta alle più recenti interpretazioni dell’arte
wagneriana.
Nell’affrontare il Ciclo dei Nibelungi, Wagner
non ha fatto che seguire la corrente germanica che
all’inizio dell’ottocento si orientò verso le tradizioni
nazionali. Egli divenne un assiduo della Biblioteca
Nazionale di Dresda. Attraverso questa febbre di
ricerche, nell’estate del 1848 scrisse la
Morte di
Siegfried,
che divenne poi il
Crepuscolo-,
nel 1851,
affascinato dall’ideale dell’eroe giovane forte e bello,
ingenuo e spontaneo redige in tre settimane il poema
del
Siegfried.
Questo eroe prendeva su di sè le colpe
degli Dei. Con la propria morte riscattava i loro
errori, e nella apoteosi finale restituiva loro il potere
ed aboliva la tirannia dell’oro.
La conclusione del ciclo è poco confortante. La
razza divina è divorata dal fuoco. Loge, lo spirito
guizzante e maligno, il simbolo dell’anarchia, sarebbe
dunque il solo erede del potere supremo? Il
Parsifal
ci darà la risposta agli interrogativi lasciati insoluti
dall’Amilo,
ed anche dal
Tristano.
Il
ciclo dei Nibelungi riflette la depressione di
Wagner durante il suo soggiorno a Zurìgo. Un tono
fosco grava sul poema e sulla musica.
Altra opera che merita un cenno speciale è il
Dibuk
di Lodovico Rocca, nostro concittadino,
che sarà la terza opera ad andare in scena dopo
I MonUcchi
e
Caputeti
di Bellini, che celebreranno
il Centenario della morte del grande Catanese; e
dopo il
Werther
di Massenet che insinuerà la sua
emozione romantica in molti cuori delicati. Il
Dibuk
ci giunge, sotto la direzione del Maestro Ghione,
dopo il felicissimo successo della Scala alla quale
era giunta attraverso ad un importante Concorso
per opere nuove che la Direzione del massimo Teatro
Lirico italiano aveva bandito nel 1932. Centottanta
le opere presentate; questa la prescelta. Libretto
tratto da Renato Simoni dal dramma di An-Ski.
«Il Rocca manifesta in essa », scrisse allora il
compianto Cesari, crìtico musicale del
Corriere della
Sera,
«una volontà di rinnovamento, una pronun
ciata e nobile aspirazione ad uscire dalle conven
zionali strettoie delle forme melodrammatiche di
tradizione. L ’autore ha versato nella partitura ciò
che la sua natura di musicista possedeva in grado
spiccato per rendere i caratteri dei riti sinagogali
nelle loro tipiche cantilene, per creare una atmosfera
ebrea popolaresca, ove la danza ed il rito nuziale
sono tanta parte dell’evento drammatico principale ».
Auguriamo, anzi siamo certi, che il «Regio»,
ratificherà il verdetto della «Scala» consacrando
alla gloria l’eletto musicista torinese che ha già
affermato la sua personalità anche all’estero con opere
d'arte tutte improntate a nobiltà e badate dall’ispi
razione.
Altre opere di repertorio saranno:
VAndremClUmer
e la
Gioconda
che sempre fanno presa sul pubblico di
tutti gli ordini di posti, ed esumazione interessante
il
Boccaccio
di Suppè che merita riprendere, da ope
retta. il posto die le spetta fra le opere comiche.
EDOARDO ROGGERI •
41


















