
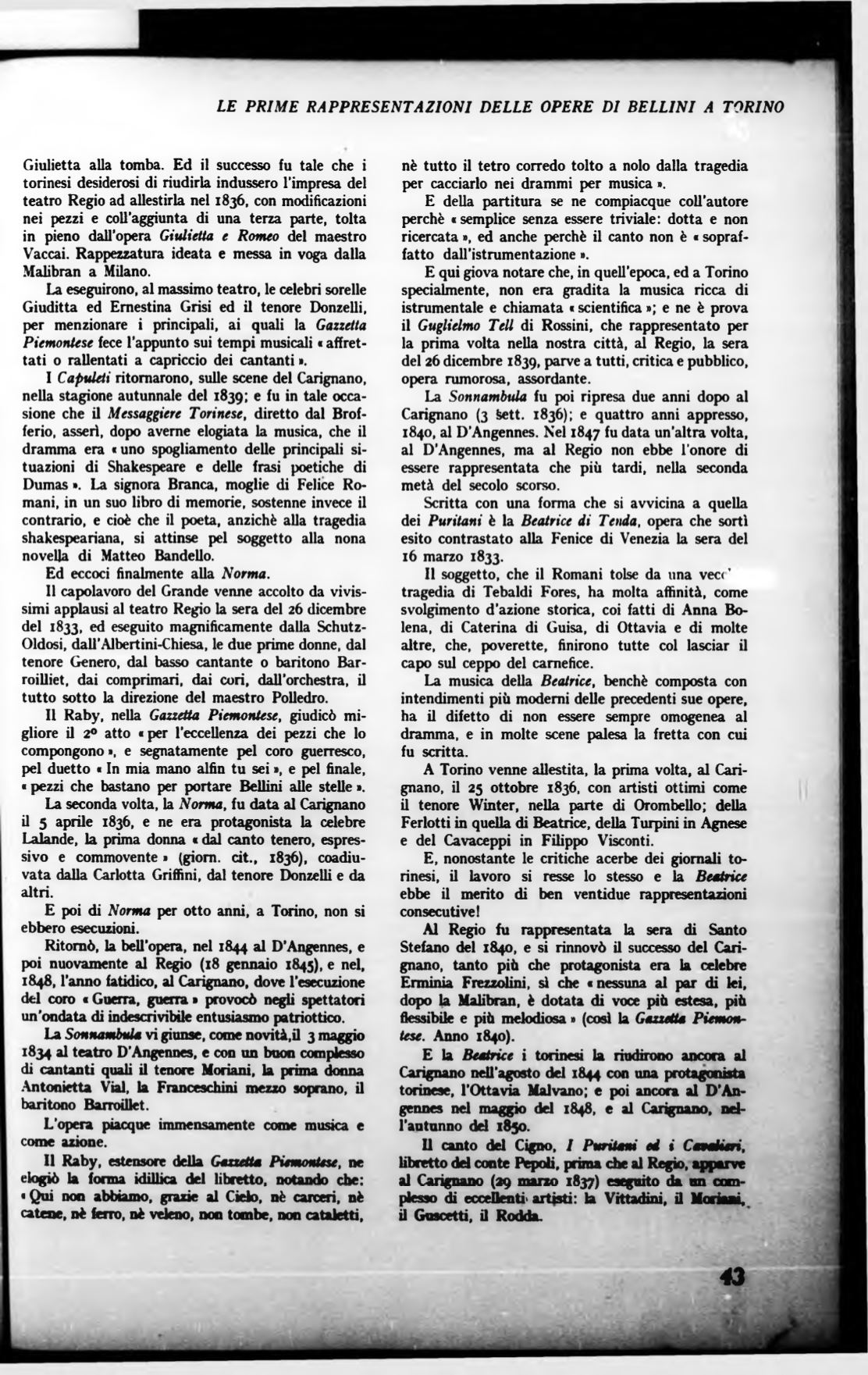
LE PRIME RAPPRESENTAZIONI DELLE OPERE DI BELL IN I A TORINO
Giulietta alla tomba. Ed il successo fu tale che i
torinesi desiderosi di riudirla indussero l’impresa del
teatro Regio ad allestirla nel 1836, con modificazioni
nei pezzi e coll’aggiunta di una terza parte, tolta
in pieno dall’opera
Giulietta e Romeo
del maestro
Vaccai. Rappezzatura ideata e messa in voga dalla
Malibran a Milano.
La eseguirono, al massimo teatro, le celebri sorelle
Giuditta ed Emestina Grisi ed il tenore Donzelli,
per menzionare i principali, ai quali la
Gazzetta
Piemontese
fece l’appunto sui tempi musicali «affret
tati o rallentati a capriccio dei cantanti ».
I
Caputeti
ritornarono, sulle scene del Carignano,
nella stagione autunnale del 1839; e fu in tale occa
sione che il
Messaggiere Torinese,
diretto dal Brof
ferio, asserì, dopo averne elogiata la musica, che il
dramma era «uno spogliamento delle principali si
tuazioni di Shakespeare e delle frasi poetiche di
Dumas ». La signora Branca, moglie di Felice Ro
mani, in un suo libro di memorie, sostenne invece il
contrario, e cioè che il poeta, anziché alla tragedia
shakespeariana, si attinse pel soggetto alla nona
novella di Matteo Bandello.
Ed eccoci finalmente alla
Norma.
II capolavoro del Grande venne accolto da vivis
simi applausi al teatro Regio la sera del 26 dicembre
del 1833, ed eseguito magnificamente dalla Schutz-
Oldosi, dall’Albertini-Chiesa, le due prime donne, dal
tenore Genero, dal basso cantante o baritono Bar-
roilliet, dai comprimari, dai cori, dall'orchestra, il
tutto sotto la direzione del maestro Poliedro.
Il
Raby, nella
Gazzetta Piemontese,
giudicò mi
gliore il 2° atto «per l’eccellenza dei pezzi che lo
compongono», e segnatamente pel coro guerresco,
pel duetto «In mia mano alfin tu sei », e pel finale,
«pezzi che bastano per portare Bellini alle stelle ».
La seconda volta, la
Norma,
fu data al Carignano
il 5 aprile 1836, e ne era protagonista la celebre
Lalande, la prima donna «dal canto tenero, espres
sivo e commovente » (giom. cit., 1836), coadiu
vata dalla Carlotta Griffini, dal tenore Donzelli e da
altri.
E poi di
Norma
per otto anni, a Torino, non si
ebbero esecuzioni.
Ritornò, la bell’opera, nel 1844 al D’Angennes, e
poi nuovamente al Regio (18 gennaio 1845), e nel,
1848, l’anno fatidico, al Carignano, dove l ’esecuzione
del coro «Guerra, guerra» provocò negli spettatori
un’ondata di indescrivibile entusiasmo patriottico.
La
Sonnambula
vi giunse, come novità,il 3 maggio
1834 al teatro D’Angennes, e con un buon complesso
di cantanti quali il tenore Moriani, la prima donna
Antonietta Vial, la Franceschini mezzo soprano, il
baritono Barroillet.
L ’opera piacque immensamente enne musica e
come azione.
Il
Raby, estensore della
Gazzetta Piemontese,
ne
elogiò la forma idillica del libretto, notando che:
«Qui non abbiamo, grazie al Cielo, nè carceri, nè
catene, nè ferro, nè veleno, non tombe, non cataletti,
nè tutto il tetro corredo tolto a nolo dalla tragedia
per cacciarlo nei drammi per musica ».
E della partitura se ne compiacque coll’autore
perchè «semplice senza essere triviale: dotta e non
ricercata », ed anche perchè il canto non è «sopraf
fatto dall’istrumentazione ».
E qui giova notare che, in quell’epoca, ed a Torino
specialmente, non era gradita la musica ricca di
istrumentale e chiamata «scientifica »; e ne è prova
il
Guglielmo Teli
di Rossini, che rappresentato per
la prima volta nella nostra città, al Regio, la sera
del 26 dicembre 1839, parve a tutti, critica e pubblico,
opera rumorosa, assordante.
La
Sonnambula
fu poi ripresa due anni dopo al
Carignano (3 fcett. 1836); e quattro anni appresso,
1840, al D’Angennes. Nel 1847 fu data un’altra volta,
al D’Angennes, ma al Regio non ebbe l ’onore di
essere rappresentata che più tardi, nella seconda
metà del secolo scorso.
Scritta con una forma che si avvicina a quella
dei
Puritani
è la
Beatrice di Tenda,
opera che sortì
esito contrastato alla Fenice di Venezia la sera del
16 marzo 1833.
Il
soggetto, che il Romani tolse da una vec< ’
tragedia di Tebaldi Fores, ha molta affinità, come
svolgimento d ’azione storica, coi fatti di Anna Bo
lena, di Caterina di Guisa, di Ottavia e di molte
altre, che, poverette, finirono tutte col lasciar il
capo sul ceppo del carnefice.
La musica della
Beatrice,
benché composta con
intendimenti più moderni delle precedenti sue opere,
ha il difetto di non essere sempre omogenea al
dramma, e in molte scene palesa la fretta con cui
fu scritta.
A Torino venne allestita, la prima volta, al Cari
gnano, il 25 ottobre 1836, con artisti ottimi come
il tenore Winter, nella parte di Orombello; della
Ferlotti in quella di Beatrice, della Turpini in Agnese
e del Cavaceppi in Filippo Visconti.
E, nonostante le critiche acerbe dei giornali to
rinesi, il lavoro si resse lo stesso e la
Beatrice
ebbe il merito di ben ventidue rappresentazioni
consecutive!
Al Regio fu rappresentata la sera di Santo
Stefano del 1840, e si rinnovò il successo del Cari
gnano, tanto più che protagonista era la celebre
Erminia Frezzolini, sì che «nessuna al par di lei,
dopo la Malibran, è dotata di voce più estesa, più
flessibile e più melodiosa » (cosi la
Gazzetta Piemon
tese.
Anno 1840).
E la
Beatrice
i torinesi la riudirono ancora al
Carignano nell’agosto del
1844
con una protagonista
torinese, l’Ottavia Malvano; e poi ancora al D’An
gennes nel maggio del
1848,
e al Carignano, nel
l’autunno del 1850.
Il
canto del Cigno,
I
Puritani
ed
i Cavalieri,
libretto dd conte Pepali, prima che al Regio,
apparve
al Carignano (29 marzo 1837) eseguito
da
un
com
plesso di eccellenti' artisti: la Vittadini, il
Mariani,
il Guscetti, il Rorida.
4 3


















