
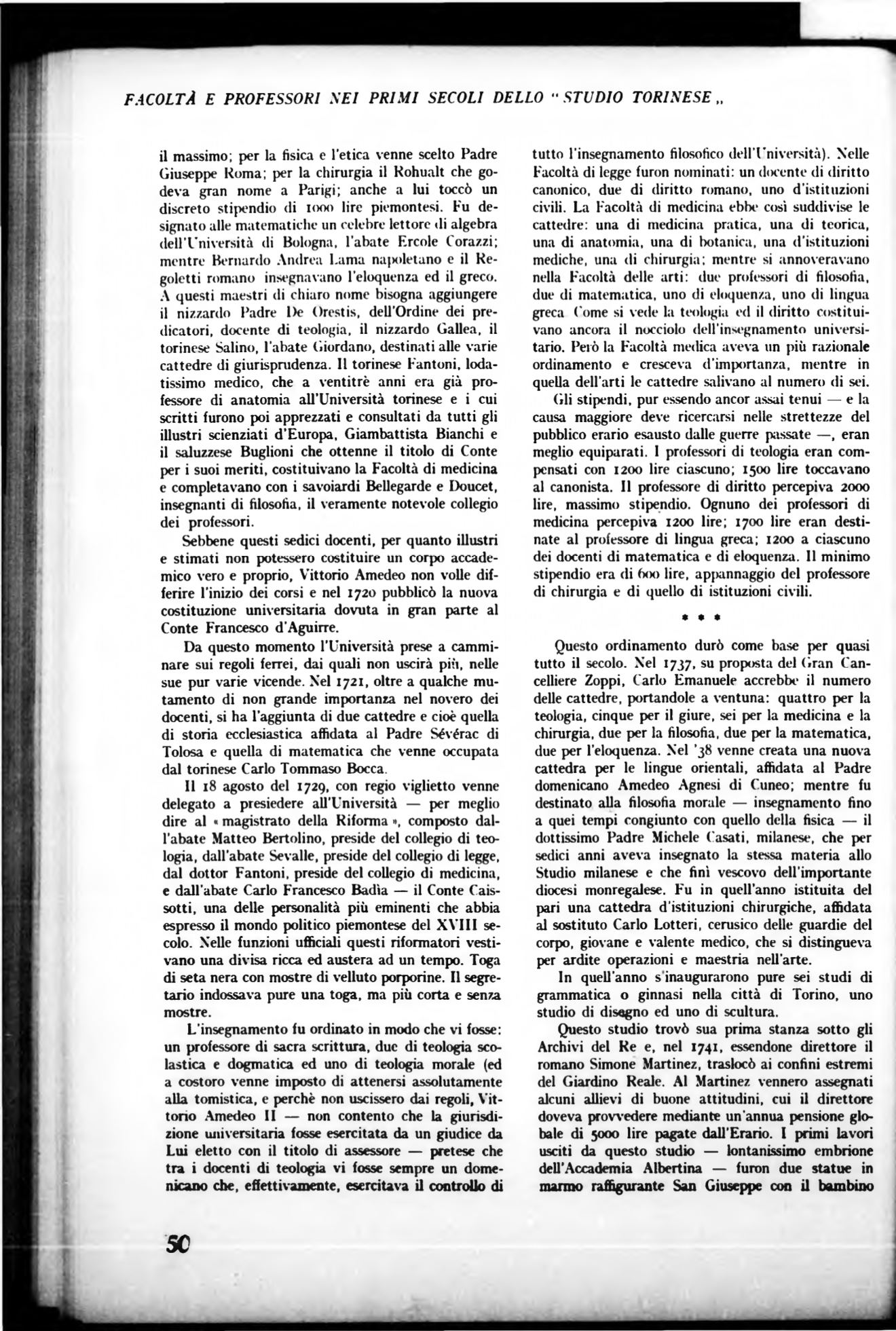
FACOLTÀ E PROFESSORI NEI PR IMI SECOLI DELLO “ STUDIO TORINESE
„
il massimo; per la fisica e l’etica venne scelto Padre
Giuseppe Roma; per la chirurgia il Rohualt che go
deva gran nome a Parigi; anche a lui toccò un
discreto stipendio di iooo lire piemontesi. Fu de
signato alle matematiche un celebre lettore «li algebra
dell’Università di Bologna, l'abate Ercole Corazzi;
mentre Bernardo Andrea Lama napoletano e il Re
goletti romano insegnavano l’eloquenza ed il greco.
A questi maestri di chiaro nome bisogna aggiungere
il nizzardo Padre l)e Orestis, dell’Ordine dei pre
dicatori, docente di teologia, il nizzardo Gallea, il
torinese Salino, l'abate Giordano, destinati alle varie
cattedre di giurisprudenza. Il torinese Fantoni, loda
tissimo medico, che a ventitré anni era già pro
fessore di anatomia all’Università torinese e i cui
scritti furono poi apprezzati e consultati da tutti gli
illustri scienziati d ’Europa, Giambattista Bianchi e
il saluzzese Buglioni che ottenne il titolo di Conte
per i suoi meriti, costituivano la Facoltà di medicina
e completavano con i savoiardi Bellegarde e Doucet,
insegnanti di filosofia, il veramente notevole collegio
dei professori.
Sebbene questi sedici docenti, per quanto illustri
e stimati non potessero costituire un corpo accade
mico vero e proprio, Vittorio Amedeo non volle dif
ferire l’inizio dei corsi e nel 1720 pubblicò la nuova
costituzione universitaria dovuta in gran parte al
Conte Francesco d ’Aguirre.
Da questo momento l’Università prese a cammi
nare sui regoli ferrei, dai quali non uscirà più, nelle
sue pur varie vicende. Nel 17 2 1 , oltre a qualche mu
tamento di non grande importanza nel novero dei
docenti, si ha l’aggiunta di due cattedre e cioè quella
di storia ecclesiastica affidata al Padre Sévérac di
Tolosa e quella di matematica che venne occupata
dal torinese Carlo Tommaso Bocca.
Il 18 agosto del 1729, con regio viglietto venne
delegato a presiedere all’Università — per meglio
dire al «magistrato della Riforma », composto dal
l’abate Matteo Bertolino, preside del collegio di teo
logia, dall’abate Sevalle, preside del collegio di legge,
dal dottor Fantoni, preside del collegio di medicina,
e dall’abate Carlo Francesco Badìa — il Conte Cais-
sotti, una delle personalità più eminenti che abbia
espresso il mondo politico piemontese del X V I I I se
colo. Nelle funzioni ufficiali questi riformatori vesti
vano una divisa ricca ed austera ad un tempo. Toga
di seta nera con mostre di velluto porporine. Il segre
tario indossava pure una toga, ma più corta e senza
mostre.
L ’insegnamento fu ordinato in modo che vi fosse:
un professore di sacra scrittura, due di teologia sco
lastica e dogmatica ed uno di teologia morale (ed
a costoro venne imposto di attenersi assolutamente
alla tomistica, e perchè non uscissero dai regoli, Vit
torio Amedeo II — non contento che la giurisdi
zione universitaria fosse esercitata da un giudice da
Lui eletto con il titolo di assessore — pretese che
tra i docenti di teologia vi fosse sempre un dome
nicano che, effettivamente, esercitava il controllo di
tutto l'insegnamento filosofico dell’Università). Nelle
Facoltà di legge furon nominati: un docente di diritto
canonico, due di diritto romano, uno d ’istituzioni
civili. La Facoltà di medicina ebbe così suddivise le
cattedre: una di medicina pratica, una di teorica,
una di anatomia, una di botanica, una d ’istituzioni
mediche, una di chirurgia; mentre si annoveravano
nella Facoltà delle arti: due professori di filosofìa,
due di matematica, uno di eloquenza, uno di lingua
greca Come si vede la teologia ed il diritto costitui
vano ancora il nocciolo dell'insegnamento universi
tario. Però la Facoltà medica aveva un più razionale
ordinamento e cresceva d ’importanza, mentre in
quella dell'arti le cattedre salivano al numero di sei.
(ìli stipendi, pur essendo ancor assai tenui — e la
causa maggiore deve ricercarsi nelle strettezze del
pubblico erario esausto dalle guerre passate — , eran
meglio equiparati. I professori di teologia eran com
pensati con 1200 lire ciascuno; 1500 lire toccavano
al canonista. Il professore di diritto percepiva 2000
lire, massimo stipendio. Ognuno dei professori di
medicina percepiva 1200 lire; 1700 lire eran desti
nate al professore di lingua greca; 1200 a ciascuno
dei docenti di matematica e di eloquenza. Il minimo
stipendio era di 600 lire, appannaggio del professore
di chirurgia e di quello di istituzioni civili.
* * *
Questo ordinamento durò come base per quasi
tutto il secolo. Nel 1737 , su proposta del Gran Can
celliere Zoppi, Carlo Emanuele accrebbe il numero
delle cattedre, portandole a ventuna: quattro per la
teologia, cinque per il giure, sei per la medicina e la
chirurgia, due per la filosofia, due per la matematica,
due per l'eloquenza. Nel ‘38 venne creata una nuova
cattedra per le lingue orientali, affidata al Padre
domenicano Amedeo Agnesi di Cuneo; mentre fu
destinato alla filosofia morale — insegnamento fino
a quei tempi congiunto con quello della fisica — il
dottissimo Padre Michele Casati, milanese, che per
sedici anni aveva insegnato la stessa materia allo
Studio milanese e che finì vescovo dell’importante
diocesi monregalese. Fu in quell’anno istituita del
pari una cattedra d'istituzioni chirurgiche, affidata
al sostituto Carlo Lotteri, cerusico delle guardie del
corpo, giovane e valente medico, che si distingueva
per ardite operazioni e maestria nell’arte.
In quell’anno s inaugurarono pure sei studi di
grammatica o ginnasi nella città di Torino, uno
studio di disegno ed uno di scultura.
Questo studio trovò sua prima stanza sotto gli
Archivi del Re e, nel 174 1, essendone direttore il
romano Simone Martinez, traslocò ai confini estremi
del Giardino Reale. Al Martinez vennero assegnati
alcuni allievi di buone attitudini, cui il direttore
doveva provvedere mediante un'annua pensione glo
bale di 5000 lire pagate dall’Erario. I primi lavori
usciti da questo studio — lontanissimo embrione
dell’Accademia Albertina — furon due statue in
marmo raffigurante San Giuseppe con il bambino
50


















