
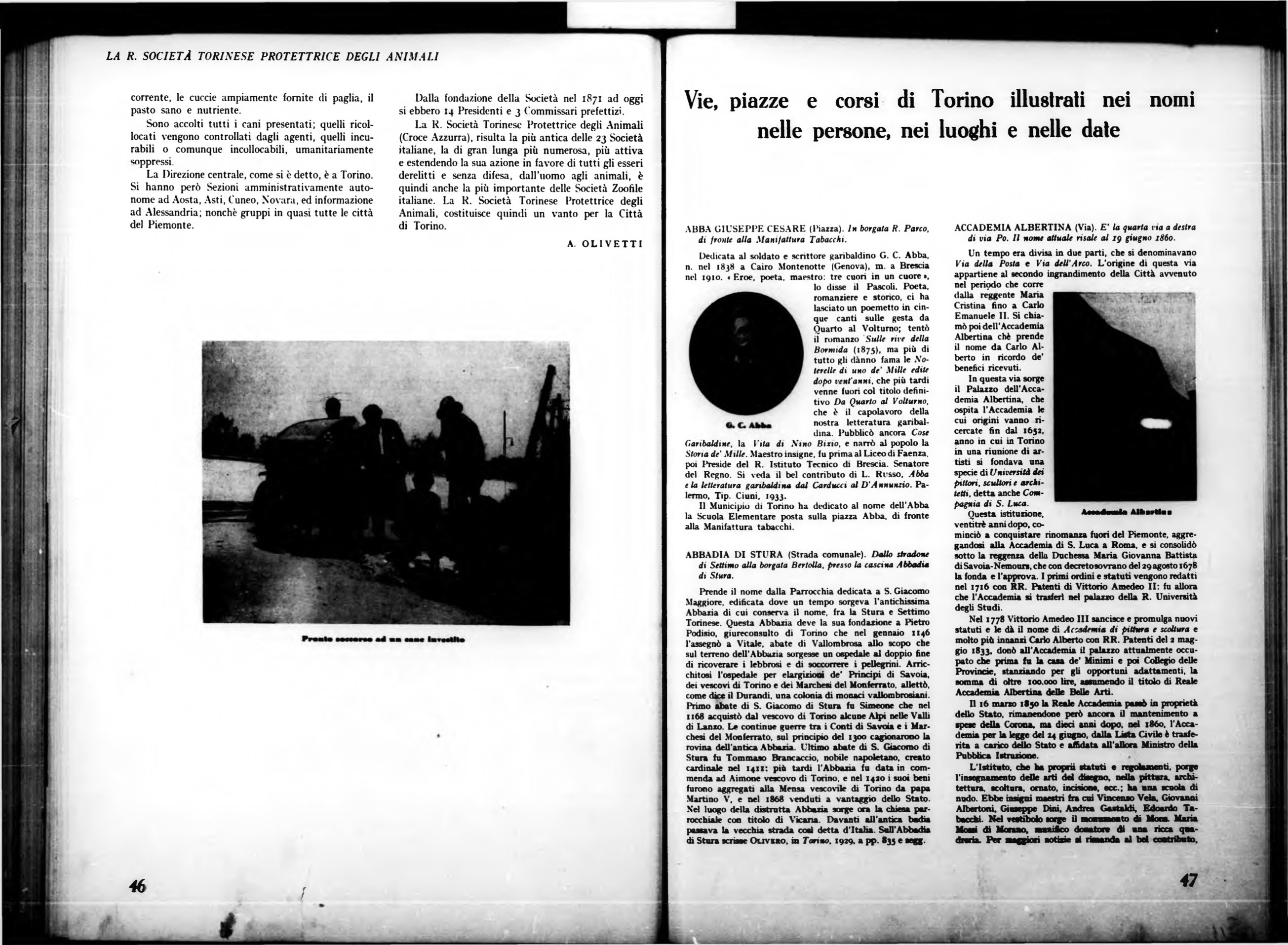
LA R. SOCIETÀ TORINESE PROTETTRICE DEGLI ANIMALI
Vie, piazze e corsi di Torino illustrali nei nomi
nelle persone, nei luoghi e nelle date
corrente, le cuccie ampiamente fornite di paglia, il
pasto sano e nutriente.
Sono accolti tutti i cani presentati; quelli ricol
locati vengono controllati dagli agenti, quelli incu
rabili o comunque incollocabili, umanitariamente
soppressi.
La Direzione centrale, come si è detto, è a Torino.
Si hanno però Sezioni amministrativamente auto
nome ad Aosta, Asti, Cuneo, Novara, ed informazione
ad Alessandria; nonché gruppi in quasi tutte le città
del Piemonte.
Dalla fondazione della Società nel 1871 ad oggi
si ebbero 14 Presidenti e 3 Commissari prefettizi.
La K. Società Torinese Protettrice degli Animali
(Croce Azzurra), risulta la più antica delle 23 Società
italiane, la di gran lunga più numerosa, più a ttiva
e estendendo la sua azione in favore di tutti gli esseri
derelitti e senza difesa, dall’uomo agli animali,
è
quindi anche la più importante delle Società Zoofile
italiane. La R. Società Torinese Protettrice degli
Animali, costituisce quindi un vanto per la C ittà
di Torino.
A. O L I V E T T I
ABBA GIUSEPPE CESARE (Piazza).
In borgata R. Parco,
di fronte alla Manifattura Tabacchi.
Dedicata al soldato e scrittore garibaldino G. C. Abba,
n. nel 1838 a Cairo Montenotte (Genova), m. a Brescia
nel 1910. «Eroe, poeta, maestro: tre cuori in un cuore »,
10 disse il Pascoli. Poeta,
romanziere e storico, ci ha
lasciato un poemetto in cin
que canti sulle gesta da
Quarto al Volturno; tentò
11 romanzo
Sulle rive della
tìormida
(1875), ma più di
tutto gli danno fama le
Xo-
terelle di uno de' Mille edite
dopo vent'anni,
che più tardi
venne fuori col titolo defini
tivo
Da Quarto al Volturno,
che
è
il capolavoro della
nostra letteratura garibal
dina. Pubblicò ancora
Cose
Garibaldine,
la
Vita di S'ino Hixio,
e narrò al popolo la
Storia de' Mille.
Maestro insigne, fu prima al Liceo di Faenza,
poi Preside del R. Istituto Tecnico di Brescia. Senatore
del Regno. Si veda il bel contributo di L. Rrsso,
Abba
e la letteratura garibaldina dal Carducci al D'Annunzio.
Pa
lermo, Tip. Ciuni, 1933.
Il Municipio di Torino ha dedicato al nome dell'Abba
la Scuola Elementare posta sulla piazza Abba, di fronte
alla Manifattura tabacchi.
ABBADIA DI STURA (Strada comunale).
Dallo stradone
di Settimo alla borgata Bertolla, presso la cascina Abbadia
di Stura.
Prende il nome dalla Parrocchia dedicata a S. Giacomo
Maggiore, edificata dove un tempo sorgeva l’antichissima
Abbazia di cui conserva il nome, fra la Stura e Settimo
Torinese. Questa Abbazia deve la sua fondazione a Pietro
Podisio, giureconsulto di Torino che nel gennaio 1146
l’assegnò a Vitale, abate di Vallombrosa allo scopo che
sul terreno dell’Abbazia sorgesse un ospedale al doppio fine
di ricoverare i lebbrosi e di soccorrere i pellegrini. Arric
chitosi l’ospedale per elargizioni de’ Principi di Savoia,
dei vescovi di Torino e dei Marchesi del Monferrato, allettò,
come dice il Durandi, una colonia di monaci vallombrosiani.
Primo abate di S. Giacomo di Stura fu Simeone che nel
1168 acquistò dal vescovo di Torino alcune Alpi nelle Valli
di Lanzo. Le continue guerre tra i Conti di Savoia e i Mar
chesi del Monferrato, sul principio del 1300 cagionarono la
rovina dell’antica Abbazia. Ultimo abate di S. Giacomo di
Stura fu Tommaso Brancaccio, nobile napoletano, creato
cardinale nel 1411: più tardi l’Abbazia fu data in com
menda ad Aimone vescovo di Torino, e nel 1420 i suoi beni
furono aggregati alla Mensa vescovile di Torino da papa
Martino V, e nel 1868 venduti a vantaggio dello Stato.
Nel luogo della distrutta Abbazia sorge ora la chiesa par
rocchiale con titolo di Vicaria. Davanti all’antica badia
passava la vecchia strada cosi detta d’Italia. Soli’Abbadia
di Stura scrisse
O u v e k o ,
in
Torino.
1929. a pp. 835 e segg.
ACCADEMIA ALBERTINA (Via).
E ' la quarta via a destra
di via Po. Il nome attuale risale al ig giugno 1860.
Un tempo era divisa in due parti, che si denominavano
Via della Posta
e
Via dell'Arco.
L'origine di questa via
appartiene al secondo ingrandimento della Città avvenuto
nel peripdo che corre
dalla reggente Maria
Cristina fino a Carlo
Emanuele II. Si chia
mò poi dell’Accademia
Albertina chè prende
il nome da Carlo Al
berto in ricordo de’
benefìci ricevuti.
In questa via sorge
il Palazzo dell'Acca-
demia Albertina, che
ospita l’Accademia le
cui origini vanno ri
cercate fin dal 1652,
anno in cui in Torino
in una riunione di ar
tisti si fondava una
specie di
Università dei
pittori, scultori e archi
tetti.
detta anche
Com
pagnia di S. Luca.
Questa istituzione,
4
«•■<■■!■A l l i v l l i i
ventitré anni dopo, co
minciò a conquistare rinomanza fuori del Piemonte, aggre
gandosi alla Accademia di S. Luca a Roma, e si consolidò
sotto la reggenza della Duchessa Maria Giovanna Battista
diSavoia-Nemours, che con decretosovrano del 29agosto 1678
la fonda e l’approva. I primi ordini e statuti vengono redatti
nel 1716 con RR. Patenti di Vittorio Amedeo II: fu allora
che l’Accademia si trasferì nel palazzo della R. Università
degli Studi.
Nel 1778 Vittorio Amedeo III sancisce e promulga nuovi
statuti e le dà il nome di
Accademia di pittura e scottura
e
molto più innanzi Carlo Alberto con RR . Patenti del 2 mag
gio 1833, donò all*Accademia il palazzo attualmente occu
pato che prima fu la casa de’ Minimi e poi Collegio delle
Provincie, stanziando per gli opportuni adattamenti, la
somma di oltre 100.000 lire, assumendo il titolo di Reale
Accademia Albertina delle Belle Arti.
Il 16 marzo 1850 la Reale Accademia passò in proprietà
dello Stato, rimanendone però ancora il mantenimento a
spese della Corona, ma dieci anni dopo, nel 1860, l’Acca
demia per la legge del 24 giugno, dalla Lista Civile è trasfe
rita a carico dello Stato e affidata all’allora Ministro della
Pubblica Istruzione.
L ’Istituto, che ha proprii statuti e regolamenti,
porge
l'insegnamento delle arti del disegno, nella pittura, archi
tettura, scoltura, ornato, incisione, ecc.; ha una scuola di
nudo. Ebbe insigni maestri Ira cui Vincenzo Vela, Giovanni
Albertoni. Giuseppe Dini, Andrea Gastaldi, Edoardo Ta
bacchi. Nel vestibolo sorge il mommento di Mona. Maria
Marni di Morano, munifico donatore di una ricca qna-
dmria. Per maggiori notizie ri rimanda al b d contributo.
46
r
!
47


















