
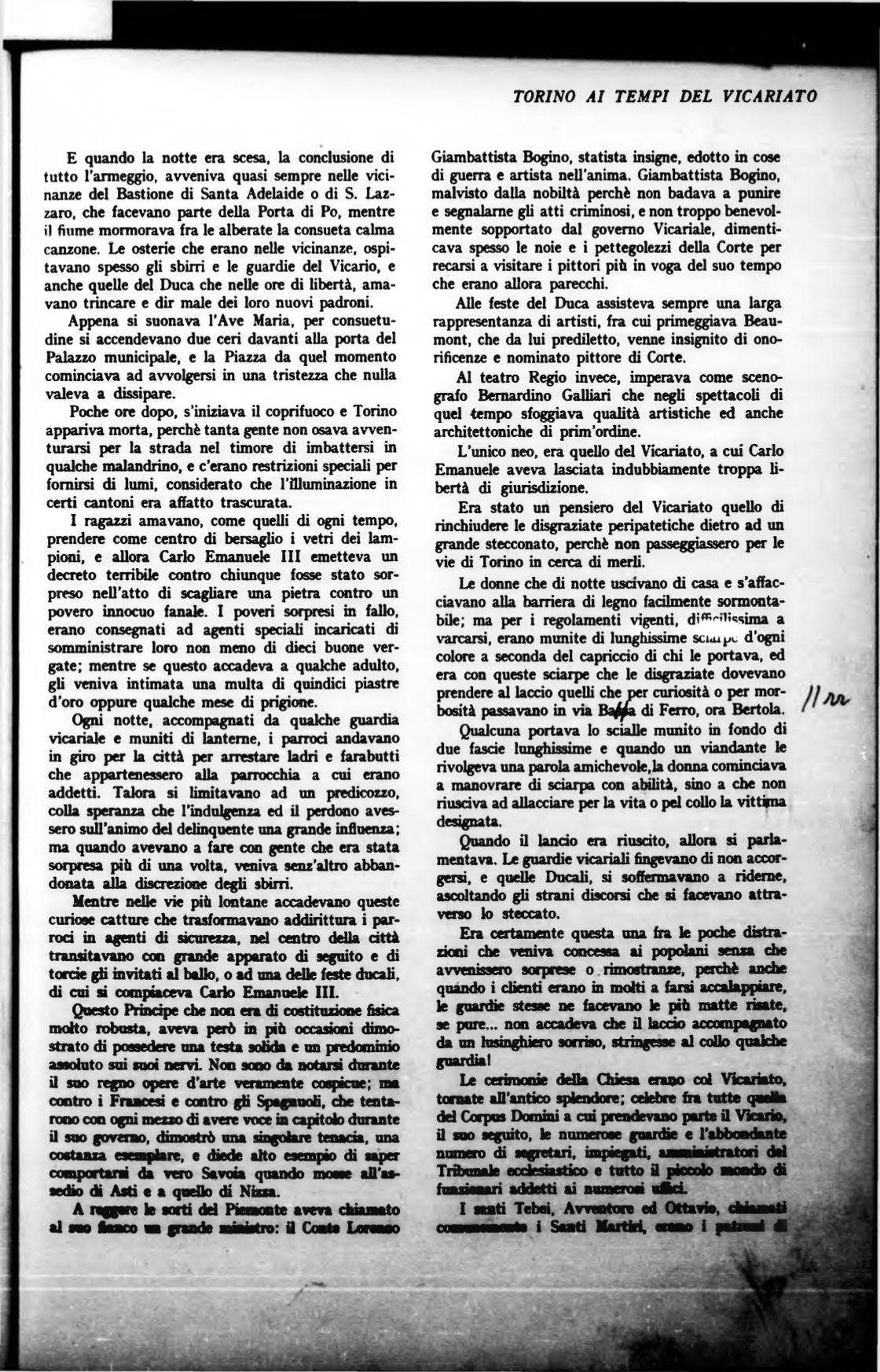
TORINO AI TEMPI DEL VICARIATO
E quando la notte era scesa, la conclusione di
tutto l’armeggio, avveniva quasi sempre nelle vici
nanze del Bastione di Santa Adelaide o di S. Laz
zaro, che facevano parte della Porta di Po, mentre
il
fiume mormorava fra le alberate la consueta calma
canzone. Le osterie che erano nelle vicinanze, ospi
tavano spesso gli sbirri e le guardie del
V icario,
e
anche quelle del Duca che nelle ore di libertà, ama
vano trincare e dir male dei loro nuovi padroni.
Appena si suonava l’Ave Maria, per consuetu
dine si accendevano due ceri davanti alla porta del
Palazzo municipale, e la Piazza da quel momento
cominciava ad avvolgersi in una tristezza che nulla
valeva a dissipare.
Poche ore dopo, s’iniziava il coprifuoco e Torino
appariva morta, perchè tanta gente non osava avven
turarsi per la strada nel timore di imbattersi in
qualche malandrino, e c'erano restrizioni speciali per
fornirsi di lumi, considerato che l’illuminazione in
certi cantoni era affatto trascurata.
I
ragazzi amavano, come quelli di ogni tempo,
prendere come centro di bersaglio i vetri dei lam
pioni, e allora Carlo Emanuele III emetteva un
decreto terrìbile contro chiunque fosse stato sor
preso nell’atto di scagliare una pietra contro un
povero innocuo fanale. I poveri sorpresi in fallo,
erano consegnati ad agenti speciali incaricati di
somministrare loro non meno di dieci buone ver
gate; mentre se questo accadeva a qualche adulto,
gli veniva intimata una multa di quindici piastre
d’oro oppure qualche mese di prigione.
Ogni notte, accompagnati da qualche guardia
vicariale e muniti di lanterne, i parroci andavano
in giro per la città per arrestare ladri e farabutti
che appartenessero alla parrocchia a cui erano
addetti. Talora si limitavano ad un predicozzo,
colla speranza che l’indulgenza ed il perdono aves
sero sull'animo del delinquente una grande influenza;
ma quando avevano a fare con gente che era stata
sorpresa più di una volta, veniva senz’altro abban
donata alla discrezione degli sbirri.
Mentre nelle vie più lontane accadevano queste
curiose catture che trasformavano addirittura i par
roci in agenti di sicurezza, nel centro della città
transitavano con grande apparato di seguito e di
torde gli invitati al ballo, o ad una delle feste ducali,
di cui si compiaceva Carlo Emanuele III.
Questo Principe che non era di costituzione fisica
motto robusta, aveva però in più occasioni dimo
strato di possedere una testa solida e un predominio
assoluto sui suoi nervi Non sono da notarsi durante
il suo regno opere d’arte veramente cospicue; ma
contro i Francesi e contro gii Spagnooli, che tenta
rono con ogni mezzo di avere voce in capitolo durante
il suo governo, dimostrò una singolare tenacia, una
costanza esemplare, e diede alto esempio di saper
comportarsi da vero Savoia quando mosse all’as
sedio di Asti e a quello di Nizza.
A raggerà le sorti dd Piemonte aveva chiamato
al suo fianco
v i
grande ministro: fl Conte Loranao
Giambattista Bogino, statista insigne, edotto in cose
di guerra e artista nell’anima. Giambattista Bogino,
malvisto dalla nobiltà perchè non badava a punire
e segnalarne gli atti criminosi, e non troppo benevol
mente sopportato dal governo Vicariale, dimenti
cava spesso le noie e i pettegolezzi della Corte per
recarsi a visitare i pittori più in voga del suo tempo
che erano allora parecchi.
Alle feste del Duca assisteva sempre una larga
rappresentanza di artisti, fra cui primeggiava Beau-
mont, che da lui prediletto, venne insignito di ono
rificenze e nominato pittore di Corte.
Al teatro Regio invece, imperava come sceno
grafo Bernardino Galliari che negli spettacoli di
quel tempo sfoggiava qualità artistiche ed anche
architettoniche di prim‘ordine.
L’unico neo, era quello del Vicariato, a cui Carlo
Emanuele aveva lasciata indubbiamente troppa li
bertà di giurisdizione.
Era stato un pensiero dd Vicariato quello di
rinchiudere le disgraziate peripatetiche dietro ad un
grande stecconato, perchè non passeggiassero per le
vie di Torino in cerca di merli.
Le donne che di notte usavano di casa e s’affac
ciavano alla barriera di legno facilmente sormonta
bile; ma per i regolamenti vigenti, d i ^ ’^sima a
varcarsi, erano munite di lunghissime sciai yc d’ogni
colore a seconda del capricdo di chi le portava, ed
era con queste sciarpe che le disgraziate dovevano
prendere al lacdo quelli che per curiosità o per mor
bosità passavano in via Bq/j^a di Ferro, ora Bertola.
Qualcuna portava lo scialle munito in fondo di
due fasde lunghissime e quando un viandante le
rivolgeva una parola amichevole,la donna cominciava
a manovrare di sciarpa con abilità, sino a che non
riusciva ad allacciare per la vita o pd collo la vittima
designata.
Quando il landò era riusdto, allora si parla
mentava. Le guardie vicariali fingevano di non accor
gersi, e quelle Ducali, si soffermavano a rìderne,
ascoltando gli strani discorsi che si facevano attra
verso lo steccato.
Era certamente questa una fra le poche distra
zioni che veniva concessa ai popolani senza che
avvenissero sorprese o rimostranze, perchè anche
quando i dienti erano in molti a farsi accalappiare,
le guardie stesse ne facevano le più matte risate,
se pure... non accadeva che il laccio accompagnato
da un lusinghiero sorriso, strìngesse al collo qualche
guardia!
Le cerimonie della Chiesa erano col Vicariato,
tornate all'antico splendore; celebre fra tutte quella
dd Corpus Domini a cui prendevano parte il Vicario,
il suo seguito, le numerose guardie e l'abbondante
numero di segretari, impiegati, amministratori dd
Tribunale ecclesiastico e tutto il piccolo mondo di
funzionari addetti ai numerosi uffici.
I
n a ti Tebei, Avventore ed Ottavio, chiamati
comunemente i Santi Martiri, erano i patroni di


















