
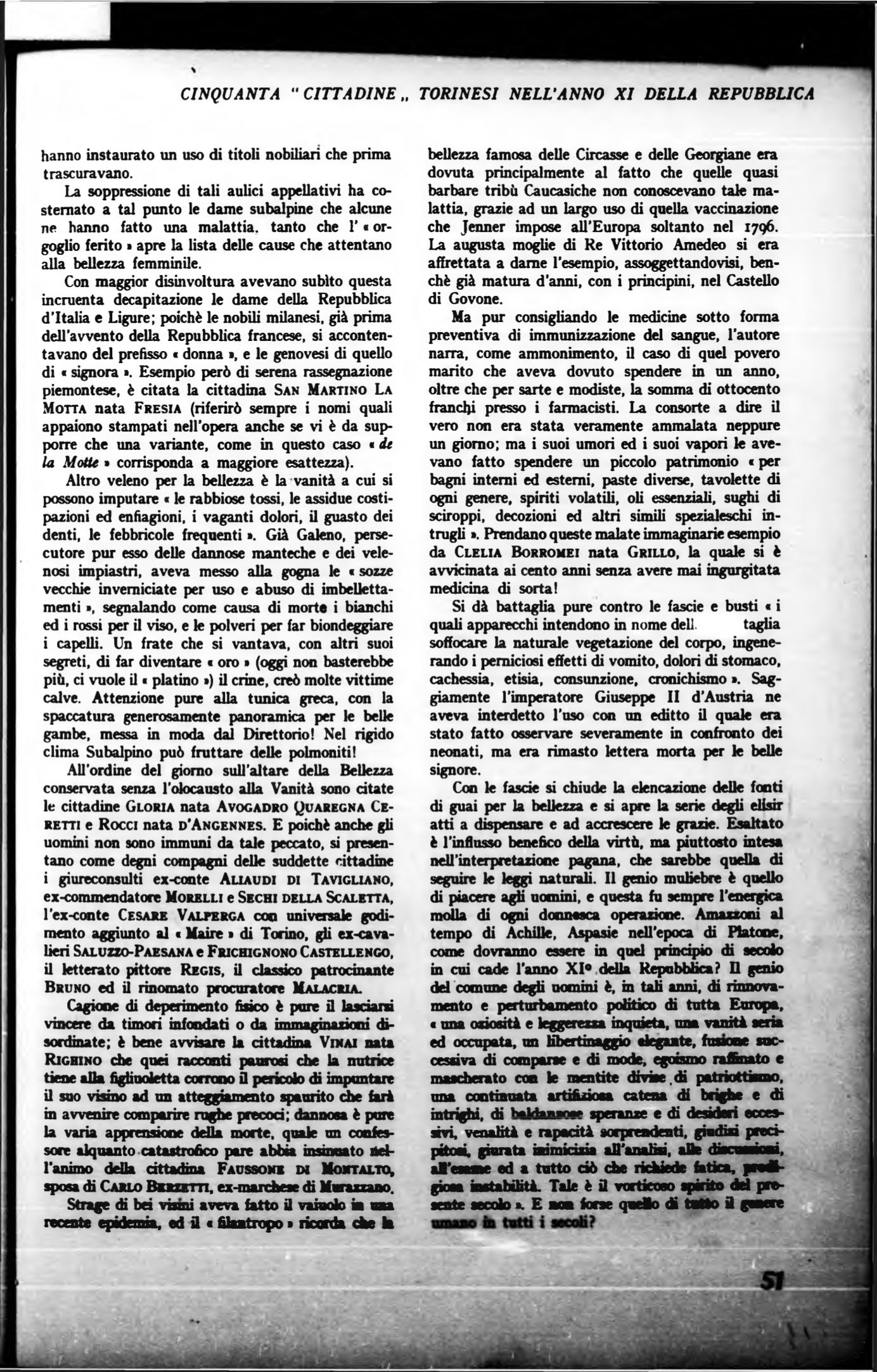
CINQUANTA
"
CITTADINE
„
TORINESI NELLANNO XI DELLA REPUBBUCA
hanno instaurato un uso di titoli nobiliari che prima
trascuravano.
La soppressione di tali aulici appellativi ha co
sternato a tal punto le dame subalpine che alcune
ne hanno fatto una malattia, tanto che 1’ «or
goglio ferito »apre la lista delle cause che attentano
alla bellezza femminile.
Con maggior disinvoltura avevano subito questa
incruenta decapitazione le dame della Repubblica
d’Italia e Ligure; poiché le nobili milanesi, già prima
dell’avvento della Repubblica francese, si acconten
tavano del prefìsso «donna », e le genovesi di quello
di «signora ». Esempio però di serena rassegnazione
piemontese, é citata la cittadina
S
an
M
a r t in o
L
a
M
o tta
nata
F
r e s ia
(riferirò sempre i nomi quali
appaiono stampati nell’opera anche se vi è da sup
porre che una variante, come in questo caso «
de
la Motte
» corrisponda a maggiore esattezza).
Altro veleno per la bellezza è la vanità a cui si
possono imputare «le rabbiose tossi, le assidue costi
pazioni ed enfiagioni, i vaganti dolori, il guasto dei
denti, le febbricole frequenti ». Già Galeno, perse
cutore pur esso delle dannose manteche e dei vele
nosi impiastri, aveva messo alla gogna le «sozze
vecchie inverniciate per uso e abuso di imbelletta-
menti », segnalando come causa di morte i bianchi
ed i rossi per il viso, e le polveri per far biondeggiare
i capelli. Un frate che si vantava, con altri suoi
segreti, di far diventare «oro » (oggi non basterebbe
più, ci vuole il «platino ») il crine, creò molte vittime
calve. Attenzione pure alla tunica greca, con la
spaccatura generosamente panoramica per le belle
gambe, messa in moda dal Direttorio! Nel rigido
clima Subalpino può fruttare delle polmoniti!
All’ordine del giorno sull’altare della Bellezza
conservata senza l’olocausto alla Vanità sono citate
le
cittadine
G
lor ia
nata
A
vog adro
y u
aregn a
C
e
rett i
e Rocci nata
d
’A
n g en n e s
.
E poiché anche gli
uomini non sono immuni da tale peccato, si presen
tano come degni compagni delle suddette cittadine
i giureconsulti ex-conte
A
l ia u d i
di
T
a v ig l ian o
,
ex-commendatore
M
o r e l l i
e
S
e ch i
d e l la
S
c a l e t t a
,
l ’ex-conte
C
e sar e
V
a l p e r g a
con universale godi
mento aggiunto al «Maire » di Torino, gli ex-cava
lieri
S
aluzzo
-P
a e sa n a
e
F
rich ignono
C
a ste llen go
,
il letterato pittore
R
e g is
,
il classico patrocinante
B
runo
ed il rinomato procuratore
M
a l a c r ia
.
Cagione di deperimento fisico è pure il lasciarsi
vincere da timori infondati o da immaginazioni di
sordinate; è bene avvisare la cittadina
V
inai
nata
R
ighino
che quei racconti paurosi che la nutrice
tiene alla fighuoletta corrono il pericolo di impuntare
il suo visino ad un atteggiamento spaurito che farà
in avvenire comparire rughe precoci; dannosa è pure
la varia apprensione della morte, quale un confes
sore alquanto catastrofico pare abbia insinuato nel
l'animo della cittadina
F
aussone
di
M
ontalto
,
sposa di
C
arlo
B
ekzetti
,
ex-marchese di Murazxano.
Strage di bei vismi aveva fatto il vainolo ia una
recate epidemia, ed il « filantropo » riconta che la
bellezza famosa delle Circasse e delle Georgiane era
dovuta principalmente al fatto che quelle quasi
barbare tribù Caucasiche non conoscevano tale ma
lattia, grazie ad un largo uso di quella vaccinazione
che Jenner impose all’Europa soltanto nel 1796.
La augusta moglie di Re Vittorio Amedeo si era
affrettata a darne l’esempio, assoggettandovisi, ben
ché già matura d’anni, con i principini, nel Castello
di Govone.
Ma pur consigliando le medicine sotto forma
preventiva di immunizzazione del sangue, l’autore
narra, come ammonimento, il caso di quel povero
marito che aveva dovuto spendere in un anno,
oltre che per sarte e modiste, la somma di ottocento
franchi presso i farmacisti. La consorte a dire il
vero non era stata veramente ammalata neppure
un giorno; ma i suoi umori ed i suoi vapori le ave
vano fatto spendere un piccolo patrimonio «per
bagni interni ed esterni, paste diverse, tavolette di
ogni genere, spiriti volatili, oli essenziali, sughi di
sciroppi, decozioni ed altri simili spezialeschi in
trugli ». Prendano queste malate immaginarie esempio
da
C
l e l i a
B
o r r o m e i
nata
G
r il l o
,
la quale si è
avvicinata ai cento anni senza avere mai ingurgitata
medicina di sorta!
Si dà battaglia pure contro le fascie e busti <i
quali apparecchi intendono in nome dell.
taglia
soffocare la naturale vegetazione del corpo, ingene
rando i perniciosi effetti di vomito, dolori di stomaco,
cachessia, etisia, consunzione, cronichismo ». Sag
giamente l’imperatore Giuseppe II d’Austria ne
aveva interdetto l ’uso con un editto il quale era
stato fatto osservare severamente in confronto dei
neonati, ma era rimasto lettera morta per le belle
signore.
Con le fascie si chiude la elencazione delle fonti
di guai per la bellezza e si apre la serie degli elisir
atti a dispensare e ad accrescere le grazie. Esaltato
è l ’influsso benefico della virtù, ma piuttosto intesa
nell'interpretazione pagana, che sarebbe quella di
seguire le leggi naturali. Il genio muliebre è quello
di piacere agli uomini, e questa fu sempre l’energica
molla di ogni donnesca operazione. Amazzoni al
tempo di Achille, Aspasie nell’epoca di Platone,
come dovranno essere in quel principio di secolo
in cui cade l’anno XI® della Repubblica? U genio
del comune degli uomini è, in tali anni, di rinnova
mento e perturbamento politico di tutta Europa,
«una oziosità e leggerezza inquieta, una vanità seria
ed occupata, un libertinaggio elegante, fonone suc
cessiva di comparse e di mode, egoismo raffinato e
mascherato con le mentite divise,di patriottismo,
una continuata artifiziosa catena di brighe e di
intrighi, di <*»«"«««* speranze e di desideri ecces
sivi, venalità e rapacità sorprendenti, giudizi preci
pitosi, giurata mimirazia all’analisi, aQe discussioni,
all’esame ed a tutto ciò die richiede fatica, prodi-
gioia instabilità. Tale è il vorticoso spirito del pre
sente secolo ». E non forse quello di tatto il genere


















