
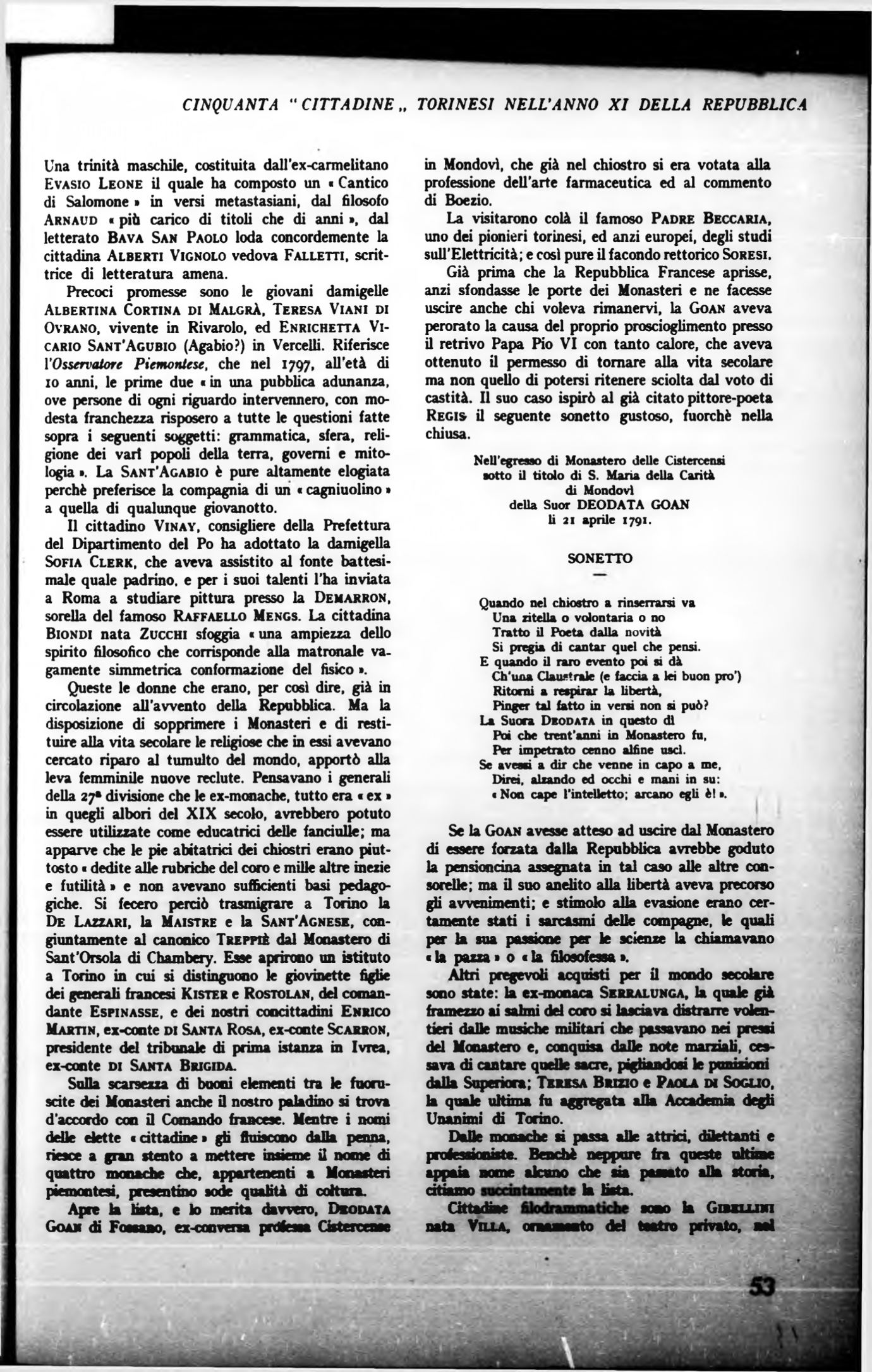
CINQUANTA " CITTADINE„ TORINESI NELLANNO X I DELLA REPUBBLICA
Una trinità maschile, costituita dall’ex-carmelitano
E
vasio
L
eone
il quale ha composto un «Cantico
di Salomone » in versi metastasiani, dal filosofo
A
rnaud
«più carico di titoli che di anni », dal
letterato
B
ava
S
an
P
aolo
loda concordemente la
cittadina
A
l ber t i
V
ignolo
vedova
F
alletti
,
scrit
trice di letteratura amena.
Precoci promesse sono le giovani damigelle
A lb e r t in a C o r t in a di MalgrA , T e r e s a V ian i di
Ovrano ,
vivente in Rivarolo, ed
E n r i c h e t t a Vi
c a r io S a n t ’Agubio
(Agabio?) in Vercelli. Riferisce
l'Ossetralore Piemontese,
che nel
1 7 9 7 ,
all’età di
10 anni, le prime due «in una pubblica adunanza,
ove persone di ogni riguardo intervennero, con mo
desta franchezza risposero a tutte le questioni fatte
sopra i seguenti soggetti: grammatica, sfera, reli
gione dei vari popoli della terra, governi e mito
logia ». La
S
ant
’A
gabio
è pure altamente elogiata
perchè preferisce la compagnia di un «cagniuolino »
a quella di qualunque giovanotto.
Il
cittadino V
inay
, consigliere della Prefettura
del Dipartimento del Po ha adottato la damigella
S
ofia
C
l e r k
, che aveva assistito al fonte ba ttesi
male quale padrino, e per i suoi talenti l ’ha inviata
a Roma a studiare pittura presso la D
emarron
,
sorella del famoso R
affaello
M
engs
. La cittadina
B
iondi
na ta Z
ucchi
sfoggia « una ampiezza dello
spirito filosofico che corrisponde alla matronale va
gamente simmetrica conformazione del fisico ».
Queste le donne che erano, per così dire, già in
circolazione all’avvento della Repubblica. Ma la
disposizione di sopprimere i Monasteri e di resti
tuire alla vita secolare le religiose che in essi avevano
cercato riparo al tumulto del mondo, apportò alla
leva femminile nuove reclute. Pensavano i generali
della
2 7 *
divisione che le ex-monache, tutto era «ex »
in quegli albori del XIX secolo, avrebbero potuto
essere utilizzate come educatrici delle fanciulle; ma
apparve che le pie abitatrici dei chiostri erano piut
tosto «dedite alle rubriche del coro e mille altre inezie
e futilità » e non avevano sufficienti basi pedago
giche. Si fecero perciò trasmigrare a Torino la
D e L a z z a r i,
la
M a is t r e
e la
S a n t ’A g n e s e ,
con
giuntamente al canonico
T r e p p iè
dal Monastero di
Sant'Orsola di Chambery. Esse aprirono un istituto
a Torino in cui si distinguono le giovinette figlie
dei generali francesi
K i s t e r
e
R o s t o la n ,
del coman
dante
E sp in a s s e ,
e dei nostri concittadini
E n r ic o
M a r tin ,
ex-conte
d i S a n ta R o s a ,
ex-conte
S c a r r o n ,
presidente del tribunale di prima istanza in Ivrea,
ex-conte
d i S a n t a B r ig id a .
Sulla scarsezza di buoni elementi tra le fuoru
scite dei Monasteri anche il nostro paladino si trova
d’accordo eoo il Comando francese. Mentre i nomi
delle elette «cittadine» gli fluiscano dalla penna,
riesce a gran stento a mettere insieme il nome di
quattro monache che, appartenenti a Monasteri
piemontesi, presentino sode qualità di coltura.
Apre
la lista, e lo merita davvero,
D
eodata
G
oan
di Foasano, ex-conversa
prtfasa
Cistercense
in Mondovl, che già nel chiostro si era votata alla
professione dell’arte farmaceutica ed al commento
di Boezio.
La visitarono colà il famoso P
adre
B
eccaria
,
uno dei pionieri torinesi, ed anzi europei, degli studi
Sull’E le ttricità ; e così pure il facondo rettori») S
o r e s i
.
Già prima che la Repubblica Francese aprisse,
anzi sfondasse le porte dei Monasteri e ne facesse
uscire anche chi voleva rimanervi, la
G
oan
aveva
perorato la causa del proprio proscioglimento presso
il retrivo Papa Pio VI con tanto calore, che aveva
ottenuto il permesso di tornare alla vita secolare
ma non quello di potersi ritenere sciolta dal voto di
castità. Il suo caso ispirò al già citato pittore-poeta
R
e g is
il seguente sonetto gustoso, fuorché nella
chiusa.
Nell'egresso d i Monastero delle Cistercensi
sotto il tito lo d i S. M aria della C arità
d i Mondovl
della Suor D EO D A TA GOAN
li
21
ap rile
1791
.
SO N ET TO
Quando nel chiostro a rinserrarsi va
Una z itella o volon taria o no
T ratto il Poeta d alla novità
S i pregia d i can tar quel che pensi.
E quando il raro evento poi si dà
Ch'una C laustrale (e faccia a lei buon prò’)
R ito rn i a respirar la libertà,
Finger ta l {a tto in versi non si può?
L a Suora
D
e o d a t a
in questo d i
Po i che tren t’anni in Monastero fu,
Pe r im petrato cenno alfine usci.
Se avessi a d ir che venne in capo a me,
D irei, alzando ed occhi e m ani in su:
1
Non cape l’in te lle tto ; arcano egli è! ».
Se la
G
oan
avesse atteso ad uscire dal Monastero
di essere forzata dalla Repubblica avrebbe goduto
la pensioncina assegnata in tal caso alle altre con
sorelle; ma il suo anelito alla libertà aveva precorso
gli avvenimenti; e stimolo alla evasione erano cer
tamente stati i sarcasmi delle compagne, le quali
per la sua passione per le scienze la chiamavano
«la pazza » o «la filosofessa ».
Altri pregevoli acquisti per il mondo secolare
sono state: la ex-monaca
S
erralunga
,
la quale già
framezzo ai salmi del coro si lasciava distrarre volen
tieri dalle musiche militari che passavano nei pressi
del Monastero e, conquisa dalle note marziali, ces
sava di cantare quelle sacre, pigliandosi le punizioni
dalla Superiora;
T
eresa
B
kizio
e
P
aola di
S
oglio
,
la quale ultima fu aggregata alla Accademia degli
Unanimi di Torino.
Dalle monache si passa alle attrici, dilettanti e
professioniste. Benché neppure fra queste ultime
appaia nome alcuno che sia passato alla storia,
citiamo
la lista.
Cittadine
sono la
G
ibelliki
nata
V
illa
,
ornamento del teatro privato,
nel


















