
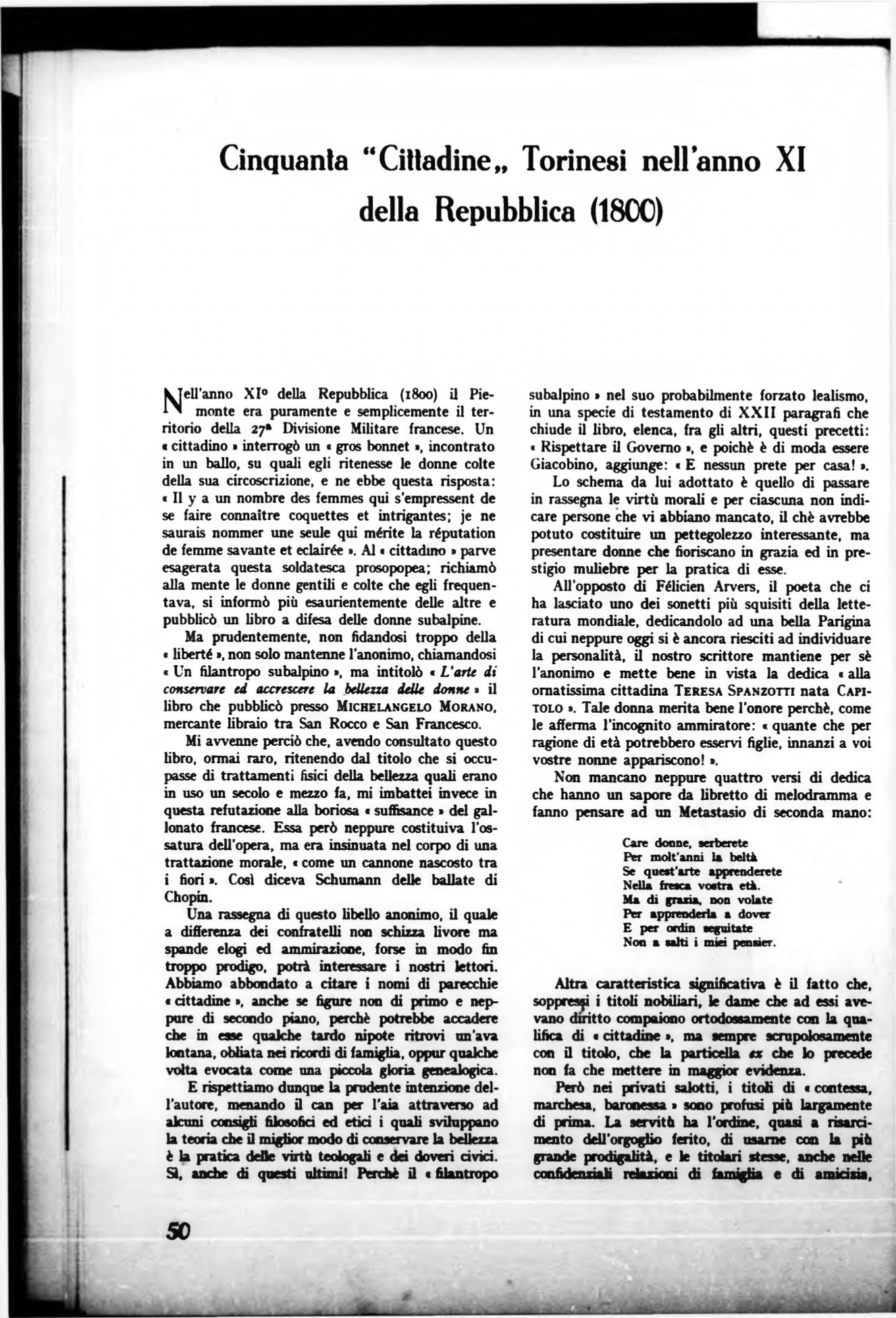
Cinquanta “Cittadine,, Torinesi nell’anno XI
della Repubblica (1800)
N
ell’anno XI° della Repubblica (1800) il Pie
monte era puramente e semplicemente il ter
ritorio della 27* Divisione Militare francese. Un
«cittadino »interrogò un «gros bonnet », incontrato
in un ballo, su quali egli ritenesse le donne colte
della sua circoscrizione, e ne ebbe questa risposta:
« Il
y
a un nombre des femmes qui s’empressent de
se faire connaitre coquettes et intrigantes; je ne
saurais nommer ime seule qui mérite la réputation
de femme savante et eclairée ». Al «cittadino »parve
esagerata questa soldatesca prosopopea; richiamò
alla mente le donne gentili e colte che egli frequen
tava, si informò più esaurientemente delle altre e
pubblicò un libro a difesa delle donne subalpine.
Ma prudentemente, non fidandosi troppo della
«liberté », non solo mantenne l’anonimo, chiamandosi
«Un filantropo subalpino », ma intitolò «
L'arte di
conservare ed accrescere la bellezza delle donne
» il
libro che pubblicò presso
M
ic h e l a n g e l o
M
o r a n o
,
mercante libraio tra San Rocco e San Francesco.
Mi avvenne perciò che, avendo consultato questo
libro, ormai raro, ritenendo dal titolo che si occu
passe di trattamenti fìsici della bellezza quali erano
in uso un secolo e mezzo fa, mi imbattei invece in
questa refutazione alla boriosa «suffisance »del gal
lonato francese. Essa però neppure costituiva l’os
satura dell’opera, ma era insinuata nel corpo di una
trattazione morale, • come un cannone nascosto tra
i fiori ». Così diceva Schumann delle ballate di
Chopin.
Una rassegna di questo libello anonimo, il quale
a differenza dei confratelli non schizza livore ma
spande elogi ed ammirazione, forse in modo fin
troppo prodigo, potrà interessare i nostri lettori.
Abbiamo abbondato a citare i nomi di parecchie
«cittadine », anche se figure non di primo e nep
pure di secondo piano, perchè potrebbe accadere
che in esse qualche tardo nipote ritrovi un’ava
lontana, obliata nei ricordi di famiglia, oppur qualche
volta evocata come una piccola gloria genealogica.
E rispettiamo dunque la prudente intenzione del
l’autore, menando il can per l'aia attraverso ad
alcuni consigli filosofici ed etici i quali sviluppano
la teoria che il miglior modo di conservare la bellezza
è la pratica delle virtù teologali e dei doveri civici.
Si, anche di questi aitimi! Perchè il « filantropo
subalpino » nel suo probabilmente forzato lealismo,
in una specie di testamento di XXII paragrafi che
chiude il libro, elenca, fra gli altri, questi precetti:
«Rispettare il Governo », e poiché è di moda essere
Giacobino, aggiunge: «E nessun prete per casa! ».
Lo schema da lui adottato è quello di passare
in rassegna le virtù morali e per ciascuna non indi
care persone che vi abbiano mancato, il chè avrebbe
potuto costituire un pettegolezzo interessante, ma
presentare donne che fioriscano in grazia ed in pre
stigio muliebre per la pratica di esse.
All’opposto di Félicien Arvers, il poeta che ci
ha lasciato uno dei sonetti più squisiti della lette
ratura mondiale, dedicandolo ad ima bella Parigina
di cui neppure oggi si è ancora riesciti ad individuare
la personalità, il nostro scrittore mantiene per sè
l’anonimo e mette bene in vista la dedica «alla
ornatissima cittadina
T
er e s a
S
pan zo tt i
nata
C
a p i
tolo
». Tale donna merita bene l’onore perchè, come
le afferma l ’incognito ammiratore: «quante che per
ragione di età potrebbero esservi figlie, innanzi a voi
vostre nonne appariscono! ».
Non mancano neppure quattro versi di dedica
che hanno un sapore da libretto di melodramma e
fanno pensare ad un Metastasio di seconda mano:
Care donne, serberete
Per molt’anni la beltà
Se quest’arte apprenderete
Nella fresca vostra età.
Ma di grazia, non volate
Per apprenderla
a
dover
E per ordin seguitate
Non a salti i miei pensier.
Altra caratteristica significativa è il fatto che,
soppressi i titoli nobiliari, le dame che ad essi ave
vano diritto compaiono ortodossamente con la qua
lifica di «cittadine », ma sempre scrupolosamente
con il titolo, che la particella
ex
che k> precede
non fa che mettere in maggior evidenza.
Però nei privati salotti, i titoli di «contessa,
marchesa, baronessa » sono profusi più largamente
di prima. La servitù ha l'ordine, quasi a risarci
mento dell’orgoglio ferito, di usarne con la più
grande prodigalità, e le titolari stesse, anche nelle
confidenziali relazioni di famiglia e di amicizia,
50


















