
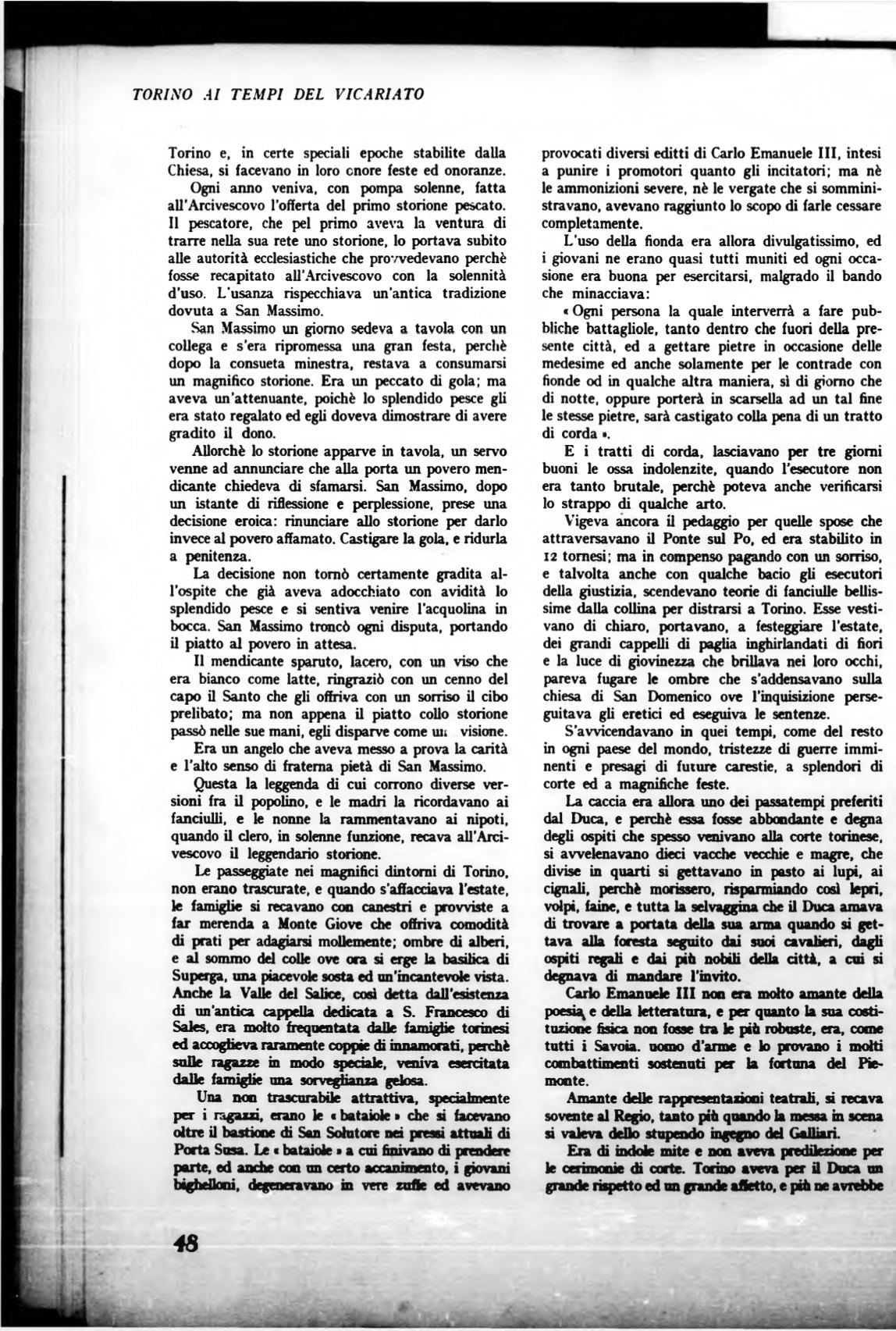
TORINO AI TEMPI DEL VICARIATO
Torino e, in certe speciali epoche stabilite dalla
Chiesa, si facevano in loro onore feste ed onoranze.
Ogni anno veniva, con pompa solenne, fatta
all'Arcivescovo l’offerta del primo storione pescato.
Il pescatore, che pel primo aveva la ventura di
trarre nella sua rete uno storione, lo portava subito
alle autorità ecclesiastiche che provvedevano perchè
fosse recapitato all'Arcivescovo con la solennità
d’uso. L'usanza rispecchiava un’antica tradizione
dovuta a San Massimo.
San Massimo un giorno sedeva a tavola con un
collega e s ’era ripromessa una gran festa, perchè
dopo la consueta minestra, restava a consumarsi
un magnifico storione. Era un peccato di gola; ma
aveva un’attenuante, poiché lo splendido pesce gli
era stato regalato ed egli doveva dimostrare di avere
gradito il dono.
Allorché lo storione apparve in tavola, un servo
venne ad annunciare che alla porta un povero men
dicante chiedeva di sfamarsi. San Massimo, dopo
un istante di riflessione e perplessione, prese una
decisione eroica: rinunciare allo storione per darlo
invece al povero affamato. Castigare la gola, e ridurla
a penitenza.
La decisione non tornò certamente gradita al
l’ospite che già aveva adocchiato con avidità lo
splendido pesce e si sentiva venire l’acquolina in
bocca. San Massimo troncò ogni disputa, portando
il piatto al povero in attesa.
Il
mendicante sparuto, lacero, con un viso che
era bianco come latte, ringraziò con un cenno del
capo il Santo che gli offriva con un sorriso il cibo
prelibato; ma non appena il piatto collo storione
passò nelle sue mani, egli disparve come un visione.
Era un angelo che aveva messo a prova la carità
e l ’alto senso di fraterna pietà di San Massimo.
Questa la leggenda di cui corrono diverse ver
sioni fra il popolino, e le madri la ricordavano ai
fanciulli, e le nonne la rammentavano ai nipoti,
quando il clero, in solenne funzione, recava all’Arci-
vescovo il leggendario storione.
Le passeggiate nei magnifici dintorni di Torino,
non erano trascurate, e quando s'affacciava l’estate,
le famiglie si recavano con canestri e provviste a
far merenda a Monte Giove che offriva comodità
di prati per adagiarsi mollemente; ombre di alberi,
e ai sommo del colle ove ora si erge la basilica di
Superga, una piacevole sosta ed un’incantevole vista.
Anche la Valle del Salice, così detta dall’esistenza
di un’antica cappella dedicata a S. Francesco di
Sales, era molto frequentata dalle famiglie torinesi
ed accoglieva raramente coppie di innamorati, perchè
sulle ragazze in modo speciale, veniva esercitata
dalle famiglie una sorveglianza gelosa.
Una non trascurabile attrattiva, specialmente
per i ragazzi, erano le «bataiole » che si facevano
oltre il bastione di San Solutore nei pressi attuali di
Porta Susa. Le «bataiole »a cui finivano di prendere
parte, ed anche con un certo accanimento, i giovani
bighelloni, degeneravano in vere zuffe ed avevano
provocati diversi editti di Carlo Emanuele III, intesi
a punire i promotori quanto gli incitatori; ma nè
le ammonizioni severe, nè le vergate che si sommini
stravano, avevano raggiunto lo scopo di farle cessare
completamente.
L ’uso della fionda era allora divulgatissimo, ed
i giovani ne erano quasi tutti muniti ed ogni occa
sione era buona per esercitarsi, malgrado il bando
che minacciava:
«Ogni persona la quale interverrà a fare pub
bliche battagliole, tanto dentro che fuori della pre
sente città, ed a gettare pietre in occasione delle
medesime ed anche solamente per le contrade con
fionde od in qualche altra maniera, sì di giorno che
di notte, oppure porterà in scarsella ad un tal fine
le stesse pietre, sarà castigato colla pena di un tratto
di corda ».
E i tratti di corda, lasciavano per tre giorni
buoni le ossa indolenzite, quando l’esecutore non
era tanto brutale, perchè poteva anche verificarsi
lo strappo di qualche arto.
Vigeva ancora il pedaggio per quelle spose che
attraversavano il Ponte sul Po, ed era stabilito in
12 tomesi; ma in compenso pagando con un sorriso,
e talvolta anche con qualche bacio gli esecutori
della giustizia, scendevano teorie di fanciulle bellis
sime dalla collina per distrarsi a Torino. Esse vesti
vano di chiaro, portavano, a festeggiare l’estate,
dei grandi cappelli di paglia inghirlandati di fiori
e la luce di giovinezza che brillava nei loro occhi,
pareva fugare le ombre che s’addensavano sulla
chiesa di San Domenico ove l’inquisizione perse
guitava gli eretici ed eseguiva le sentenze.
S’avvicendavano in quei tempi, come del resto
in ogni paese del mondo, tristezze di guerre immi
nenti e presagi di future carestie, a splendori di
corte ed a magnifiche feste.
La caccia era allora uno dei passatempi preferiti
dal Duca, e perchè essa fosse abbondante e degna
degli ospiti che spesso venivano alla corte torinese,
si avvelenavano dieci vacche vecchie e magre, che
divise in quarti si gettavano in pasto ai lupi, ai
cignali, perchè morissero, risparmiando così lepri,
volpi, faine, e tutta la selvaggina che il Duca amava
di trovare a portata della sua arma quando si get
tava alla foresta seguito dai suoi cavalieri, dagli
ospiti regali e dai più nobili della città, a cui si
degnava di mandare l’invito.
Carlo Emanuele III non era molto amante della
poesia^e della letteratura, e per quanto la sua costi
tuzione fisica non fosse tra le piò robuste, era, come
tutti i Savoia, uomo d’arme e lo provano i molti
combattimenti sostenuti per la fortuna del Pie
monte.
Amante delle rappresentazioni teatrali, si recava
sovente al Regio, tanto più quando la messa in scena
si valeva dello stupendo ingegno del Galliari.
Era di indole mite e non aveva predilezione per
le cerimonie di corte. Torino aveva per il Duca un
grande rispetto ed un grande affetto, e più ne avrebbe
48


















