
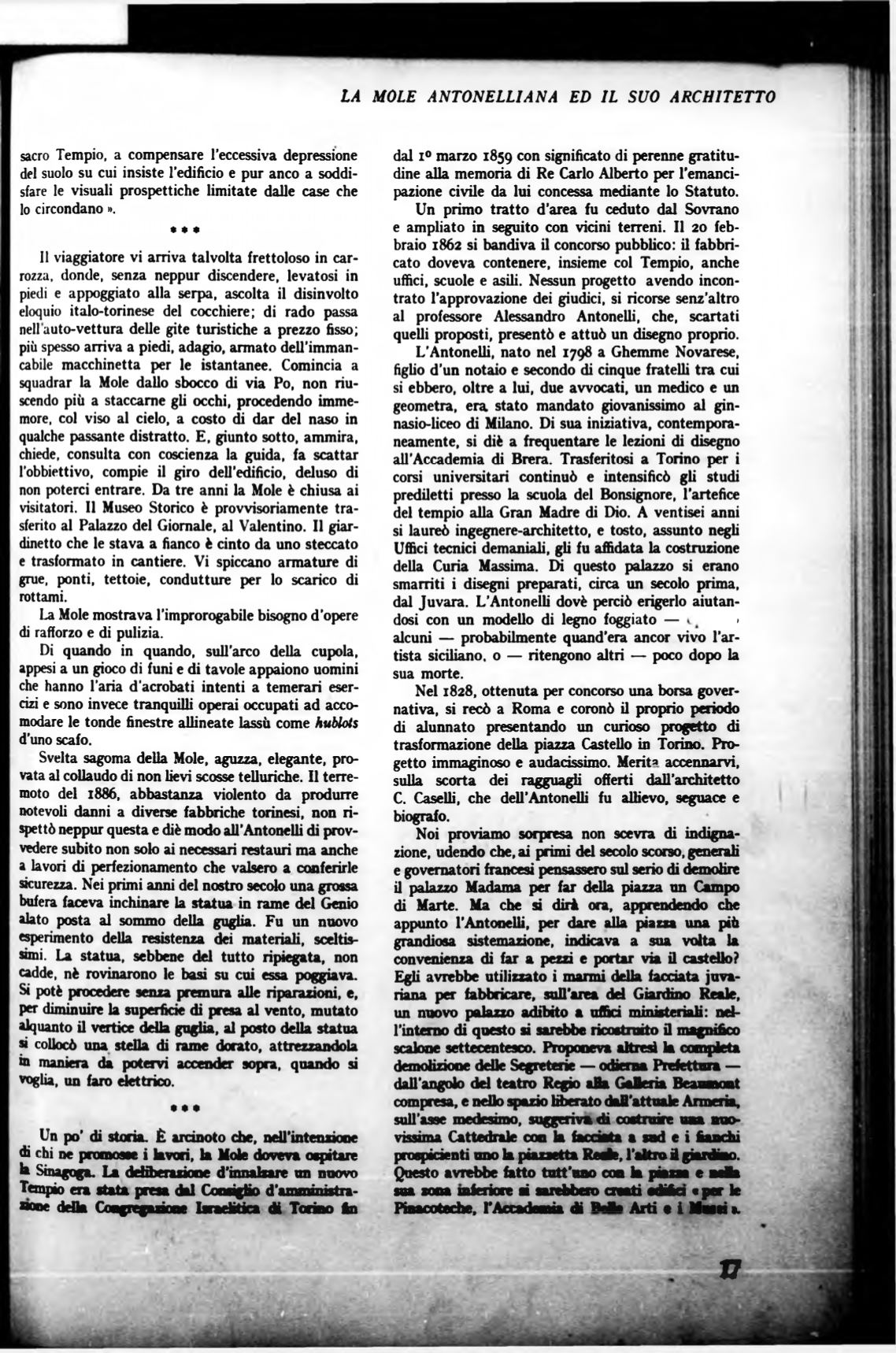
LA MOLE ANTONE H I AN A ED I L SUO ARCHITETTO
sacro Tempio, a compensare l’eccessiva depressione
del suolo su cui insiste l’edifìcio e pur anco a soddi
sfare le visuali prospettiche limitate dalle case che
lo circondano ».
* * *
Il viaggiatore vi arriva talvolta frettoloso in car
rozza, donde, senza neppur discendere, levatosi in
piedi e appoggiato alla serpa, ascolta il disinvolto
eloquio italo-torinese del cocchiere; di rado passa
nell auto-vettura delle gite turistiche a prezzo fisso;
più spesso arriva a piedi, adagio, armato dell’imman
cabile macchinetta per le istantanee. Comincia a
squadrar la Mole dallo sbocco di via Po, non riu
scendo più a staccarne gli occhi, procedendo imme
more, col viso al cielo, a costo di dar del naso in
qualche passante distratto. E, giunto sotto, ammira,
chiede, consulta con coscienza la guida, fa scattar
l’obbiettivo, compie il giro dell’edificio, deluso di
non poterci entrare. Da tre anni la Mole è chiusa ai
visitatori. Il Museo Storico è provvisoriamente tra
sferito al Palazzo del Giornale, al Valentino. Il giar
dinetto che le stava a fianco è cinto da uno steccato
e trasformato in cantiere. Vi spiccano armature di
grue, ponti, tettoie, condutture per lo scarico di
rottami.
La Mole mostrava l’improrogabile bisogno d ’opere
di rafforzo e di pulizia.
Di quando in quando, sull’arco della cupola,
appesi a un gioco di funi e di tavole appaiono uomini
che hanno l’aria d ’acrobati intenti a temerari eser
cizi e sono invece tranquilli operai occupati ad acco
modare le tonde finestre allineate lassù come
hublots
d’uno scafo.
Svelta sagoma della Mole, aguzza, elegante, pro
vata al collaudo di non lievi scosse telluriche. Il terre
moto del 1886, abbastanza violento da produrre
notevoli danni a diverse fabbriche torinesi, non ri
spettò neppur questa e diè modo all’Antonelli di prov
vedere subito non solo ai necessari restauri ma anche
a lavori di perfezionamento che valsero a conferirle
sicurezza. Nei primi anni del nostro secolo una grossa
bufera faceva inchinare la statua in rame del Genio
alato posta al sommo della guglia. Fu un nuovo
esperimento della resistenza dei materiali, sceltis
simi. La statua, sebbene del tutto ripiegata, non
cadde, nè rovinarono le basi su cui essa poggiava.
Si potè procedere senza premura alle riparazioni, e,
per diminuire la superficie di presa al vento, mutato
alquanto il vertice della guglia, al posto della statua
si collocò una stella di rame dorato, attrezzandola
in maniera da potervi accender sopra, quando si
voglia, un faro elettrico.
• • *
Un po’ di storia. È arcinoto che, nell’intenzione
di
chi
ne promosse i lavori, la Mole doveva ospitare
h Sinagoga. La dehberazàooe d'innalzare un nuovo
Tempio era stata presa dsi Consiglio d’amministra-
aooe della Congregazione Israelitica di Torino fin
dal i° marzo 1859 con significato di perenne gratitu
dine alla memoria di Re Carlo Alberto per l’emanci
pazione civile da lui concessa mediante lo Statuto.
Un primo tratto d ’area fu ceduto dal Sovrano
e ampliato in seguito con vicini terreni. Il 20 feb
braio 1862 si bandiva il concorso pubblico: il fabbri
cato doveva contenere, insieme col Tempio, anche
uffici, scuole e asili. Nessun progetto avendo incon
trato l’approvazione dei giudici, si ricorse senz’altro
al professore Alessandro Antonelli, che, scartati
quelli proposti, presentò e attuò un disegno proprio.
L ’Antonelli, nato nel 1798 a Ghemme Novarese,
figlio d ’un notaio e secondo di cinque fratelli tra cui
si ebbero, oltre a lui, due avvocati, un medico e un
geometra, era stato mandato giovanissimo al gin
nasio-liceo di Milano. Di sua iniziativa, contempora
neamente, si diè a frequentare le lezioni di disegno
all’Accademia di Brera. Trasferitosi a Torino per i
corsi universitari continuò e intensificò gli studi
prediletti presso la scuola del Bonsignore, l ’artefice
del tempio alla Gran Madre di Dio. A ventisei anni
si laureò ingegnere-architetto, e tosto, assunto negli
Uffici tecnici demaniali, gli fu affidata la costruzione
della Curia Massima. Di questo palazzo si erano
smarriti i disegni preparati, circa un secolo prima,
dal Juvara. L ’Antonelli dovè perciò erigerlo aiutan
dosi con un modello di legno foggiato —
>
alcuni — probabilmente quand’era ancor vivo l’ar
tista siciliano, o — ritengono altri — poco dopo la
sua morte.
Nel 1828, ottenuta per concorso ima borsa gover
nativa, si recò a Roma e coronò il proprio periodo
di alunnato presentando un curioso progetto di
trasformazione della piazza Castello in Torino. Pro
getto immaginoso e audacissimo. Merita accennarvi,
sulla scorta dei ragguagli offerti dall’architetto
C. Caselli, che dell’AntoneUi fu allievo, seguace e
biografo.
Noi proviamo sorpresa non scevra di indigna
zione, udendo che, ai primi del secolo scorso, generali
e governatori francesi pensassero sul serio di demolire
il palazzo Madama per far della piazza un Campo
di Marte. Ma che si d iri ora, apprendendo che
appunto l’Antonelli, per dare alla piazza una più
grandiosa sistemazione, indicava a sua volta la
convenienza di far a pezzi e portar via il castello?
Egli avrebbe utilizzato i marmi della facciata juva-
riana per fabbricare, sull’area dd Giardino Reale,
un nuovo palazzo adibito a offici ministeriali: nel
l’interno di questo si sarebbe ricostruito il magnifico
scalone settecentesco. Proponeva altresì la compieta
demolizione delle Segreterie — odierna Prefettura —
dall'angolo del teatro Regio alla Galleria Beaumont
compresa, e nello spazio liberato dall'attuale Armeria,
sull’asse medesimo, suggeriva di costruire una nuo
vissima Cattedrale con la facciata a sud e i fianchi
prospicienti uno la piazzetta Reafe, l ’altro il giardino.
Questo avrebbe fatto tntt’uno con la piana e nella
sua zona inferiore à sarebbero croati edifici «per le
Pinacoteche,
1
*Accademia di M » Arti e i U n ii •.
J7


















