
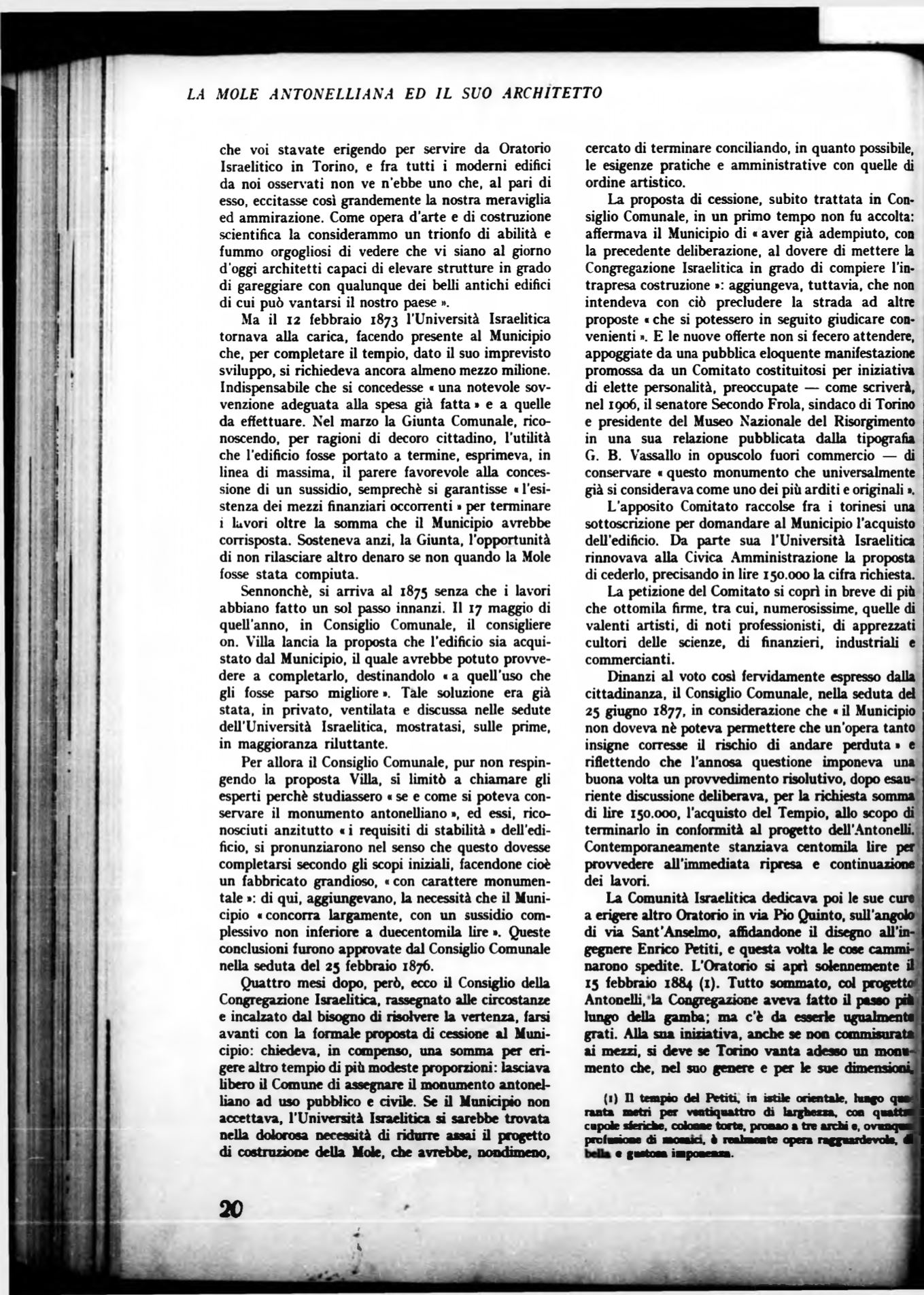
LA MOLE ANTONELL I ANA ED I L SUO ARCHITETTO
che voi stavate erigendo per servire da Oratorio
Israelitico in Torino, e fra tutti i moderni edifici
da noi osservati non ve n ’ebbe uno che, al pari di
esso, eccitasse così grandemente la nostra meraviglia
ed ammirazione. Come opera d ’arte e di costruzione
scientifica la considerammo un trionfo di abilità e
fummo orgogliosi di vedere che vi siano al giorno
d ’oggi architetti capaci di elevare strutture in grado
di gareggiare con qualunque dei belli antichi edifici
di cui può vantarsi il nostro paese ».
Ma il 12 febbraio 1873 l’Università Israelitica
tornava alla carica, facendo presente al Municipio
che, per completare il tempio, dato il suo imprevisto
sviluppo, si richiedeva ancora almeno mezzo milione.
Indispensabile che si concedesse «una notevole sov
venzione adeguata alla spesa già fatta » e a quelle
da effettuare. Nel marzo la Giunta Comunale, rico
noscendo, per ragioni di decoro cittadino, l’utilità
che l’edificio fosse portato a termine, esprimeva, in
linea di massima, il parere favorevole alla conces
sione di un sussidio, semprechè si garantisse «l’esi
stenza dei mezzi finanziari occorrenti »per terminare
i lavori oltre la somma che il Municipio avrebbe
corrisposta. Sosteneva anzi, la Giunta, l’opportunità
di non rilasciare altro denaro se non quando la Mole
fosse stata compiuta.
Sennonché, si arriva al 1875 senza che i lavori
abbiano fatto un sol passo innanzi. Il 17 maggio di
quell’anno, in Consiglio Comunale, il consigliere
on. Villa lancia la proposta che l’edificio sia acqui
stato dal Municipio, il quale avrebbe potuto provve
dere a completarlo, destinandolo «a quell’uso che
gli fosse parso migliore ». Tale soluzione era già
stata, in privato, ventilata e discussa nelle sedute
dell’Università Israelitica, mostratasi, sulle prime,
in maggioranza riluttante.
Per allora il Consiglio Comunale, pur non respin
gendo la proposta Villa, si limitò a chiamare gli
esperti perchè studiassero «se e come si poteva con
servare il monumento antonelliano », ed essi, rico
nosciuti anzitutto « i requisiti di stabilità » dell’edi
fìcio, si pronunziarono nel senso che questo dovesse
completarsi secondo gli scopi iniziali, facendone cioè
un fabbricato grandioso, «con carattere monumen
tale »: di qui, aggiungevano, la necessità che il Muni
cipio «concorra largamente, con un sussidio com
plessivo non inferiore a duecentomila lire ». Queste
conclusioni furono approvate dal Consiglio Comunale
nella seduta del 25 febbraio 1876.
Quattro mesi dopo, però, ecco il Consiglio della
Congregazione Israelitica, rassegnato alle circostanze
e incalzato dal bisogno di risolvere la vertenza, farsi
avanti con la formale proposta di cessione al Muni
cipio: chiedeva, in compenso, una somma per eri
gere altro tempio di più modeste proporzioni: lasciava
libero il Comune di assegnare il monumento antonel
liano ad uso pubblico e civile. Se il Municipio non
accettava, l ’Università Israelitica si sarebbe trovata
nella dolorosa necessità di ridurre assai il progetto
di costruzione della Mole, che avrebbe, nondimeno,
30
r
k
cercato di terminare conciliando, in quanto possibile,
le esigenze pratiche e amministrative con quelle di
ordine artistico.
La proposta di cessione, subito trattata in Con
siglio Comunale, in un primo tempo non fu accolta:
affermava il Municipio di «aver già adempiuto, con
la precedente deliberazione, al dovere di mettere la
Congregazione Israelitica in grado di compiere l’in
trapresa costruzione »: aggiungeva, tuttavia, che non
intendeva con ciò precludere la strada ad altre
proposte «che si potessero in seguito giudicare con
venienti ». E le nuove offerte non si fecero attendere,
appoggiate da una pubblica eloquente manifestazione
promossa da un Comitato costituitosi per iniziativa
di elette personalità, preoccupate — come scriverà,
nel 1906, il senatore Secondo Frola, sindaco di Torino
e presidente del Museo Nazionale del Risorgimento
in una sua relazione pubblicata dalla tipografìa
G. B. Vassallo in opuscolo fuori commercio — di
conservare «questo monumento che universalmente
già si considerava come uno dei più arditi e originali ».
L ’apposito Comitato raccolse fra i torinesi una
sottoscrizione per domandare al Municipio l’acquisto
dell’edifìcio. Da parte sua l’Università Israelitica
rinnovava alla Civica Amministrazione la proposta
di cederlo, precisando in lire 150.000 la cifra richiesta.
La petizione del Comitato si coprì in breve di più
che ottomila firme, tra cui, numerosissime, quelle di
valenti artisti, di noti professionisti, di apprezzati
cultori delle scienze, di finanzieri, industriali e
commercianti.
Dinanzi al voto così fervidamente espresso dalla
cittadinanza, il Consiglio Comunale, nella seduta del
25 giugno 1877, in considerazione che «il Municipio
non doveva nè poteva permettere che un’opera tanto
insigne corresse il rischio di andare perduta » e
riflettendo che l’annosa questione imponeva una
buona volta un provvedimento risolutivo, dopo esau
riente discussione deliberava, per la richiesta somma
di lire 150.000, l’acquisto del Tempio, allo scopo di
terminarlo in conformità al progetto dell’Antonelli.
Contemporaneamente stanziava centomila lire per
provvedere a ll’immediata ripresa e continuazione
dei lavori.
La Comunità Israelitica dedicava poi le sue cure
a erigere altro Oratorio in via Pio Quinto, sull’angolo
di via Sant'Anselmo, affidandone il disegno all’in
gegnere Enrico Petiti, e questa volta le cose cammi
narono spedite. L ’Oratorio si aprì solennemente il
15 febbraio 1884 (1). Tutto sommato, col progetto
Antonelli, la Congregazione aveva fatto il passo più
lungo della gamba; ma c ’è da esserle ugualmente
grati. Alla sua iniziativa, anche se non commisurata
ai mezzi, si deve se Torino vanta adesso un menu--
mento che, nel suo genere e per le sue dimensioni.
(
1
) Il tempio del IVtiti, in istile orientale, lungo q » > |
ran ta metri per ventiquattro di larghezza, con q o a t t iw
cupole sferiche, colonne torte, pronao a tre archi e,
ovunqnuj
profusione di moauci, è realmente opera ragguardevole, di
© guitoMi imponenza.


















