
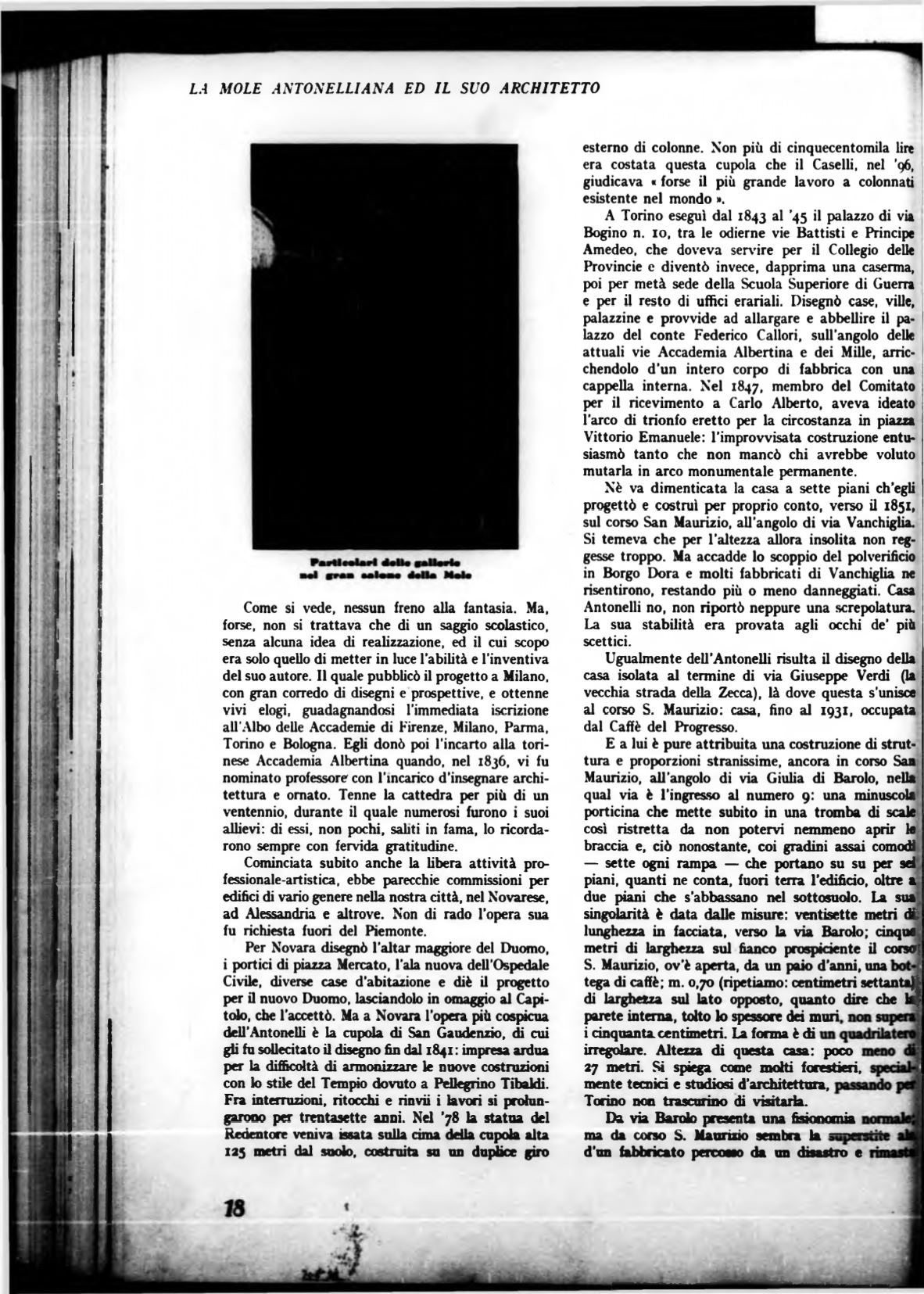
Come si vede, nessun freno alla fantasia. Ma,
forse, non si trattava che di un saggio scolastico,
senza alcuna idea di realizzazione, ed il cui scopo
era solo quello di metter in luce l’abilità e l’inventiva
del suo autore. Il quale pubblicò il progetto a Milano,
con gran corredo di disegni e prospettive, e ottenne
vivi elogi, guadagnandosi l’immediata iscrizione
all'Albo delle Accademie di Firenze, Milano, Parma,
Torino e Bologna. Egli donò poi l’incarto alla tori
nese Accademia Albertina quando, nel 1836, vi fu
nominato professore con l ’incarico d ’insegnare archi
tettura e ornato. Tenne la cattedra per più di un
ventennio, durante il quale numerosi furono i suoi
allievi: di essi, non pochi, saliti in fama, lo ricorda
rono sempre con fervida gratitudine.
Cominciata subito anche la Ubera attività pro-
fessionale-artistica, ebbe parecchie commissioni per
edifici di vario genere nella nostra città, nel Novarese,
ad Alessandria e altrove. Non di rado l’opera sua
fu richiesta fuori del Piemonte.
Per Novara disegnò l ’altar maggiore del Duomo,
i portici di piazza Mercato, l’ala nuova dell’Ospedale
Civile, diverse case d’abitazione e diè il progetto
per il nuovo Duomo, lasciandolo in omaggio al Capi
tolo, che l'accettò. Ma a Novara l’opera più cospicua
dell’AntoneUi è la cupola di San Gaudenzio, di cui
gli fu sollecitato il disegno fin dal 1841 : impresa ardua
per la difficoltà di armonizzare le nuove costruzioni
con lo stile del Tempio dovuto a Pellegrino Tibakli.
Fra interruzioni, ritocchi
e
rinvii i lavori si prolun
garono per trentasette anni. Nel *78 la statua del
Redentore veniva issata sulla cima della
cupola
alta
125 metri dal sudo, costruita
su un duplice giro
LA MOLE ANTONELL IANA ED I L SUO ARCHITETTO
esterno di colonne. Non più di cinquecentomila lire
era costata questa cupola che il Caselli, nel '96,
giudicava « forse il più grande lavoro a colonnati
esistente nel mondo ».
A Torino eseguì dal 1843 al '45 il palazzo di via
Bogino n. 10, tra le odierne vie Battisti e Principe
Amedeo, che doveva servire per il Collegio delle
Provincie e diventò invece, dapprima una caserma,
poi per metà sede della Scuola Superiore di Guerra
e per il resto di uffici erariali. Disegnò case, ville,
palazzine e provvide ad allargare e abbellire il pa
lazzo del conte Federico Callori, sull’angolo delle
attuali vie Accademia Albertina e dei Mille, arric
chendolo d ’un intero corpo di fabbrica con una
cappella interna. Nel 1847, membro del Comitato
per il ricevimento a Carlo Alberto, aveva ideato
l’arco di trionfo eretto per la circostanza in piazza
Vittorio Emanuele: l ’improvvisata costruzione entu
siasmò tanto che non mancò chi avrebbe voluto
mutarla in arco monumentale permanente.
Nè va dimenticata la casa a sette piani ch’egli
progettò e costruì per proprio conto, verso il 1851,
sul corso San Maurizio, all’angolo di via Vanchiglia.
Si temeva che per l ’altezza allora insolita non reg
gesse troppo. Ma accadde lo scoppio del polverificio
in Borgo Dora e molti fabbricati di Vanchiglia ne
risentirono, restando più o meno danneggiati. Casa
Antonelli no, non riportò neppure una screpolatura.
La sua stabilità era provata agli occhi de’ più
scettici.
Ugualmente dell’Antonelli risulta il disegno della
casa isolata al termine di via Giuseppe Verdi (la
vecchia strada della Zecca), là dove questa s’unisce
al corso S. Maurizio: casa, fino al 1931, occupata
dal Caffè del Progresso.
E a lui è pure attribuita ima costruzione di strut
tura e proporzioni stranissime, ancora in corso San
Maurizio, a ll’angolo di via Giulia di Barolo, nella
qual via è l ’ingresso al numero 9: una minuscola
porticina che mette subito in una tromba di scale
così ristretta da non potervi nemmeno aprir le
braccia e, ciò nonostante, coi gradini assai comodi
— sette ogni rampa — che portano su su per sei
piani, quanti ne conta, fuori terra l'edificio, oltre a
due piani che s’abbassano nel sottosuolo. La sua
singolarità è data dalle misure: ventisette metri dii
lunghezza in facciata, verso la via Barolo; cinque
metri di larghezza sul fianco prospiciente il corso?
S. Maurizio, o v ’è aperta, da un paio d'anni, una
tega di caffè; m. 0,70 (ripetiamo: centimetri settanta)^
di larghezza sul lato opposto, quanto dire che
taf
parete interna, tolto lo spessore dei muri
i cinquanta centimetri. La forma è di
irregolare. Altezza di questa casa: poco
27 metri. Si spiega come molti forestieri,
mente tecnici e studiosi d'architettura,
Torino non trascurino di visitarla.
Da via Bardo presenta una fisionomia
ma da corso
S.
Maurizio sembra la
d’un fabbricato percosso da un disastro e
____


















