
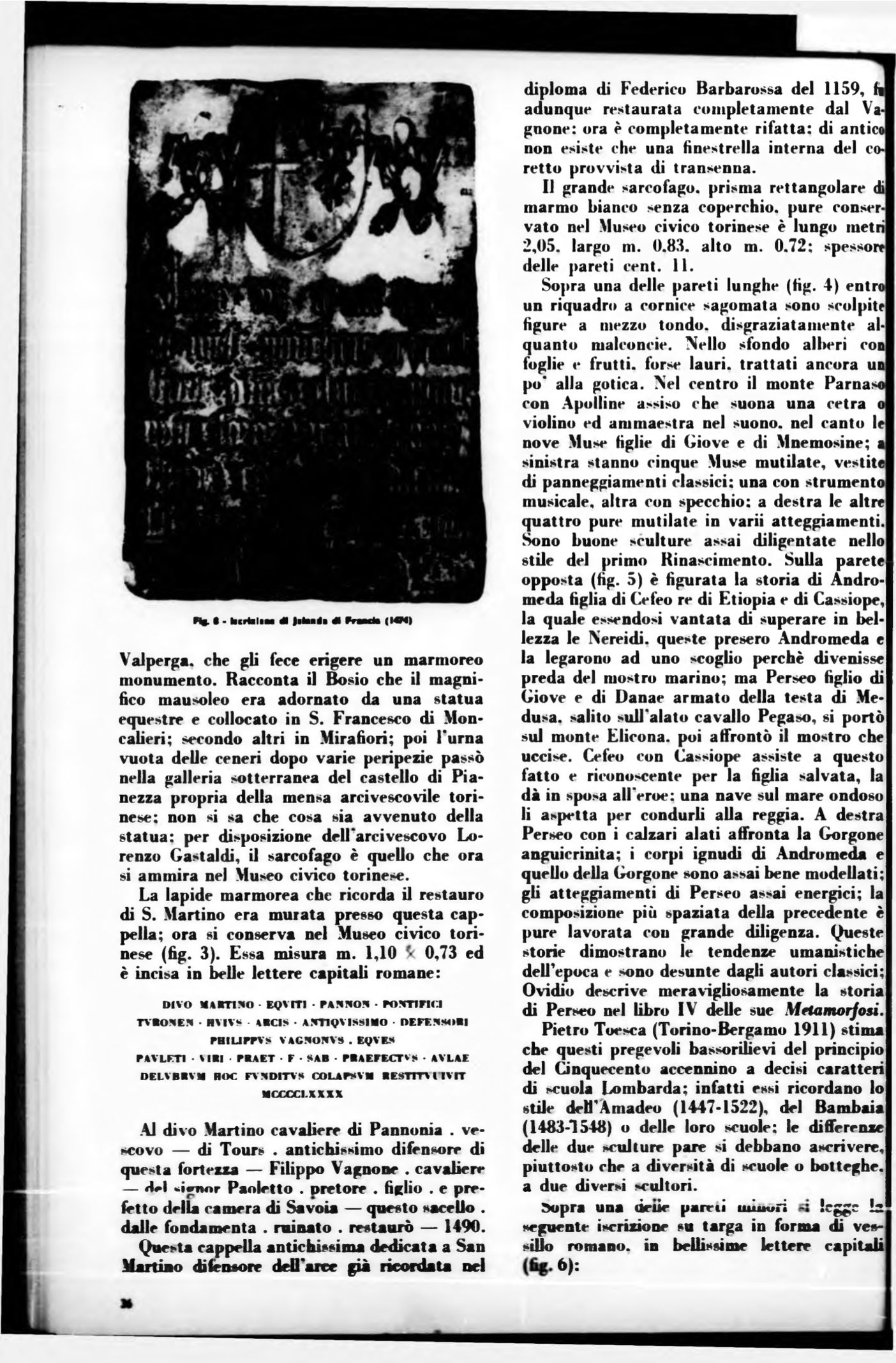
f if . t -
b i r i l l i — « )■>■■<» « P raacfa <1474)
Valperga. che gli fece erigere un marmoreo
monumento. Racconta il Bosio che il magni
fico mausoleo era adornato da una statua
equestre e collocato in S. Francesco di Mon
calieri; secondo altri in Mirafiori; poi l'urna
vuota delle ceneri dopo varie peripezie passò
nella galleria sotterranea del castello di Pia
nezza propria della mensa arcivescovile tori
nese; non si sa che cosa sia avvenuto della
statua: per disposizione dell'arcivescovo Lo
renzo Castaldi, il sarcofago è quello che ora
si ammira nel Museo civico torinese.
La lapide marmorea che ricorda il restauro
di S. Martino era murata presso questa cap
pella; ora si conserva nel Museo civico tori
nese (fig. 3). Essa misura m.
1,10
0,73 ed
è incisa in belle lettere capitali romane:
D IV O M A R T IN O • E Q V IT 1 • P A N N O * - P O N T IF IC I
T V R O N E N • H V IV S - A R C IS • A M I C I S S I M O • D E F E N S O R I
p h i l i p p v s
v a g n o n v s
.
e q v e s
P A V L K T l • V IR I • P R A E T • F • S A B • P R A E F E C T V S • A V L A E
D E L V B R V M H O C F V N D IT V 8 C O L A P S V M R E S T IT V I I V I T
M C C C C I.X X X X
Al divo Martino cavaliere di Pannonia . ve
scovo — di Tours . antichissimo difensore di
questa fortezza — Filippo Vagnone . cavaliere
— d«>l kivnnr Paoletto . pretore . figlio . e pre
fetto della camera di Savoia — questo sacello .
dalle fondamenta . minato . restaurò — 1490.
Questa cappella antichissima dedicata a San
Martino difensore dell'arce già ricordata nel
diploma di Federico Barbarossa del 1159, fi
adunque restaurata completamente dal Va
gnone: ora è completamente rifatta: di antico
non esiste ehe una finestrella interna del co-
retto provvista di transenna.
Il grande sarcofago, prisma rettangolare di
marmo bianco senza coperchio, pure conser
vato nel Museo civico torinese è lungo metri
2 ,05 .
largo m.
0 .83.
alto m.
0 .72 ;
spessore
delle pareti cent.
1 1
.
Sopra una delle pareti lunghe (fig. 4) entro
un riquadro a cornice sagomata sono scolpite
figure a mezzo tondo, disgraziatamente al
quanto malconcie. Nello sfondo alberi con
foglie e frutti, forse lauri, trattati ancora un
po' alla gotica. Nel centro il monte Parnaso
con Apolline assiso che suona una cetra o
violino ed ammaestra nel suono, nel canto le
nove Muse figlie di Giove e di Mnemosine; a
sinistra stanno cinque Muse mutilate, vestite
di panneggiamenti classici: una con strumento
musicale, altra con specchio: a destra le altre
quattro pure mutilate in varii atteggiamenti.
Sono buone sculture assai diligentate nello
stile del primo Rinascimento. Sulla parete
opposta (fig. 5) è figurata la storia di Andro
meda figlia di Cefeo re di Etiopia e di Cassiope,
la quale essendosi vantata di superare in bel
lezza le Nereidi. queste presero Andromeda e
la legarono ad uno scoglio perchè divenisse
preda del mostro marino; ma Perseo figlio di
Giove e di Danae armato della testa di Me
dusa. salito sull'alato cavallo Pegaso, si portò
sul monte Elicona, poi affrontò il mostro che
uccise. Cefeo con Cassiope assiste a questo
fatto e riconoscente per la figlia salvata, la
dà in sposa all'eroe: una nave sul mare ondoso
li aspetta per condurli alla reggia. A destra
Perseo con i calzari alati affronta la Gorgone
anguicrinita; i corpi ignudi di Andromeda e
quello della Gorgone sono assai bene modellati;
gli atteggiamenti di Perseo assai energici; la
composizione più spaziata della precedente è
pure lavorata cou grande diligenza. Queste
storie dimostrano le tendenze umanistiche
dell'epoca e sono desunte dagli autori classici;
Ovidio descrive meravigliosamente la storia
di Perseo nel libro IV delle sue
Metamorfosi.
Pietro Tocsea (Torino-Bergamo 1911) stima
che questi pregevoli bassorilievi del principio
del Cinquecento accennino a decisi caratteri
di scuola Lombarda; infatti essi ricordano lo
stile dcM’Amadeo (1447-1522), del Bambaia
(1483-1548) o delle loro scuole: le differenze
delle due sculture pare si debbano ascrivere,
piuttosto che a diversità di scuole o botteghe,
a due diversi scultori.
Sopra una delie pami uiiuuri
legge is
seguente iscrizione su targa in forma di ves
sillo romano, in bellissime lettere capitali
6):


















