
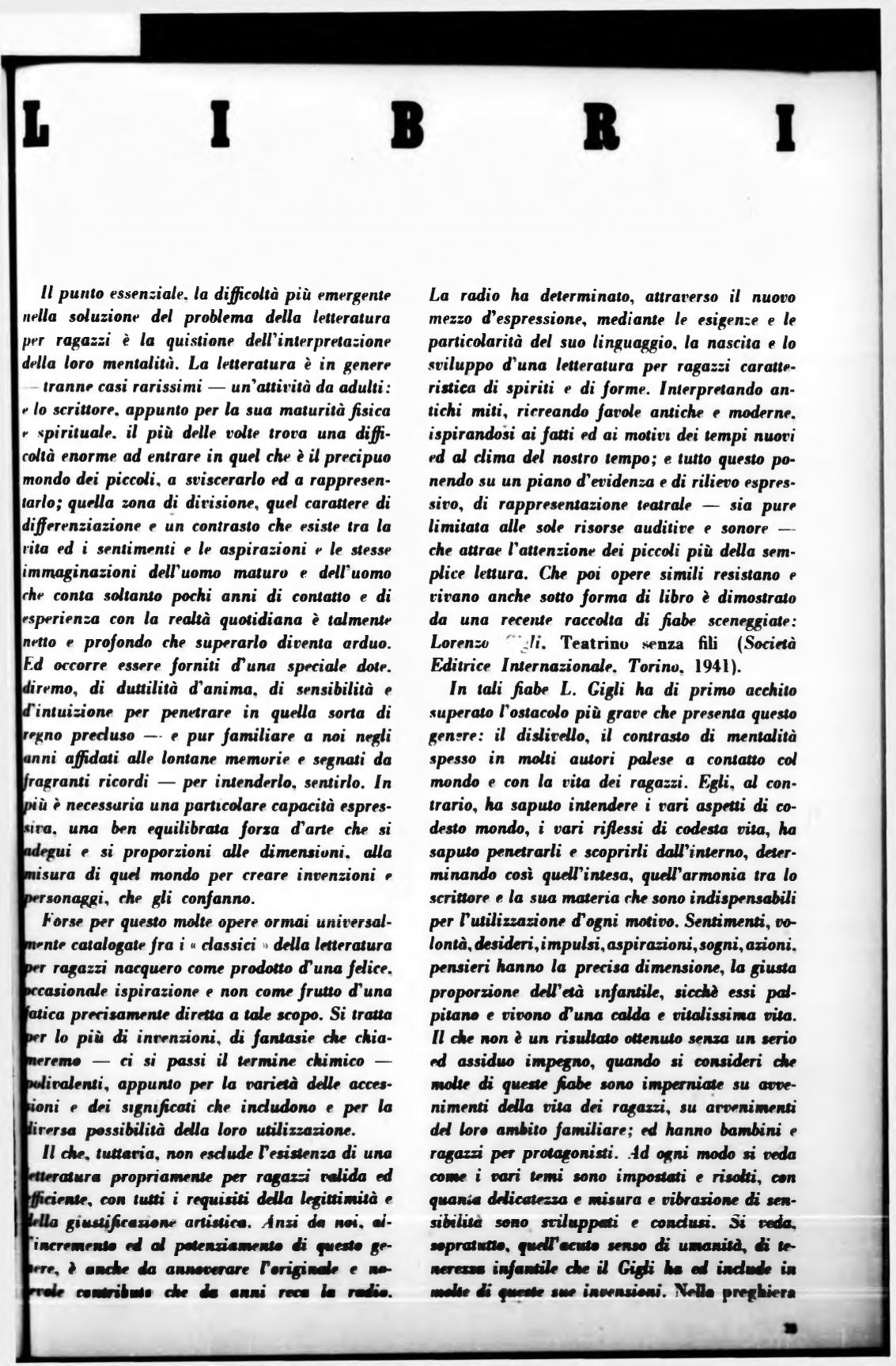
I l punto essenziale, la difficoltà più emergente
nella soluzione del problema della letteratura
per ragazzi è la quistione deir interpretazione
della loro mentalità. La letteratura è in genere
tranne casi rarissimi
—
un'attività da adulti:
»• lo scrittore, appunto per la sua maturità fisica
r
spirituale, il più delle volte trova una diffi
coltà enorme ad entrare in quel che è il precipuo
mondo dei piccoli, a sviscerarlo ed a rappresen
tarlo; quella zona di divisione, quel carattere di
differenziazione e un contrasto che esiste tra la
vita ed i sentimenti e le aspirazioni e le stesse
immaginazioni delVuomo maturo e dell'uomo
che conta soltanto pochi anni di contatto e di
esperienza con la realtà quotidiana è talmente
netto e profondo che superarlo diventa arduo.
Ed occorre essere forn iti d'uno speciale dote,
iremo, di duttilità d'anima, di sensibilità e
intuizione per penetrare in quella sorta di
regno precluso
—
e pur familiare a noi negli
nni affidati alle lontane memorie e segnati da
ragranti ricordi
—
per intenderlo, sentirlo. In
iù è necessaria una particolare capacità espres
sa. una ben equilibrata forza d'arte che si
ui e si proporzioni alle dimensioni, alla
isura di quel mondo per creare invenzioni e
rsonaggi, che gli confanno.
Forse per questo molte opere ormai universal-
rnte catalogate fra i
«
classici
»
della letteratura
r
ragazzi nacquero come prodotto d'uno felice,
casionale ispirazione e non come frutto d'uno
atica precisamente diretta a tale scopo. Si tratta
~r lo più di invenzioni, di fantasie che chia-
eremo
—
ci si passi il termine chimico
—
i valenti, appunto per la varietà delle acces-
oni e dei significati che includono e per la
iversa possibilità della loro utilizzazione.
I l che, tuttavia, non esclude resistenza di una
ratura propriamente per ragazzi valida ed
iente. con tutti i requisiti della legittimità e
■
gì unificanon*- artistico. Anzi dm noi, ai-
incremento ed al potenziamento di questo ge-
re. è anche dm annoverare roriginale e no-
comtr ibmts che dm mmmi rocm Im rodio.
La radio ha determinato, attraverso il nuovo
mezzo d'espressione, mediante le esigenze e le
particolarità del suo linguaggio, la nascita e lo
sviluppo d'una letteratura per ragazzi caratte
ristica di spiriti e di forme. Interpretando an
tichi miti, ricreando favole antiche e moderne,
ispirandosi ai fatti ed ai motivi dei tempi nuovi
ed al clima del nostro tempo; e tutto questo po
nendo su un piano d'evidenza e di rilievo espres
sivo, di rappresentazione teatrale
—
sia pure
limitata alle sole risorse auditive e sonore
—
che attrae l'attenzione dei piccoli più della sem
plice lettura. Che poi opere simili resistano e
vivano anche sotto forma di libro è dimostrato
da una recente raccolta di fiabe sceneggiate:
Lorenzo
07i. Teatrino senza fili
( Società
Editrice Internazionale. Torino.
1941).
In tali fiabe L. Gigli ha di primo acchito
superato l'ostacolo più grave che presenta questo
genzre: il dislivello, il contrasto di mentalità
spesso in molti autori palese a contatto col
mondo e con la vita dei ragazzi. Egli, al con
trario, ha saputo intendere i vari aspetti di co-
desto mondo, i vari riflessi di codesta vita, ha
saputo penetrarli e scoprirli dall'interno, deter
minando così quell'intesa, quell'armonia tra lo
scrittore e la sua materia che sono indispensabili
per l'utilizzazione d'ogni motivo. Sentimenti, vo
lontà, desideri,impulsi, aspirazioni, sogni, azioni,
pensieri hanno la precisa dimensione, la giusta
proporzione dell'età infantile, sicché essi pal
pitano e vivono d'una calda e vitalissima vita.
I l che non è un risultato ottenuto senza un serio
ed assiduo impegno, quando si consideri die
molte di queste fiabe sono imperniate su avve
nimenti deila vita dei ragazzi, su avvenimenti
del loro ambito familiare; ed hanno bambini e
ragazzi per protagonisti. Ad ogni modo si veda
come i vari temi sono impostati e risolti, con
quania delicatezza e misura e vibrazione di sen
sibilità sono sviluppati e conclusi. S i veda,
sopratutto, quelTacuto senso di ummnitò, di te
nerezza i nfmntile che il Gigli km ed indmde im
oselle di qmeote sme imoemsiomi.
N<*fli preghiera


















