
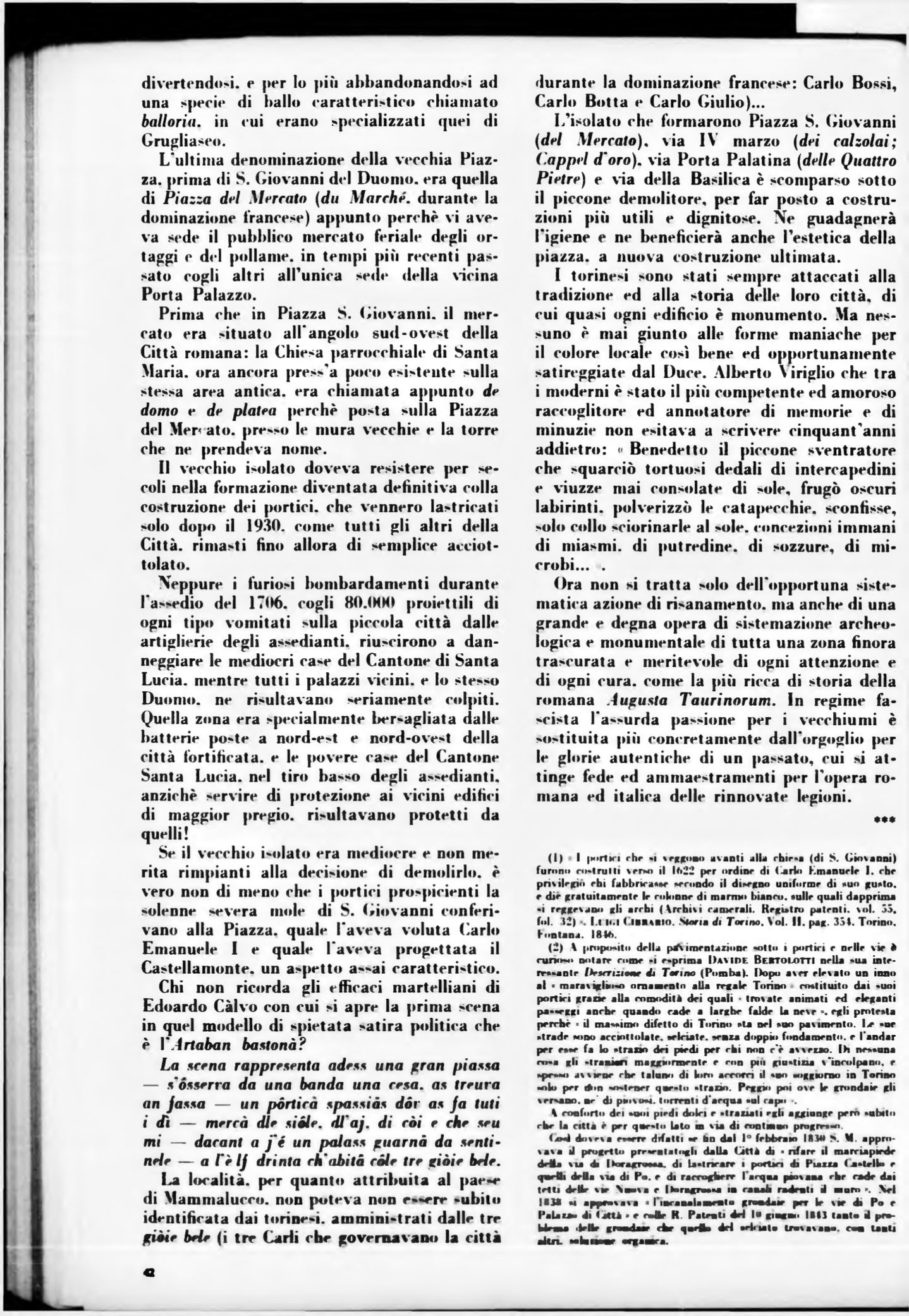
divertendosi, e per lo più abbandonandoci ad
una specie di ballo caratteristico chiamato
balloria.
in cui erano specializzati quei di
Grugliaseo.
L'ultima denominazione della vecchia Piaz
za. prima di S. Giovanni del Duomo, era quella
di
Piazza del Mercato
(du Marche,
durante la
dominazione francese) appunto perchè vi ave
va sede il pubblico mercato feriale degli or
taggi e del pollame, in tempi più recenti pas
sato cogli altri all’unica sede della vicina
Porta Palazzo.
Prima che in Piazza S. Giovanni, il mer
cato era >ituato all'angolo sud-ovest della
Città romana: la Chiesa parrocchiale di Santa
Maria, ora ancora press’a poeti esistente sulla
stessa area antica, era chiamata appunto
de
domo
e
de platea
perchè posta sulla Piazza
del Men ato, presso le mura vecchie e la torre
che ne prendeva nome.
Il
vecchio isolato doveva resistere per se
coli nella formazione diventata definitiva colla
costruzione dei portici, che vennero la>tricati
solo dopo il 1930. come tutti gli altri della
Città, rimasti fino allora di semplice acciot
tolato.
Neppure i furiosi bombardamenti durante
l'assedio del 1706. cogli 80.000 proiettili di
ogni tipo vomitati sulla piccola città dalle
artiglierie degli assediami, riunirono a dan
neggiare le mediocri case del Cantone di Santa
Lucia, mentre tutti i palazzi vicini, e lo stesso
Duomo, ne risultavano seriamente colpiti.
Quella zona era specialmente bersagliata dalle
batterie po;»te a nord-est e nord-ovest della
città fortificata, e le povere ca>e del Cantone
Santa Lucia, nel tiro basso degli a>sedianti,
anziché servire di protezione ai vicini edifici
di maggior pregio, risultavano protetti da
quelli!
Se il vecchio isolato era mediocre e non me
rita rimpianti alla decisione di demolirlo, è
vero non di meno che i portici prospicienti la
solenne severa mole di S. Giovanni conferi
vano alla Piazza, quale l'aveva voluta Carlo
Emanuele I e quale l'aveva progettata il
Castellamonte. un a>petto assai caratteristico.
Chi non ricorda gli efficaci martelliani di
Edoardo Càlvo con cui si apre la prima scena
in quel modello di spietata satira politica che
è
I
'Artaban bastonò?
La scena rappresenta adess una pran piassa
—
s'osserva da una banda una cesa, as treuva
an ja ssa
—
un pèrtica spassiòs dóv as fa tuti
i dì
—
mercà die sióle. dl'aj. di eòi e che seu
mi
—
dacant a j 'é un pedass puarnò da senti
-
nele
—
a l ' è l j drinta ch'abitò còle tre giòie bete.
La località, per quanto attribuita al pae«e
di Mammalucco, non poteva non e««*cre -ubilo
identificata dai torinesi, amministrati dalle tre
giòie bete
(i tre Carli che governavano la città
durante la dominazione francese: Carlo Bossi,
Cariti Botta e Carlo Giulio)...
I/isolato che formarono Piazza S. Giovanni
(del Mercato
), via IV marzo
(dei calzolai;
Cappel d'oro),
via Porta Palatina
(delle Quattro
Pietre)
e via della Basilica è scomparso sotto
il piccone demolitore, per far posto a costru
zioni più utili e dignitose. Ne guadagnerà
l’igiene e ne benefieierà anche l’estetica della
piazza, a nuova costruzione ultimata.
I
torinesi sono stati sempre attaccati all
tradizione ed alla storia delle loro città, di
cui quasi ogni edificio è monumento. Ma nes
suno è mai giunto alle forme maniache per
il colore locale così bene ed opportunamente
satireggiate dal Duce. Alberto \ iriglio che tra
i moderni è stato il più competente ed amoroso
raccoglitore ed annotatore di memorie e di
minuzie non esitava a scrivere cinquant’anni
addietro: « Benedetto il piccone sventratore
che squarciò tortuosi dedali di intercapedini
e viuzze mai consolate di sole, frugò oscuri
labirinti, polverizzò le catapecchie, sconfisse,
solo collo sciorinarle al >oIe. concezioni immani
di miasmi, di putredine, di sozzure, di mi
crobi... .
Ora non si tratta solo dell'opportuna siste
matica azione di risanamento, ma anche di una
grande e degna opera di sistemazione archeo
logica e monumentale di tutta una zona finora
trascurata e meritevole di ogni attenzione e
di ogni cura, come la più ricca di storia della
romana
Augusta Taurinorum.
In regime fa
scista l'assurda passione per i vecchiumi è
>o>tituita più concretamente dall'orgoglio per
le glorie autentiche di un passato, cui si at
tinge fede ed ammaestramenti per l’opera ro
mana ed italica delle rinnovate legioni.
**•
(1) I |H>rtiri che «i veggono a v a n ti alla ch ir-a (di S. G iovanni)
furono co» tru tti verno il lf
>22
p rr ordine di C-arl» K m anu rlr I. rh r
privilegio rh i fab b ricati* «econdo il disegno uniforme di «un guitto,
r d ir g ra tu itam e n te Ir ro lo n n r di m arm o bianco. nulle quali d ap p rim a
«i reggevano gli archi (A rc h iti ram rra li. R egistro p a trn ti. voi. 55.
fol. 12) I.t ii.i ( i b r v r i o . Storia
di Torino.
Voi. II. pag. 354. Torino,
h o n ta n a . 1846.
(2) A proposito d rlla pifv im rn taz io n r -o tto i portici r nt-Ile vie
è
ru rn H i n o tare com r -i r-p n m a
D a v i d e B e i t o l o t t i
n rlla «ua inte-
rr«« an tr
Itrsrrizionr di Torino
(P om ba). Uopo a \ r r elevato un inno
a l • marav iglio«o o rnam ento alla regale Torino rm titu ito d ai «uni
po rtici g ra n e alla com odità dei qu ali ■trov ate anim ati ed eleganti
pa»«eggi anche quando ra d e a larghe falde la neve *. egli p ro testa
perché • il maw iim i d ifetto di Torino »ta nel mio pavim ento. I
jr
«ue
«trade «odo accio tto late, ■ rlriatr. senza doppio fondam ento, e l'a n d a r
per rw f fa lo tir a n o dei piedi p rr rh i non c'è avvezzo. Ih nn>«una
co«a gli « tran ian m aggiorm ente e con piti giustizia v'incolpano, r
*pr»«o avviene rh e talu n o di loro accorri il «uo «oggiorno in Torino
« ila per itm ««-tener q u r-to «trazio. Prggio poi ove ir g ro n d air gli
v rrsan o . ne' di piovo»!. to rre n ti d 'a rq u a *ul capo •.
% conforto dei «uoi piedi dolci r « fra n a ti egli aggiunge pero «ubilo
che la c ittà è per qur*to lato in via di ron tm uo progrc«o.
( ìh I doveva e««ere «Matti «e bn dal 1° febbraio I8W >. M. appro
vava il progetto p reno tatogli dalla C ittà di • rifare il m arriapirdr
della via di lloragruMa. di Li«Iorare i portici di Piazza <-a«trllo e
quelli drlla via di Po. r di ramogferrr I acqua piovana rh r rade dai
t r iti drllr vie Nuova r |loragro*«a in ranali radenti il muro •. Nel
IHUt «i approvava • I incanalamento grondaie per Ir vie di Po e
Palazzo di ( i t t i •
t
rotte K. Patenti del lo giugni 1844 tan to il pro
blema .Ielle grondaie
rhr
quello del »e|. iato trovavano, eoa U n ti
a itn . min mine organica.
42


















