
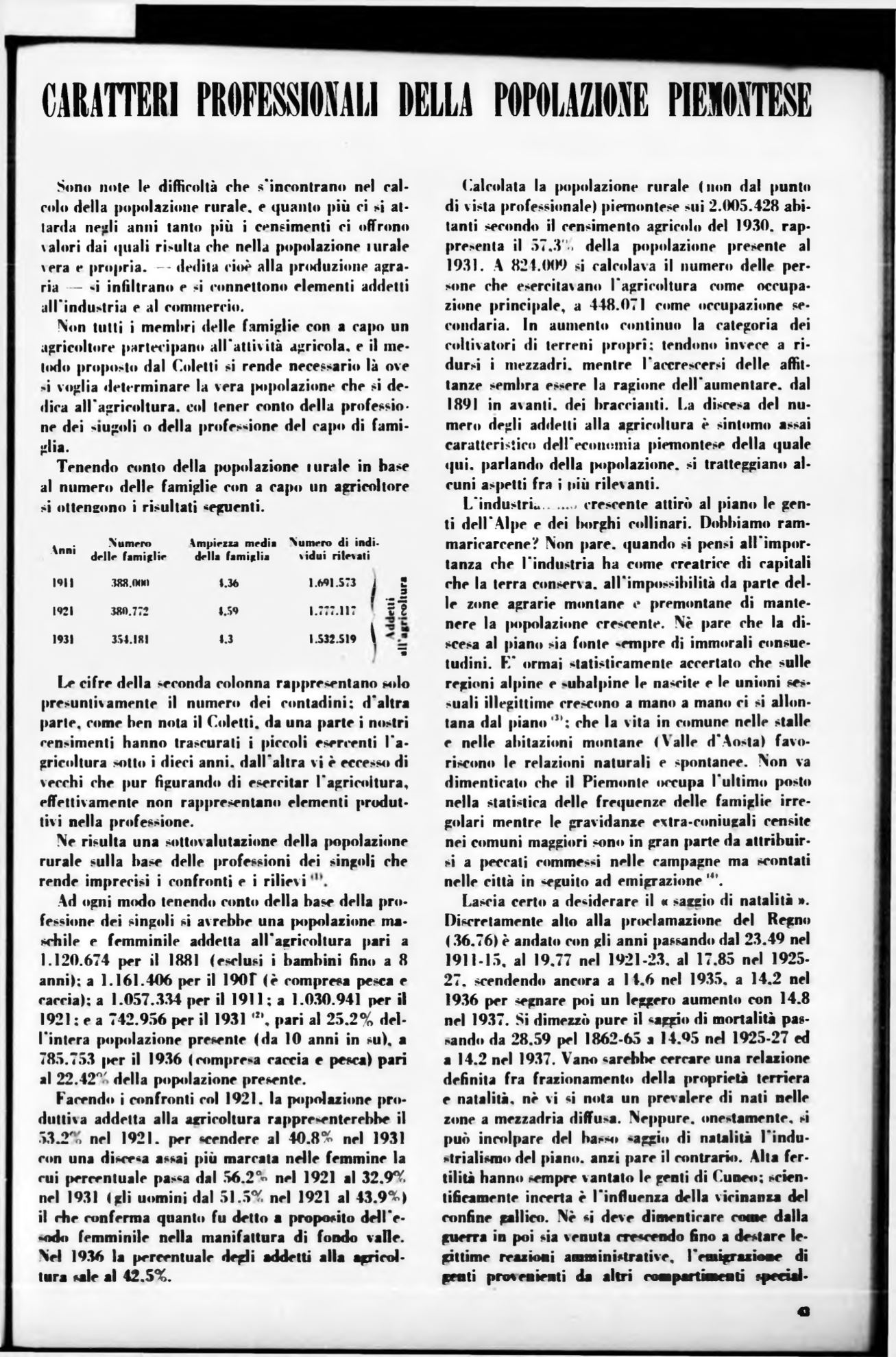
CARATERI PRIMOMIJ DELA POPMWE P IEM ÌE
Sono note le difficoltà che s'incontrano nel cal
colo della popolazione rurale, e quanto più ci si at
tarda ne*rli anni tanto più i censimenti ci offrono
\alori dai quali risulta che nella popolazione i tirale
>era e propria. — dedita cioè alla produzione agra
ria — 'i infiltrano e si connettono elementi addetti
all'industria e al commercio.
Non tutti i membri delle famiglie con a capo un
agricoltore partecipano all'attività agricola, e il me
todo proposto dal Coletti si rende necessario là ove
»i voglia determinare la vera popolazione che si de
dica aH'agricoltura. col tener conto della professio
ne dei Mugoli o della professione del capo di fami
glia.
Tenendo conto della popolazione turale in base
al numero delle famiglie con a capo un agricoltore
si ottengono i risultati seguenti.
Anni
Num rr»
Xmpirzza media Numero di indi-
d r llr fam iplir
drlla famiglia
\id u i ritm ali
1911
m n o ii
1.36
1.691.573
ì
■E3
1*21
380.772
4.59
1.777.117 *
1
i l
1931
354.181
4.3
1.532.519 \
“3
Le cifre della seconda colonna rappresentano solo
presuntivamente il numero dei contadini: d'altra
parte, come hen nota il Coletti, da una parte i nostri
cedimenti hanno trascurati i piccoli esercenti l'a
gricoltura sotto i dieci anni, dall'altra vi è eccesso di
vecchi che pur figurando di esercitar l'agricoltura,
effettivamente non rappresentano elementi produt
tivi nella professione.
Ne risulta una sottovalutazione della popolazione
rurale sulla hase delle professioni dei singoli che
rende imprecisi i confronti e i rilievi
Ad ogni modo tenendo conto della hase della pro
fessione dei singoli si avrebbe una popolazione ma
schile e femminile addetta all'agricoltura pari a
1.120.674 per il 1881 (esclusi i bambini fino a 8
anni): a 1.161.406 per il 1901" (è compresa pesca e
caccia): a 1.057.334 per il 1911 ; a 1.030.941 per il
1921 : e a 742.956 per il 1931 m, pari al 25.2% del
l'intera popolazione presente (da 10 anni in su), a
785.753 |K*r il 1936 (compresa caccia e pesca) pari
al 22.42°' della popolazione presente.
Facendo j confronti col 1921. la popolazione pro
duttiva addetta alla agricoltura rappresenterebbe il
33*2*0 nel 1921. per «cendere al 40.8% nel 1931
con una discesa assai più marcata nelle femmine la
cui percentuale pas«a dal 56.2°« nel 1921 al 32.9*V.
nel 1931 (gli uomini dal 51..W. nel 1921 al 43.9%)
il che conferma quanto fu detto a proposito dell'e-
«odo femminile nella manifattura di fondo valle.
Nel 1936 la percentuale degli addetti alla agricol
tura sale al
42.5%.
Calcolata la popolazione rurale (non dal punto
di vista professionale) piemontese sui 2.005.428 abi
tanti secondo il censimento agricolo del 1930. rap
p r e s i la il 57.3"., della popolazione presente al
1931. A 824.009 si calcolava il numero delle per
sone che esercitavano l'agricoltura come occupa
zione principale, a 448.071 come occupazione se
condaria. In aumento continuo la categoria dei
coltivatori di terreni propri: tendono invece a ri
dursi i mezzadri, mentre l'accrescersi delle affit
tanze sembra essere la ragione deH'aumentare. dal
1891 in avanti, dei braccianti. La discesa del nu
mero degli addetti alla agricoltura è sintomo assai
caratteristico dell'economia piemontese della quale
«pii. parlando della |>opolazione. si tratteggiano al
cuni aspetti fra i t»iii rilevanti.
L'industrL........ crescente attirò al piano le gen
ti dell'Alpe e dei liorghi collinari. Dobbiamo ram
maricarcene? Non pare, quando si pensi all'impor
tanza che l'industria ha come creatrice di capitali
che la terra conserva, all'impossibilità da parte del
le zone agrarie montane e premontane di mante
nere la popolazione crescente. Nè pare che la di
scesa al piano sia fonte «empre di immorali consue
tudini. E* ormai statisticamente accertato che sulle
regioni alpine e «ubalpine le nascite e le unioni ses
suali illegittime crescono a mano a mano ci si allon
tana dal piano'1': che la vita in comune nelle stalle
e nelle abitazioni montane ( \ alle d'Aosta) favo
riscono le relazioni naturali e spontanee. Non va
dimenticato che il Piemonte occupa l'ultimo posto
nella statistica delle frequenze delle famiglie irre
golari mentre le gravidanze extra-coniugali censite
nei comuni maggiori sono in gran parte da attribuir
si a peccali commessi nelle campagne ma scontati
nelle città in seguito ad emigrazione ,4’.
Lascia certo a desiderare il « saegio di natalità ».
Discretamente alto alla proclamazione del Regno
( 36.76) è andato con gli anni passando dal 23.49 nel
1911-15, al 19.77 nel 1921-23, al 17.85 nel 1925-
27. scendendo ancora a 14.6 nel 1935. a 14.2 nel
1936 per segnare poi un leggero aumento con 14.8
nel 1937. Si dimezzò pure il «aggio di mortalità pas-
>ando da 28.59 pel 1862-65 a 14.05 nel 1925-27 ed
a 14.2 nel 1937. Vano «arebbe cercare una relazione
definita fra frazionamento della proprietà terriera
e natalità, nè vi si nota un prevalere di nati nelle
zone a mezzadria diffusa. Neppure. one>tamente, si
può incolpare del ha?>so «aggio di natalità l'indù-
otrialismo del piano, anzi pare il contrario. Alta fer
tilità hanno sempre vantato le genti di Cuneo: scien
tificamente incerta è l'influenza della vicinanza del
confine gallico. Nè si deve dimenticare come dalla
guerra in poi sia venuta crescendo fino a destare le
gittime reazioni amministrative, l'emigrazione di
grati provenienti da altri compartimenti special*
41


















