
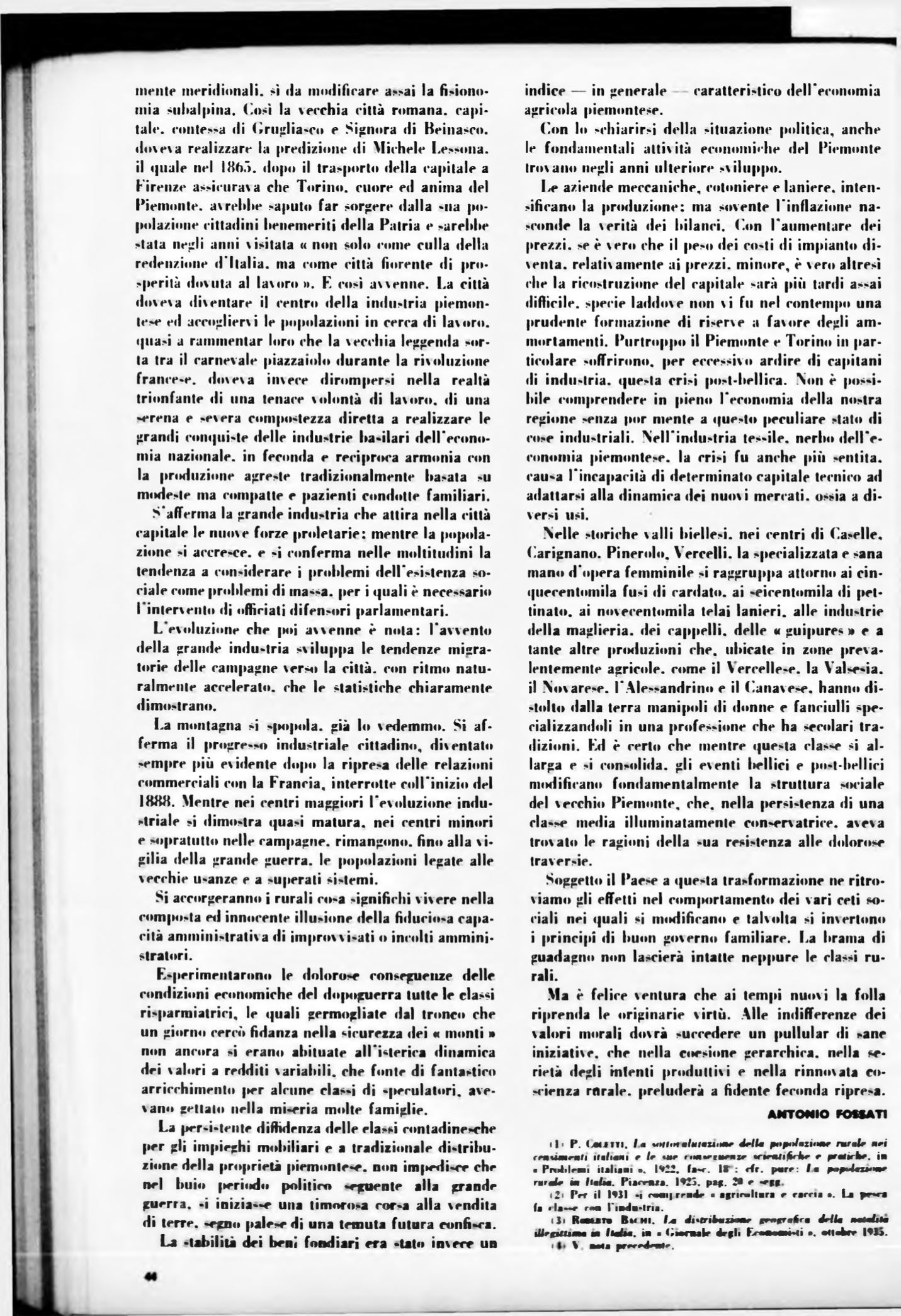
mente meridionali, sì da modificare assai la fisiono
mia subalpina. Così la vecchia città romana, capi
tale. con te sa di Grugliasco
e
Signora di Beinasco.
d o \e \a realizzare la predizione di Michele Lenona ,
il quale nel IHò.">. dopo il trasporto della rapitale a
Firenze assicurava che Torino, cuore ed anima ilei
Piemonte, avrebbe saputo far sorgere dalla »iia po
polazione cittadini benemeriti della Patria e sarebbe
stata negli anni visitata « non solo come culla della
redenzione d'Italia, ma come città fiorente di pro
sperità dovuta al lavoro» . F così aw enn e . La città
dove\a diventare il centro della industria piemon
tese
ed accogliervi le popolazioni in cerca di lavoro,
quasi a rammentar loro che la \ecc liia leggenda sor
ta tra il carnevale piazzando durante la rivoluzione
france-c. d o \e \a invece dirompersi nella realtà
trionfante di una tenace volontà di lavoro, di una
*erena e severa compostezza diretta a realizzare le
grandi conquiste delle industrie basilari dell'econo
mia nazionale, in feconda e reciproca armonia con
la produzione agreste tradizionalmente basata su
modeste ma compatte e pazienti condotte familiari.
S'afferma la grande industria che attira nella città
capitale le nuove forze proletarie: mentre la popola
zione si accresce, e si conferma nelle moltitudini la
tendenza a considerare i problemi dell'esistenza so
ciale come problemi di ina^a. per i quali è necessario
I intervento di officiati difensori parlamentari.
L evoluzione che poi avvenne è nota: l'avvento
della grande industria sviluppa le tendenze migra
torie delle campagne verso la città, con ritmo natu
ralmente accelerato, che le statistiche chiaramente
dimostrano.
l>a montagna si s|»opola. già lo vedemmo. Si af
ferma il progresso industriale cittadino, diventato
sempre più evidente dopo la ripresa delle relazioni
commerciali con la Francia, interrotte co ll'in izio del
IWW. Mentre nei centri maggiori l'evoluzione indu
striale si dimostra quasi matura, nei centri minori
e sopratutto nelle campagne, rimangono, fino alla vi
gilia della grande guerra, le popolazioni legate alle
vecchie Usanze e a superali sistemi.
Si accorgeranno i rurali cosa significhi vivere nella
composta ed innocente illusione della fiduciosa capa
cità amministrativa di improvvisati o incolti ammini
stratori.
K'perimentarono le dolorose conseguenze delle
condizioni economiche del dopoguerra tutte le classi
risparmiatrici, le quali germogliate dal tronco che
un giorno cercò fidanza nella sicurezza dei « monti »
non ancora si erano abituate all'i*terica dinamica
dei vali •ri a redditi variabili, che fonte di fantastico
arricchimento |*er alcune clas»i di speculatori, ave
vano gettalo nella miseria molte famiglie.
La persistente diffidenza delle classi contadinesche
per gli impieghi mobiliari e a tradizionale distribu
zione della proprietà piemontese, non im|»edi*ec che
nel buio |»criodo politico «cruente alla grande
guerra, -i iniziasse una timorosa ror-a alla vendita
di terre, «cgno palese di una temuta futura confisca.
La stabiliti dei beni fondiari era «tato invece un
indice — in generale
caratteristico dell'economia
agricola piemontese.
Con lo schiarirsi della situazione politica, anche
le fondamentali attività econom iche del Piemonte
trovano negli anni ulteriore sviluppo.
Le aziende meccaniche, cotoniere e laniere, inten
sificano la produzione: ma sovente l'inflazione na
sconde la verità dei bilanci, don l'aumentare dei
prezzi, se
è
vero che il peso dei co«ti di impianto d i
venta. relativamente ai prezzi, m inore,
è
vero altresì
d ie la ricostruzione del capitale sarà più tardi assai
difficile, specie laddove non vi fu nel contempo una
prudente formazione di riserve a favore degli am
mortamenti. Purtroppo il Piemonte e Torino in par
ticolare soffrirono, per eccessivo ardire di capitani
di industria, questa crisi post-bellica. Non
è p o s s i
bile comprendere in pieno l'economia della nostra
regione senza por niente a questo peculiare stato di
cose industriali. Nell'industria tessile, nerbo d e ll'e
conomia piemontese, la crisi fu anche più sentita,
causa l'incapacità di determinato capitale tecnico ad
adattarsi alla dinamica dei nuovi mercati, ossia a d i
versi usi.
N elle storiche valli b iellesi. nei centri di Caselle,
(larignano. Pinerolo. Vercelli, la specializzata e sana
mano d'opera femm in ile si raggruppa attorno ai cin-
quecentomila
fusi
di cardato, ai scicentomila di pet
tinato. ai novecentomila telai lan ieri, alle industrie
della maglieria, dei cappelli, delle « guipures » e a
tante altre produzioni che. ubicate in zone preva
lentemente agricole, come il \e r c e lle « e . la Valse*ia.
il Novarese,
l '
Alessandrino
e
il Canavese. hanno d i
stolto
dalla terra manipoli di donne e fanciulli
sp e
cializzandoli in una professione che ha secolari tra
d izioni. Ed è certo che mentre questa classe si a l
larga e si consolida, gli eventi bellici e
post-bellici
n id ifican o fondamentalmente la struttura sociale
del vecchio Piemonte, che. nella persistenza di una
classe media illuminatamente conservatrice, aveva
trovato le ragioni della
sua
resistenza alle dolorose
traversie.
Soggetto il Paese a questa trasformazione ne ritro
viamo gli effetti nel comportamento dei vari ceti so
ciali nei quali si modificano e talvolta si invertono
i principi di buon governo fam iliare. La brama di
guadagno non lascierà intatte neppure le classi ru
rali.
Ma è felice ventura che ai tempi nuovi la folla
riprenda le originarie virtù. Alle indifferenze dei
valori morali dovrà succedere un pullular di sane
iniziative, che nella coesione gerarchica, nella se
rietà degli intenti produttivi e nella rinnovata co
scienza rnrale. preluderà a fidente feconda ripresa.
ANTON IO FOSSATI
1
1
1
P.
( J O I T I .
In
uifftrt
atmaziimr Arila pttpttlaxiimr ruralr nri
cmùmrmti italiani r Ir \ur ><nt*rzurnzr *rirmltfirhr r pratichr.
in
• Pn4»lrtni italiani ». I» !!. fax-, i r :
rfr. purr : l a pnpulazumr
ruralr im Italia.
Piarrmia. 1*23. p if. 2*
r -rfr
l 2‘
Prr il 1911 -I roni| rrn ilr « agricoltura
r
rama •. La p rx -l
(a «la—«■
rnm
l'indo-tria.
I l i
Ramata
K « I m i.
l-a iH*tribuxi*mr
g m FTatrm
drlla malattia
lUrgutima
m
limita,
in • (ÌM raalr d rfli E*— — iati ». «tlnW» IW».
>
V
M a
frrrrAm Ir.


















