
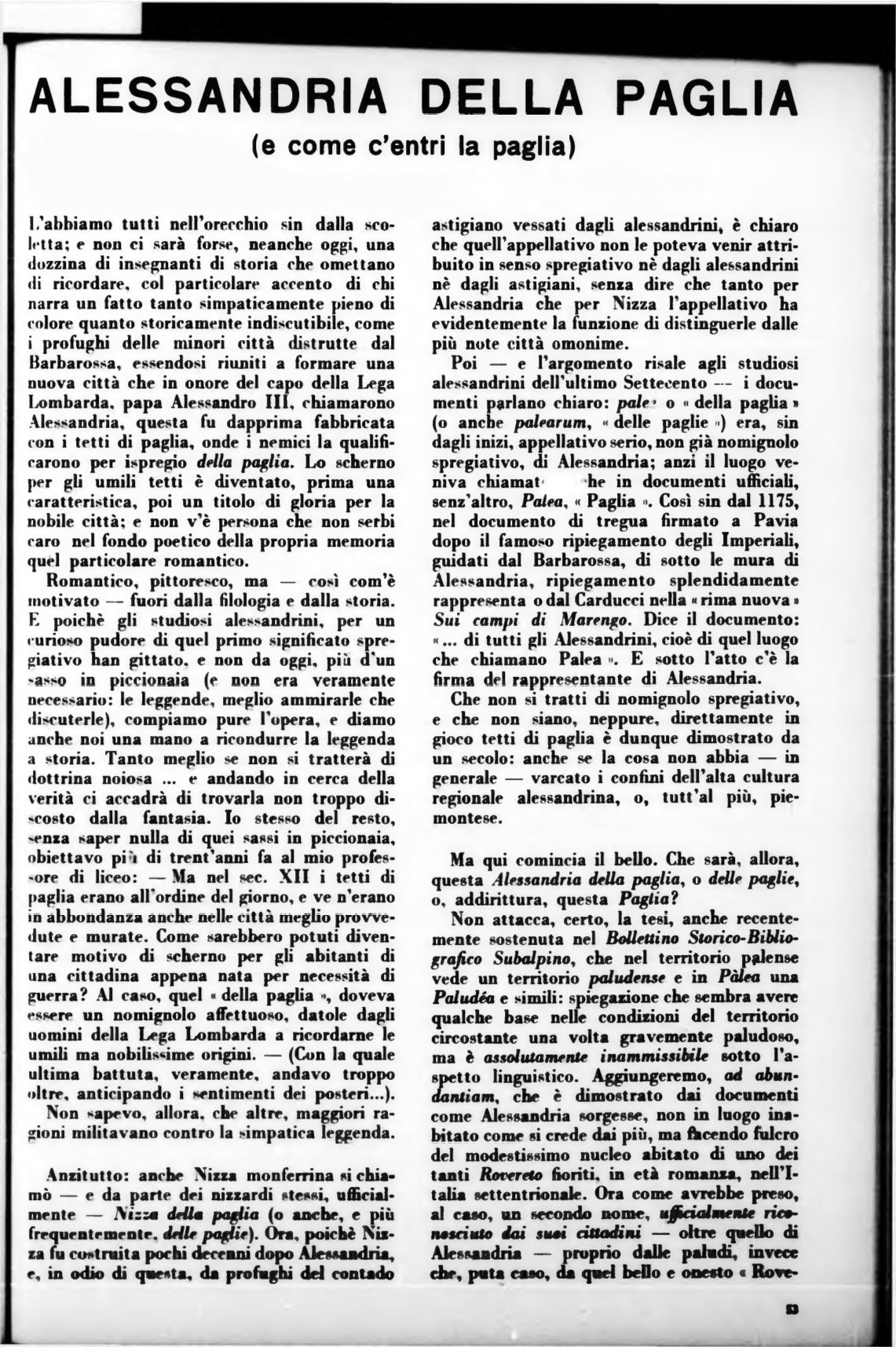
ALESSANDRIA DELLA PAGLIA
(e come c’entri la paglia)
I/abbiamo tu tti nell'orecchio sin dalla sco-
Irtta; e non ci sarà forse, neanche oggi, una
dozzina di insegnanti di storia che omettano
di ricordare, col particolare accento di chi
narra un fatto tanto simpaticamente pieno di
colore quanto storicamente indiscutibile, come
i profughi delle minori città distrutte dal
Barbarossa, essendosi riuniti a formare una
nuova città che in onore del capo della Lega
Lombarda, papa Alessandro III, chiamarono
Alessandria, questa fu dapprima fabbricata
con i tetti di paglia, onde i nemici la qualifi-
carono per ispregio
della paglia.
Lo scherno
per gli umili tetti è diventato, prima una
caratteristica, poi un titolo di gloria per la
nobile città; e non v ’è persona che non serbi
caro nel fondo poetico della propria memoria
quel particolare romantico.
Romantico, pittoresco, ma — così com’è
motivato — fuori dalla filologia e dalla storia.
E poiché gli studiosi alessandrini, per un
curioso pudore di quel primo significato spre
giativo han gittato. e non da oggi, più d'un
-asso in piccionaia (e non era veramente
necessario: le leggende, meglio ammirarle che
discuterle), compiamo pure l'opera, e diamo
anche noi una mano a ricondurre la leggenda
a storia. Tanto meglio se non si tratterà di
dottrina noiosa ... e andando in cerca della
verità ci accadrà di trovarla non troppo di-
>costo dalla fantasia. Io stesso del resto,
-enza saper nulla di quei sassi in piccionaia,
obiettavo pi di trent'anni fa al mio profes-
-ore di liceo: — Ma nel sec. XII i tetti di
paglia erano all'ordine del giorno, e ve n'erano
in abbondanza anche nelle città meglio provve
dute e murate. Come sarebbero potuti diven
tare motivo di scherno per gli abitanti di
una cittadina appena nata per necessità di
guerra? Al caso, quel « della paglia ■>, doveva
essere un nomignolo affettuoso, datole dagli
uomini della Lega Lombarda a ricordarne le
umili ma nobilissime origini. — (Con la quale
ultima battuta, veramente, andavo troppo
oltre, anticipando i sentimenti dei posteri...).
Non sapevo, allora, che altre, maggiori ra
gioni militavano contro la simpatica leggenda.
Anzitutto: anche Nizza monferrina si chia
mò — e da parte dei nizzardi stessi, ufficial
mente —
R izza drlla paglia
(o anche, e più
frequentemente,
delle paglie).
Ora, poiché Niz
za fu costruita pochi decenni dopo Alessandria,
e, in odio di questa, da profughi del contado
astigiano vessati dagli alessandrini, è chiaro
che quell'appellativo non le poteva venir attri
buito in senso spregiativo nè dagli alessandrini
nè dagli astigiani, senza dire che tanto per
Alessandria che per Nizza l'appellativo ha
evidentemente la funzione di distinguerle dalle
più note città omonime.
Poi — e l'argomento risale agli studiosi
alessandrini dell'ultimo Settecento — i docu
menti parlano chiaro:
pale •
o « della paglia »
(o anche
palearum
, « delle paglie ") era, sin
dagli inizi, appellativo serio, non già nomignolo
spregiativo, di Alessandria; anzi il luogo ve
niva chiamat'
he in documenti ufficiali,
senz'altro, Poiea, « Paglia ». Così sin dal 1175,
nel documento di tregua firmato a Pavia
dopo il famoso ripiegamento degli Imperiali,
guidati dal Barbarossa, di sotto le mura di
Alessandria, ripiegamento splendidamente
rappresenta o dal Carducci nella «rima nuova »
Sui campi di Marengo.
Dice il documento:
«... di tutti gli Alessandrini, cioè di quel luogo
che chiamano Palea ». E sotto l'atto c'è la
firma del rappresentante di Alessandria.
Che non si tratti di nomignolo spregiativo,
e che non siano, neppure, direttamente in
gioco tetti di paglia è dunque dimostrato da
un secolo: anche se la cosa non abbia — in
generale — varcato i confini dell'alta cultura
regionale alessandrina, o, tutt'al più, pie
montese.
Ma qui comincia il bello. Che sarà, allora,
questa
Alessandria della paglia
, o
delle paglie
,
o, addirittura, questa
Paglia
?
Non attacca, certo, la tesi, anche recente
mente sostenuta nel
Bollettino Storico-Biblio
grafico Subalpino
,
che nel territorio pjdense
vede un territorio
paludense
e in
Pàlea
una
Paludéa
e simili: spiegazione che sembra avere
qualche base nelle condizioni del territorio
circostante una volta gravemente paludoso,
ma
è assolutamente inammissibile
sotto l'a-
r
tto linguistico. Aggiungeremo,
ad abun-
itiam,
che
è
dimostrato dai documenti
come Alessandria sorgesse, non in luogo ina
bitato come si crede dai più, ma fticendo fulcro
del modestissimo nucleo abitato di uno dei
tanti
Rovereto
fioriti, in età romanza, nell'I
talia settentrionale. Ora come avrebbe preso,
al caso, un secondo nome,
ufficialmente rico
nosciuto dai suoi cittadin i
— oltre quello di
Alessandria — proprio dalle paludi, invece
che, puta caso, da quel bello e onesto « Rove
l i


















