
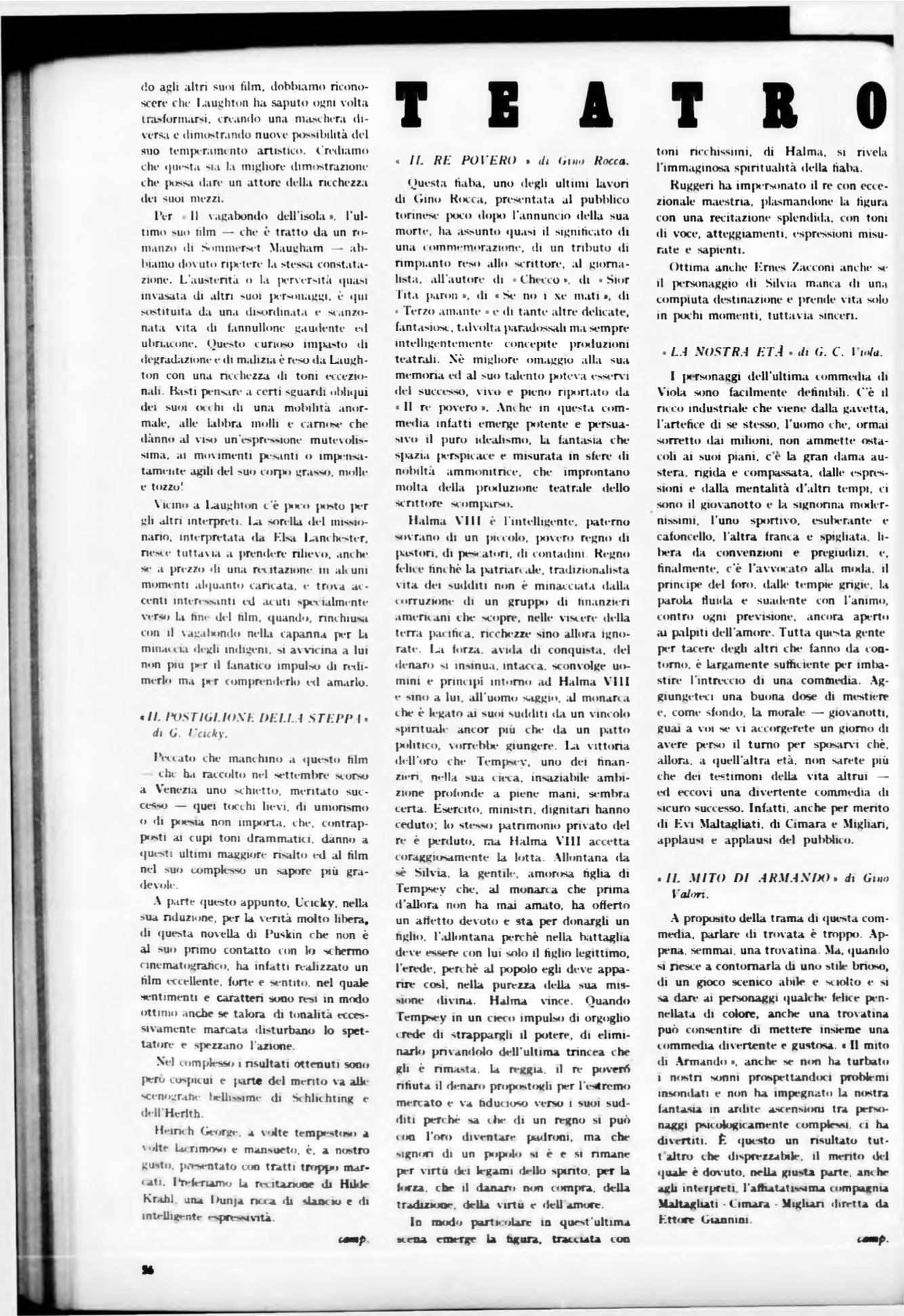
do agli altri suoi film, dobbiamo ricono
scere che Laughton ha saputo ogni volta
trasformarsi, creando una maschera di
versa e dimostrando nuove possibilità del
suo temperamento artistico. Crediamo
che questa sia la migliore dimostrazione
che possa dare un attore della ricchezza
dei suoi mezzi.
l ’er 11 vagabondo dell'isola ». l’ul
timo suo film — che è tratto da un ro
manzo di Sommerset Maugham — ab
biamo dovuto ripetere la stessa constata
zione. L’austerità o la perversità quasi
invasata di altri suoi personaggi,
è
qui
sostituita da una disordinata e se.inzo
nata vita di fannullone gaudente ed
ubriacone. Questo curioso impasto di
degradazione e di malizia è reso da Laugh-
ton con una ricchezza di toni eccezio
nali. Basti pensare a certi sguardi obliqui
dei suoi occhi di una mobilità anor
male, alle Libbra molli e carnose che
dànno al viso un’espressione mutevolis-
sima. ai movimenti pesanti o impensa
tamente agili del suo corpo grasso, molle
e tozzo!
Vicino a laughton c’è poco posto j>er
«li altri interpreti. L i sorella del missio
nario. interpretata da Klsa Lanchester,
riesce tuttavia a prendere rilievo, anche
se a prezzo di una recitazione in alcuni
momenti alquanto caricata, e trova ac
centi interessanti ed acuti specìalmente
verso la tini del tilm, quando, rinchiusi
con il vagaliondo nella capanna per Li
minaccia degli indigeni, si avvicina a lui
non più {» r il fanatico impulso di redi
merlo ma i*r comprenderlo ed amarlo.
• IL PO ST IG L IONE D ELLA S T E P P A
•
di G. Ucicky.
Peccato che manchino a questo tilm
che ha raccolto nel settembre scorso
a Venezia uno schietto, meritato suc
cesso — quei tocchi lievi, di umorismo
o di poesia non importa, che. contrap-
p«*sti ai cupi toni drammatici, dànno a
questi ultimi maggiore risalto ed al film
nel suo complesso un sapore più gra
devole.
A parte questo appunto. Ucicky. nella
sua riduzione, per la verità molto libera,
di questa novella di Puskin che non è
al suo primo contatto con lo schermo
cinematografico, ha infatti realizzato un
film eccellente, forte e sentito, nel quale
sentimenti e caratteri sono resi in modo
ottimo anche se talora di tonalità ecces
sivamente marcata disturbano lo spet
tatore e spezzano l’azione.
Nel complesso 1risultati ottenuti sono
pero cospicui e }>arte del mento va olk-
scenografie lielli-sime di Schlichting e
dell'Herlth.
Ht-iruh George, a volte tempestoso a
'"'Ite lacrimoso e mansueto, è. a nostro
gusto, presentato con tratti troppo mar
cati. iV-fenamo la recitazione di Htidr
Krahl una l>unja ricca di siane» e di
inte1utente espressività.
camp
T E A
«
IL R E POVERO
»
di Gino Rocca.
Questa fiaba, uno degli ultimi lavori
di Gino Rocca, presentata al pubblico
torinese poco dopo l'annuncio della sua
morte, ha assunto quasi il significato di
una commemorazione, di un tributo di
rimpianto reso allo scrittore, al giorna
lista, all’autore di «Chi cco ». di *Sior
Tita paron ». di «Se- no 1 xe mati ». ili
«Terzo amante »e di tante altre delicate,
fantasiose, talvolta paradossali ma sempre
intelligentemente concepite produzioni
teatrali. Nè migliore omaggio alla sua
memoria ed al suo talento poteva esservi
del successo, vivo e pieno riportato da
«
11
re povero ». Anche in questa com
media infatti emerge potente e persua
sivi» il puro idealismo, la fantasia che
spazia perspicace e misurata in sfere di
nobiltà ammonitrice, che improntano
molta della produzione teatrale dello
scrittore scomparso.
Halma
V i l i
è l’intelligente, paterno
sovrano di un piccolo, povero regno di
pastori, di pescatori, di contadini. Regno
felice finché la patriarcale, tradizionalista
vita dei sudditi non è minacciata dalla
corruzione di un gruppo di finanzieri
americani clic- scopre, nelle viscere della
terra pacifica, ricchezze sino allora igno
rate. La forza, avida di conquista, del
denaro si insinua, intacca, sconvolge uo
mini e principi intorno ad Halma
V i l i
e sino a lui, all'uomo saggio, al monarca
che è legato ai suoi sudditi da un vincolo
spirituale ancor più che- da un patto
politico, vorrebbe giungere. La vittoria
dell'oro che Tempsey, uno dei finan
zieri n«-lla sua cieca, insaziabile ambi
zione profonde a piene mani, sembra
certa. Esercito, ministri, dignitari hanno
ceduto; lo stesso patrimonio privato del
re è perduto, ma Halma
V i l i
accetta
coraggiosamente la lotta. Allontana da
sè Silvia, la gentile, amorosa figlia di
Tempsey che, al monarca che prima
d'allora non ha mai amato, ha offerto
un affetto devoto e sta per donargli un
nglio. l'allontana perchè nella battaglia
deve essere con lui solo il figlio legittimo,
l'erede, perchè al popolo egli deve appa
rire così, nella purezza della sua mis
sione divina. Halma vince. Quando
Tempsey in un cieco impulso di orgoglio
crede di strappargli il potere, di elimi
narlo privandolo dell'ultima trincea che
gli è rimasta, la reggia, il re poveri
rifiuta il denaro propostogli per l'estremo
mercato e va fiduc ioso verso 1 suoi sud
diti perchè sa die di un regno si può
con l'oro diventare padroni, ma che
signori di un popolo si è e si rimane
per virtù dei legami
dello
spirito, per la
forza, che il danaro non compra, della
tradizione, della virtù e dell'amore.
In
modo parti* olare in quest'ultima
scena emerge La figura, tracciata con
T R 0
toni ricchissimi, di Halma, si rivela
l’immaginosa spiritualità della fiaba.
Ruggeri ha impersonato il re con ecce
zionale maestria, plasmandone la figura
con una recitazione splendida, con toni
di voce, atteggiamenti, espressioni misu
rate e sapienti.
Ottima anche Emes Zacconi anche se
il personaggio di Silvia manca di una
compiuta destinazione e prende vita solo
in pochi momenti, tuttavia sinceri.
.
LA NO STR A E T À - di G. C. i tola.
I jx rsonaggi dell'ultima commedia ili
Viola sono facilmente definibili, ("è il
ricco industriale che viene dalla gavetta,
l'artefice di se stesso, l'uomo che, ormai
sorretto dai milioni, non ammette osta
coli ai suoi piani, c e la gran dama au
stera. rigida e compassata, dalle espres
sioni e dalla mentalità d ’altri tempi, ci
sono il giovanotto e la signorina moder
nissimi. l'uno sportivo, esuberante e
catoncello, l’altra franca e spigliata, li
bera da convenzioni e pregiudizi, e,
finalmente, c'è l’avvocato alla moda, il
principe del foro, dalle tempie gngie. la
parola fluida e suadente con l'animo,
contro ogni previsione, ancora aperto
ai palpiti dell'amore. Tutta questa gente
per tacere degli altri che fanno da con
torno. è largamente sufficiente per india
stire l'intreccio di una commedia. Ag
giungeteci una buona dose di mestiere
e. come sfondo, la morale — giovanotti,
guai a voi se- vi accorgerete un giorno di
avere perso il turno per sposarvi chè.
allora, a quell'altra età, non sarete più
che dei testimoni della vita altrui —
ed eccovi una divertente commedia di
sicuro successo. Infatti, anche per mento
di Evi Maltagliati, di Cimara e Miglian,
applausi e applausi del pubblico.
• IL M I T O D I A R M A N D O
.
di Gino
Valori.
A proposito della trama di questa com
media, parlare di trovata è troppo. Ap
pena. semmai, una trovatina. Ma. quando
si riesce a contornarla di uno stile bnoso,
di un gioco scenico abile e sciolto e si
sa dare ai personaggi qualc he felice pen
nellata di colore, anche una trovatina
può consentire di mettere insieme una
commedia divertente e gustosa. « Il mito
di Armando ». anche se non ha turbato
1 nostn sonni prospettandoci problemi
insondati e non ha impegnato la nostra
fantasia in ardite ascensioni tra perso
naggi psicologie’amen te complessi, ci ha
divertiti. È questo un multato tut-
t altro che disprezzabile, il mento del
quale è dovuto, nella giusta parte, ani he
agli interpreti l'afhatatissima compagnia
Maltagliati - Cimara - Miglian diretta da
Ettore Giannini.
camp.
U


















