
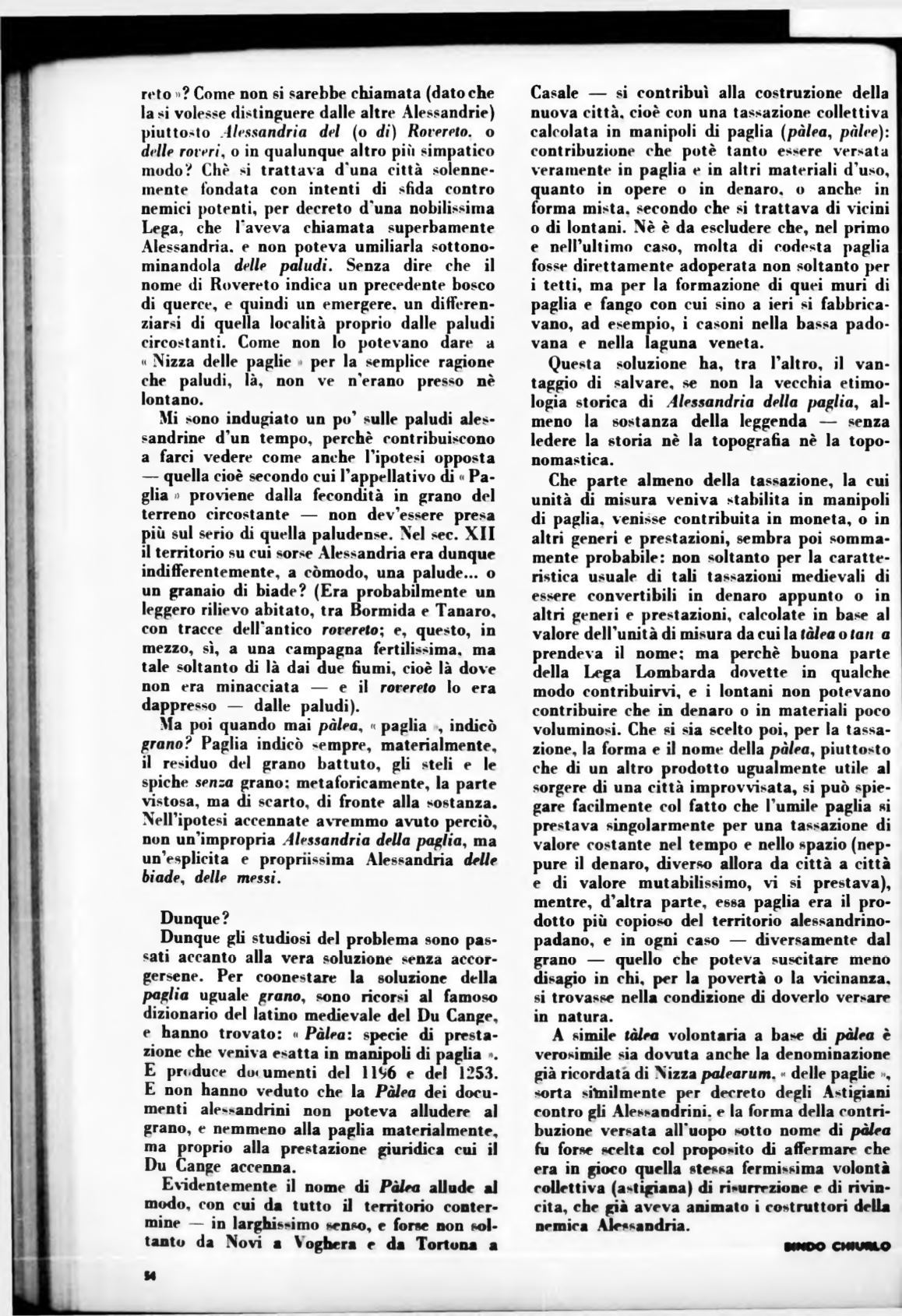
reto »? Come non si sarebbe chiamata (dato che
la si volesse distinguere dalle altre Alessandrie)
piuttosto
Alessandria del
(o
di) Rovereto,
o
delle roveri
, o in qualunque altro più simpatico
modo?
Chè
si trattava d'una città solenne
mente l'ondata con intenti di sfida contro
nemici potenti, per decreto d'una nobilissima
Lega, che l'aveva chiamata superbamente
Alessandria, e non poteva umiliarla sottono
minandola
delle paludi.
Senza dire che il
nome di Rovereto indica un precedente bosco
di querce, e quindi un emergere, un differen
ziarsi di quella località proprio dalle paludi
circostanti. Come non lo potevano dare a
« Nizza delle paglie » per la semplice ragione
che paludi, là, non ve n’erano presso nè
lontano.
Mi sono indugiato un po' sulle paludi ales
sandrine d’un tempo, perchè contribuiscono
a farci vedere come anche l'ipotesi opposta
— quella cioè secondo cui l'appellativo di «Pa
glia » proviene dalla fecondità in grano del
terreno circostante — non dev’essere presa
più sul serio di quella paludense. Nel sec. X II
il territorio su cui sorse Alessandria era dunque
indifferentemente, a còmodo, una palude... o
un granaio di biade? (Era probabilmente un
leggero rilievo abitato, tra Bormida e Tanaro,
con tracce dell'antico
rovereto;
e, questo, in
mezzo, sì, a una campagna fertilissima, ma
tale soltanto di là dai due fiumi, cioè là dove
non era minacciata — e il
rovereto
lo era
dappresso — dalle paludi).
Ma poi quando mai
pàlea,
« paglia , indicò
grano?
Paglia indicò sempre, materialmente,
il residuo del grano battuto, gli steli e le
spiche
senza
grano; metaforicamente, la parte
vistosa, ma di scarto, di fronte alla sostanza.
Nell’ipotesi accennate avremmo avuto perciò,
non un’impropria
Alessandria della paglia
, ma
un’esplicita e propizissima Alessandria
delle
biade
,
delle messi.
Dunque?
Dunque gli studiosi del problema sono pas
sati accanto alla vera soluzione senza accor
gersene. Per coonestare la soluzione della
paglia
uguale
grano
, sono ricorsi al famoso
dizionario del latino medievale del Du Cange,
e hanno trovato: «
Pàlea:
specie di presta
zione che veniva esatta in manipoli di paglia ».
E prt.duce do« umenti del 11V6 e del 1253.
E non hanno veduto che la
Pàlea
dei docu
menti alessandrini non poteva alludere al
grano, e nemmeno alla paglia materialmente,
ma proprio alla prestazione giuridica cui il
Du Cange accenna.
Evidentemente il nome di
Pàlea
allude al
modo, con cui da tutto il territorio conter
mine — in larghissimo senso, e forse non sol
tanto da Novi a \ oghera e da Tortona a
Casale — si contribuì alla costruzione della
nuova città, cioè con una tassazione collettiva
calcolata in manipoli di paglia
(pàlea, pàlee):
contribuzione che potè tanto essere versata
veramente in paglia e in altri materiali d’uso,
quanto in opere o in denaro, o anche in
forma mista, secondo che si trattava di vicini
0 di lontani. Nè è da escludere che, nel primo
e nell'ultimo caso, molta di codesta paglia
fosse direttamente adoperata non soltanto per
1 tetti, ma per la formazione di quei muri di
paglia e fango con cui sino a ieri si fabbrica
vano, ad esempio, i casoni nella bassa pado
vana e nella laguna veneta.
Questa soluzione ha, tra l'altro, il van
taggio di salvare, se non la vecchia etimo
logia storica di
Alessandria della paglia
, al
meno la sostanza della leggenda — senza
ledere la storia nè la topografia nè la topo
nomastica.
Che parte almeno della tassazione, la cui
unità di misura veniva stabilita in manipoli
di paglia, venisse contribuita in moneta, o in
altri generi e prestazioni, sembra poi somma
mente probabile: non soltanto per la caratte
ristica usuale di tali tassazioni medievali di
essere convertibili in denaro appunto o in
altri generi e prestazioni, calcolate in base al
valore dell'unità di misura da cui la
tàlea
o
tan a
prendeva il nome; ma perchè buona parte
della Lega Lombarda dovette in qualche
modo contribuirvi, e i lontani non potevano
contribuire che in denaro o in materiali poco
voluminosi. Che si sia scelto poi, per la tassa
zione, la forma e il nome della
pàlea
, piuttosto
che di un altro prodotto ugualmente utile al
sorgere di una città improvvisata, si può spie
gare facilmente col fatto che l'umile paglia si
prestava singolarmente per una tassazione di
valore costante nel tempo e nello spazio (nep
pure il denaro, diverso allora da città a città
e di valore mutabilissimo, vi si prestava),
mentre, d'altra parte, essa paglia era il pro
dotto più copioso del territorio alessandrino-
padano, e in ogni caso — diversamente dal
grano — quello che poteva suscitare meno
disagio in chi, per la povertà o la vicinanza,
si trovasse nella condizione di doverlo versare
in natura.
A simile
tàlea
volontaria a base di
pàlea
è
verosimile sia dovuta anche la denominazione
già ricordata di Nizza
palearum.
« delle pagUe »,
sorta senilmente per decreto degli Astigiani
contro gb Alessandrini, e la forma della contri
buzione versata all'uopo sotto nome di
pàlea
fu forse scelta col proposito di affermare che
era in gioco quella stessa fermissima volontà
collettiva (astigiana) di risurrezione e di rivin
cita, che già aveva animato i costruttori della
nemica Alessandria.
MNOO CK IW ILO
M


















