
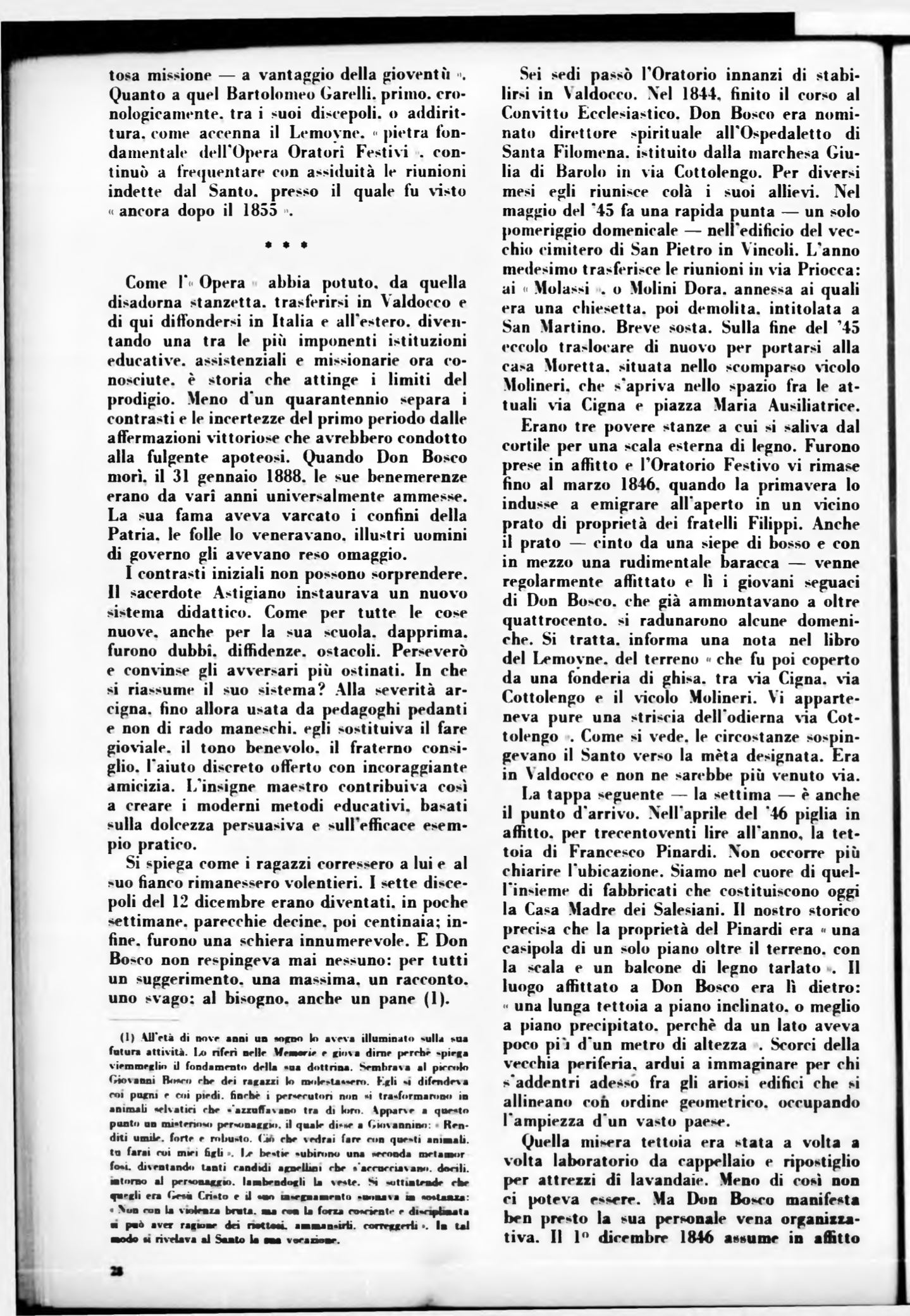
tosa missione — a vantaggio della gioventù ■>.
Quanto a quel Bartolomeo Garelli. primo. cro
nologicamente. tra i suoi discepoli, o add irit
tura. come accenna il Lemoyne. «pietra fon
damentali* deirOpera Oratori Festivi . con
tinuò a frequentare con assiduità le riunioni
indette dal Santo, presso il quale fu visto
« ancora dopo il 1855 ».
* * *
Come I*" Opera abbia potuto, da quella
disadorna stanzetta, trasferirsi in Valdocco e
di qui diffondersi in Italia e all'estero. diven
tando una tra le più imponenti istituzioni
educative, assistenziali e missionarie ora co
nosciute. è storia che attinge i limiti del
prodigio. Meno d ‘un quarantennio separa i
contrasti e le incertezze del primo periodo dalle
affermazioni vittoriose che avrebbero condotto
alla fulgente apoteosi. Quando Don Bosco
morì, il 31 gennaio 1888. le sue benemerenze
erano da vari anni universalmente ammesse.
La sua fama aveva varcato i confini della
Patria, le folle lo veneravano, illustri uomini
di governo gli avevano reso omaggio.
I contrasti iniziali non possono sorprendere.
11 sacerdote Astigiano instaurava un nuovo
sistema didattico. Come per tu tte le cose
nuove, anche per la sua scuola, dapprima,
furono dubbi, diffidenze, ostacoli. Perseverò
e convinse gli avversari più ostinati. In che
si riassume il suo sistema? Alla severità a r
cigna. fino allora usata da pedagoghi pedanti
e non di rado maneschi, egli sostituiva il fare
gioviale, il tono benevolo, il fraterno consi
glio. l'aiuto discreto offerto con incoraggiante
amicizia. I/insigne maestro contribuiva così
a creare i moderni metodi educativi, basati
sulla dolcezza persuasiva e sull'efficace esem
pio pratico.
Si spiega come i ragazzi corressero a lui e al
>uo fianco rimanessero volentieri. I sette disce
poli del 12 dicembre erano diventati, in poche
settimane, parecchie decine, poi centinaia; in
fine. furono una schiera innumerevole. E Don
Bosco non respingeva mai nessuno: per tu tt i
un suggerimento, una massima, un racconto,
uno svago: al bisogno, anche un pane (1).
(1) AlTetà di nove anni un m p v ) In aveva illuminato sulla Mia
futura attività. |x» riferì nrllr Memorie e giova dime [trrrhf «piega
viemmeglio il fondamento della «uà dottrina. Sembrava al piccolo
Giovanni B<wco rbe dei ragazzi lo molestassero. Kgli
«1
difendeva
eoi pugni e coi piedi, finché i persecutori non si trasformarono in
animali selvatici che «'azzuffavano tra di loro, \pparve a questo
punto un misterioso personaggio, il quale disse a Giovannino: R en
diti umile, forte e robusto. (!in che vedrai fare con que-ti animali,
ta farai coi miei figli ».
\jr
bestie subirono una seconda metamor
fosi. diventando tanti candidi agnellini che s'arrncciav ano. dorili,
intorno al personaggi», lambendogli la veste. Si sottintende rbe
quagli era Ge«à Cristo e il «an insegnamento «uonava in « n l i a u :
• Non con la violenza botta, ima eoa la forza co*óent>* e disciplinata
m
può aver ragione dei n o tim i, ammansirli, correggerli ». In tal
n od o •< rivelava mi Santo la a u vocazione.
Sei sedi passò l’Oratorio innanzi di stabi
lirsi in Naldocco. Nel 1844, finito il corso al
Convitto Ecclesiastico. Don Bosco era nomi
nato direttore spirituale all'Ospedaletto di
Santa Filomena, istituito dalla marchesa Giu
lia di Barolo in via Cottolengo. Per diversi
mesi egli riunisce colà i suoi allievi. Nel
maggio del *45 fa una rapida punta — un solo
pomeriggio domenicale — nelì'editìcio del vec
chio cimitero di San Pietro in Vincoli. L'anno
medesimo trasferisce le riunioni in via Priocca:
ai «Molassi . o Molini Dora, annessa ai quali
era una chiesetta, poi demolita, intitolata a
San Martino. Breve sosta. Sulla fine del ’45
eccolo tra>locare di nuovo per portarsi alla
ca>a Moretta, situata nello scomparso vicolo
Molineri, che s'apriva nello spazio fra le a t
tuali via Cigna e piazza Maria Ausiliatrice.
Erano tre povere stanze a cui si saliva dal
cortile per una scala esterna di legno. Furono
prese in affìtto e ('Oratorio Festivo vi rimase
fino al marzo 1846. quando la primavera lo
indusse a emigrare all'aperto in un vicino
prato di proprietà dei fratelli Filippi. Anche
il prato — cinto da una siepe di bosso e con
in mezzo una rudimentale baracca — venne
regolarmente affittato e lì i giovani seguaci
di Don Bosco, che già ammontavano a oltre
quattrocento, si radunarono alcune domeni
che. Si tra tta , informa una nota nel libro
del Lemoyne. del terreno « che fu poi coperto
da una fonderia di ghisa, tra via Cigna, via
Cottolengo e il vicolo Molineri. Vi apparte
neva pure una striscia dell'odierna via Cot
tolengo . Come si vede, le circostanze sospin
gevano il Santo verso la mèta designata. Era
in \aldocco e non ne sarebbe più venuto via.
La tappa seguente — la settima — è anche
il punto d'arrivo. Nell'aprile del '46 piglia in
affitto, per trecentoventi lire all'anno, la te t
toia di Francesco Pinardi. Non occorre più
chiarire l'ubicazione. Siamo nel cuore di quel
l'insieme di fabbricati che costituiscono oggi
la Casa Madre dei Salesiani. Il nostro storico
precisa che la proprietà del Pinardi era « una
casipola di un solo piano oltre il terreno, con
la scala e un balcone di legno tarlato . Il
luogo affittato a Don Bosco era lì dietro:
« una lunga tettoia a piano inclinato, o meglio
a piano precipitato, perchè da un lato aveva
poco pi j d 'un metro di altezza . Scorci della
vecchia periferia, ardui a immaginare per chi
s'addentri adesso fra gli ariosi edifici che si
allineano con ordine geometrico, occupando
l'ampiezza d 'un vasto paese.
Quella misera tettoia era s ta ta a volta a
volta laboratorio da cappellaio e ripostiglio
per attrezzi di lavandaie. Meno di così non
ci poteva essere. Ma Don Bosco manifesta
ben presto la sua personale vena organizza
tiva. Il
1°
dicembre
1846
assume
in affitto


















