
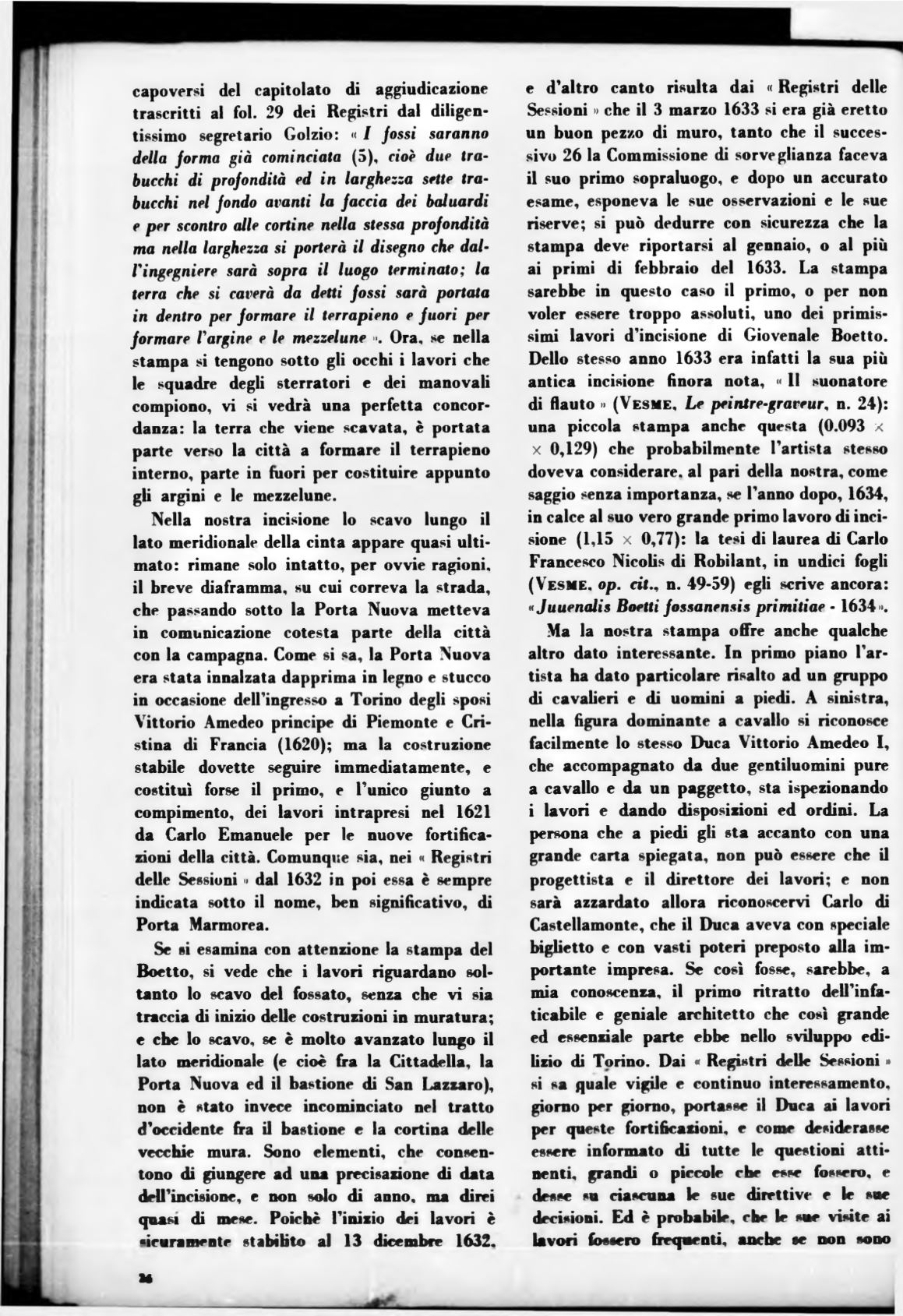
capoversi del capitolato di aggiudicazione
trascritti al fol. 29 dei Registri dal diligen
tissimo segretario Golzio: «</
fossi saranno
della forma già cominciata
(5),
cioè due tra
bucchi di profondità ed in larghezza sette tra
bucchi nel fondo avanti la faccia dei baluardi
e per scontro alle cortine nella stessa profondità
ma nella larghezza si porterà il disegno che dal-
Vingegniere sarà sopra il luogo terminato; la
terra che si caverà da detti fossi sarà portata
in dentro per formare il terrapieno e fuori per
formare l'argine e le mezzelune
». Ora, se nella
stampa si tengono sotto gli occhi i lavori che
le squadre degli sterratori e dei manovali
compiono, vi si vedrà una perfetta concor
danza: la terra che viene scavata, è portata
parte verso la città a formare il terrapieno
interno, parte in fuori per costituire appunto
gli argini e le mezzelune.
Nella nostra incisione lo scavo lungo il
lato meridionale della cinta appare quasi ulti
mato: rimane solo intatto, per ovvie ragioni,
il breve diaframma, su cui correva la strada,
che passando sotto la Porta Nuova metteva
in comunicazione cotesta parte della città
con la campagna. Come si sa, la Porta Nuova
era stata innalzata dapprima in legno e stucco
in occasione dell’ingresso a Torino degli sposi
Vittorio Amedeo principe di Piemonte e Cri
stina di Francia (1620); ma la costruzione
stabile dovette seguire immediatamente, e
costituì forse il primo, e Punico giunto a
compimento, dei lavori intrapresi nel 1621
da Carlo Emanuele per le nuove fortifica
zioni della città. Comunque sia, nei « Registri
delle Sessioni » dal 1632 in poi essa è sempre
indicata sotto il nome, ben significativo, di
Porta Marmorea.
Se si esamina con attenzione la stampa del
Boetto, si vede che i lavori riguardano sol
tanto lo scavo del fossato, senza che vi sia
traccia di inizio delle costruzioni in muratura;
e che lo scavo, se è molto avanzato lungo il
lato meridionale (e cioè fra la Cittadella, la
Porta Nuova ed il bastione di San Lazzaro),
non è stato invece incominciato nel tratto
d'occidente fra il bastione e la cortina delle
vecchie mura. Sono elementi, che consen
tono di giungere ad una precisazione di data
deirincisione, e non solo di anno, ma direi
quasi di mese. Poiché rinizio dei lavori è
sicuramente stabilito al 13 dicembre 1632.
e d'altro canto risulta dai « Registri delle
Sessioni » che il 3 marzo 1633 si era già eretto
un buon pezzo di muro, tanto che il succes
sivo 26 la Commissione di sorveglianza faceva
il suo primo sopraluogo, e dopo un accurato
esame, esponeva le sue osservazioni e le sue
riserve; si può dedurre con sicurezza che la
stampa deve riportarsi al gennaio, o al più
ai primi di febbraio del 1633. La stampa
sarebbe in questo caso il primo, o per non
voler essere troppo assoluti, uno dei primis
simi lavori d’incisione di Giovenale Boetto.
Dello stesso anno 1633 era infatti la sua più
antica incisione finora nota, <
11
suonatore
di flauto »
(Vesme,
Le peintre-graveur
, n. 24):
una piccola stampa anche questa (0.093 x
x 0,129) che probabilmente l’artista stesso
doveva considerare, al pari della nostra, come
saggio senza importanza, se l’anno dopo, 1634,
in calce al suo vero grande primo lavoro di inci
sione (1,15 x 0,77): la tesi di laurea di Carlo
Francesco Nicolis di Robilant, in undici fogli
(Vesme.
op.
d i.,
n. 49-59) egli scrive ancora:
«
Juuenalis Boetti fossanensis primitiae -
1634 ».
Ma la nostra stampa offre anche qualche
altro dato interessante. In primo piano l'ar
tista ha dato particolare risalto ad un gruppo
di cavalieri e di uomini a piedi. A sinistra,
nella figura dominante a cavallo si riconosce
facilmente lo stesso Duca Vittorio Amedeo I,
che accompagnato da due gentiluomini pure
a cavallo e da un paggetto, sta ispezionando
i lavori e dando disposizioni ed ordini. La
persona che a piedi gli sta accanto con una
grande carta spiegata, non può essere che il
progettista e il direttore dei lavori; e non
sarà azzardato allora riconoscervi Carlo di
Castellamonte, che il Duca aveva con speciale
biglietto e con vasti poteri preposto alla im
portante impresa. Se così fosse, sarebbe, a
mia conoscenza, il primo ritratto dell’infa
ticabile e geniale architetto che così grande
ed essenziale parte ebbe nello sviluppo edi
lizio di Torino. Dai « Registri delle Sessioni »
si sa quale vigile e continuo interessamento,
giorno per giorno, portasse il Duca ai lavori
per queste fortificazioni, e come desiderasse
essere informato di tutte le questioni atti
nenti, grandi o piccole che esse fossero, e
desse su ciascuna le sue direttive e le sue
decisioni. Ed è probabile, che le sue visite ai
lavori fossero frequenti, anche «e non sono
lé


















