
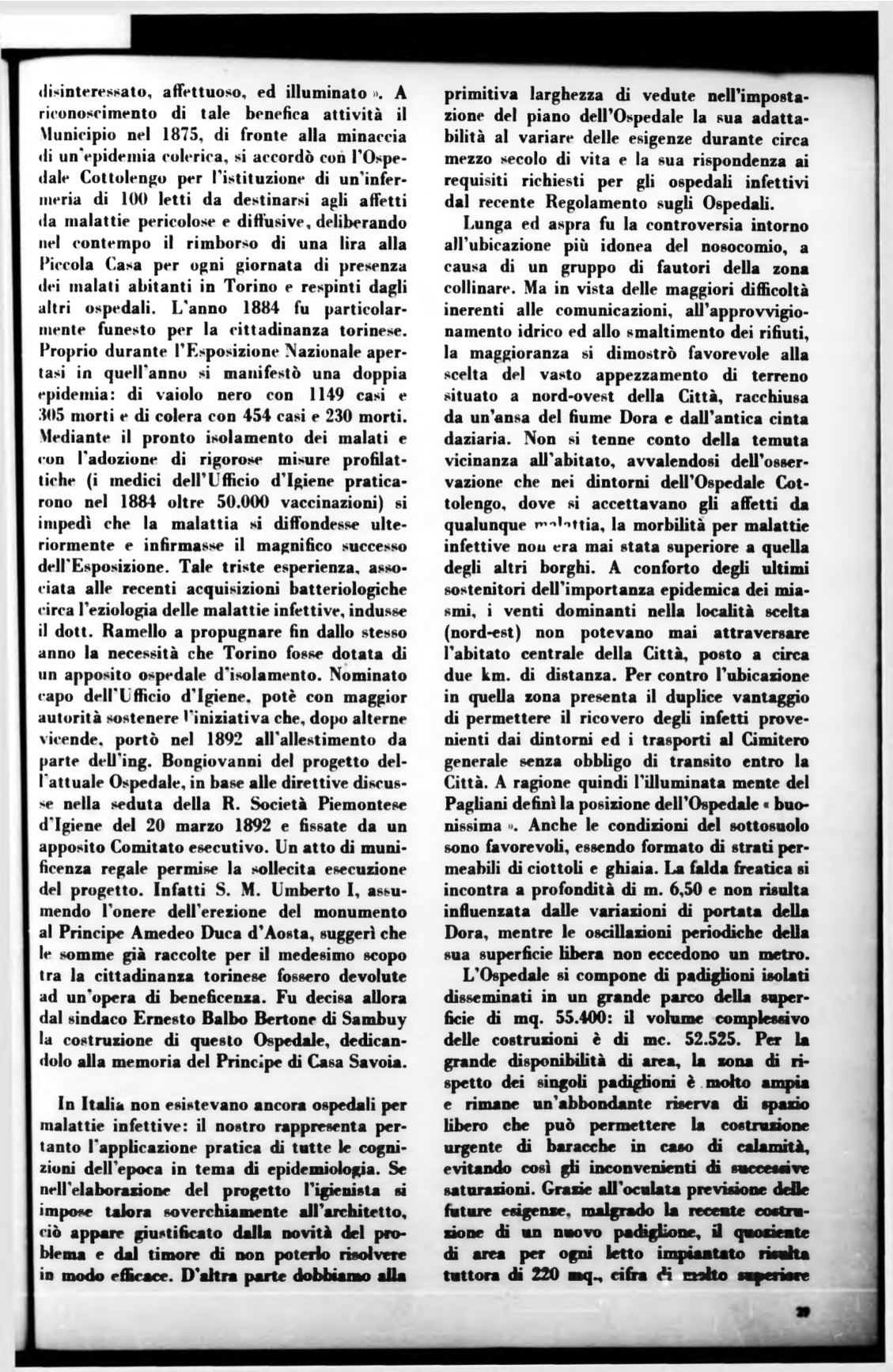
disinteressato, affettuoso, ed illuminato ». A
riconoscimento di tale benefica attività il
Municipio nel 1875, di fronte alla minaccia
di un'epidemia colerica, si accordò con l’Ospe-
dale Cottolengo per l'istituzione di un’infer-
meria di
100
letti da destinarsi agli affetti
ila malattie pericolose e diffusive, deliberando
nel contempo il rimborso di una lira alla
Piccola Casa per ogni giornata di presenza
dei inalati abitanti in Torino e respinti dagli
altri ospedali. L'anno 1884 fu particolar
mente funesto per la cittadinanza torinese.
Proprio durante l’Esposizione Nazionale aper
tasi in quell'anno si manifestò una doppia
epidemia: di vaiolo nero con 1149 casi e
305 morti e di colera con 454 casi e 230 morti.
Mediante il pronto isolamento dei malati e
con l'adozione di rigorose misure profilat
tiche (i medici dell’ Ufficio d'igiene pratica
rono nel 1884 oltre 50.000 vaccinazioni) si
impedì che la malattia si diffondesse ulte
riormente e infirmasse il magnifico successo
dell'Esposizione. Tale triste esperienza, asso
ciata alle recenti acquisizioni batteriologiche
circa l'eziologia delle malattie infettive, indusse
il dott. Ramello a propugnare fin dallo stesso
anno la necessità che Torino fosse dotata di
un apposito ospedale d'isolamento. Nominato
rapo deU'Ufficio d'igiene, potè con maggior
autorità sostenere l'iniziativa che, dopo alterne
vicende, portò nel 1892 all'allestimento da
parte dell'ing. Bongiovanni del progetto del
l'attuale Ospedale, in base alle direttive discus
se nella seduta della R. Società Piemontese
d'igiene del 20 marzo 1892 e fissate da un
apposito Comitato esecutivo. Un atto di muni
ficenza regale permise la sollecita esecuzione
del progetto. Infatti S. M. Umberto I, assu
mendo l'onere deU'erezione del monumento
al Principe Amedeo Duca d'Aosta, suggerì che
le somme già raccolte per il medesimo scopo
tra la cittadinanza torinese fossero devolute
ad un'opera di beneficenza. Fu decisa allora
dal sindaco Ernesto Balbo Bertone di Sambuy
la costruzione di questo Ospedale, dedican
dolo alla memoria del Principe di Casa Savoia.
In Italia non esistevano ancora ospedali per
malattie infettive: il nostro rappresenta per
tanto l’applicazione pratica di tutte le cogni
zioni dell'epoca in tema di epidemiologia. Se
nell'elaborazione del progetto l'igienista si
impose talora soverchiamente airarchitetto,
ciò appare giustificato dalla novità del pro
blema e dal timore di non poterlo risolvere
in modo efficace. D'altra parte dobbiamo alla
primitiva larghezza di vedute nell’imposta
zione del piano dell’Ospedale la sua adatta
bilità al variare delle esigenze durante circa
mezzo secolo di vita e la sua rispondenza ai
requisiti richiesti per gli ospedali infettivi
dal recente Regolamento sugli Ospedali.
Lunga ed aspra fu la controversia intorno
all’ubicazione più idonea del nosocomio, a
causa di un gruppo di fautori della zona
collinare. Ma in vista delle maggiori difficoltà
inerenti alle comunicazioni, all'approvvigio
namento idrico ed allo smaltimento dei rifiuti,
la maggioranza si dimostrò favorevole alla
scelta del vasto appezzamento di terreno
situato a nord-ovest della Città, racchiusa
da un'ansa del fiume Dora e dall’antica cinta
daziaria. Non si tenne conto della temuta
vicinanza all’abitato, avvalendosi dell’osser
vazione che nei dintorni dell’Ospedale Cot-
tolengo, dove si accettavano gli affetti da
qualunque r^l^ttia, la morbilità per malattie
infettive nou era mai stata superiore a quella
degli altri borghi. A conforto degli ultimi
sostenitori dell’importanza epidemica dei mia
smi, i venti dominanti nella località scelta
(nord-est) non potevano mai attraversare
l’abitato centrale della Città, posto a circa
due km. di distanza. Per contro l’ubicazione
in quella zona presenta il duplice vantaggio
di permettere il ricovero degli infetti prove
nienti dai dintorni ed i trasporti al Cimitero
generale senza obbligo di transito entro la
Città. A ragione quindi l’illuminata mente del
Pagliani definì la posizione dell’Ospedale « buo
nissima ». Anche le condizioni del sottosuolo
sono favorevoli, essendo formato di strati per
meabili di ciottoli e ghiaia. La falda freatica si
incontra a profondità di m. 6,50 e non risalta
influenzata dalle variazioni di portata della
Dora, mentre le oscillazioni periodiche della
sua superficie libera non eccedono un metro.
L ’Ospedale si compone di padiglioni isolati
disseminati in un grande parco della super
ficie di mq. 55.400: il volume complessivo
delle costruzioni è di me. 52.525. Per la
grande disponibilità di area, la sona di ri
spetto dei singoli padiglioni è .molto ampia
e rimane un’abbondante riserva di spazio
libero che può permettere la costruzione
urgente di baracche in caso di calamità,
evitando così gli inconvenienti di successive
saturazioni. Grazie all’oculata previsione delle
future esigenze, malgrado la recente costru
zione di un nuovo padiglione, il quoziente
di area per ogni letto impiantato risalta
tuttora di
220
mqM cifra <*i m ito superiore


















