
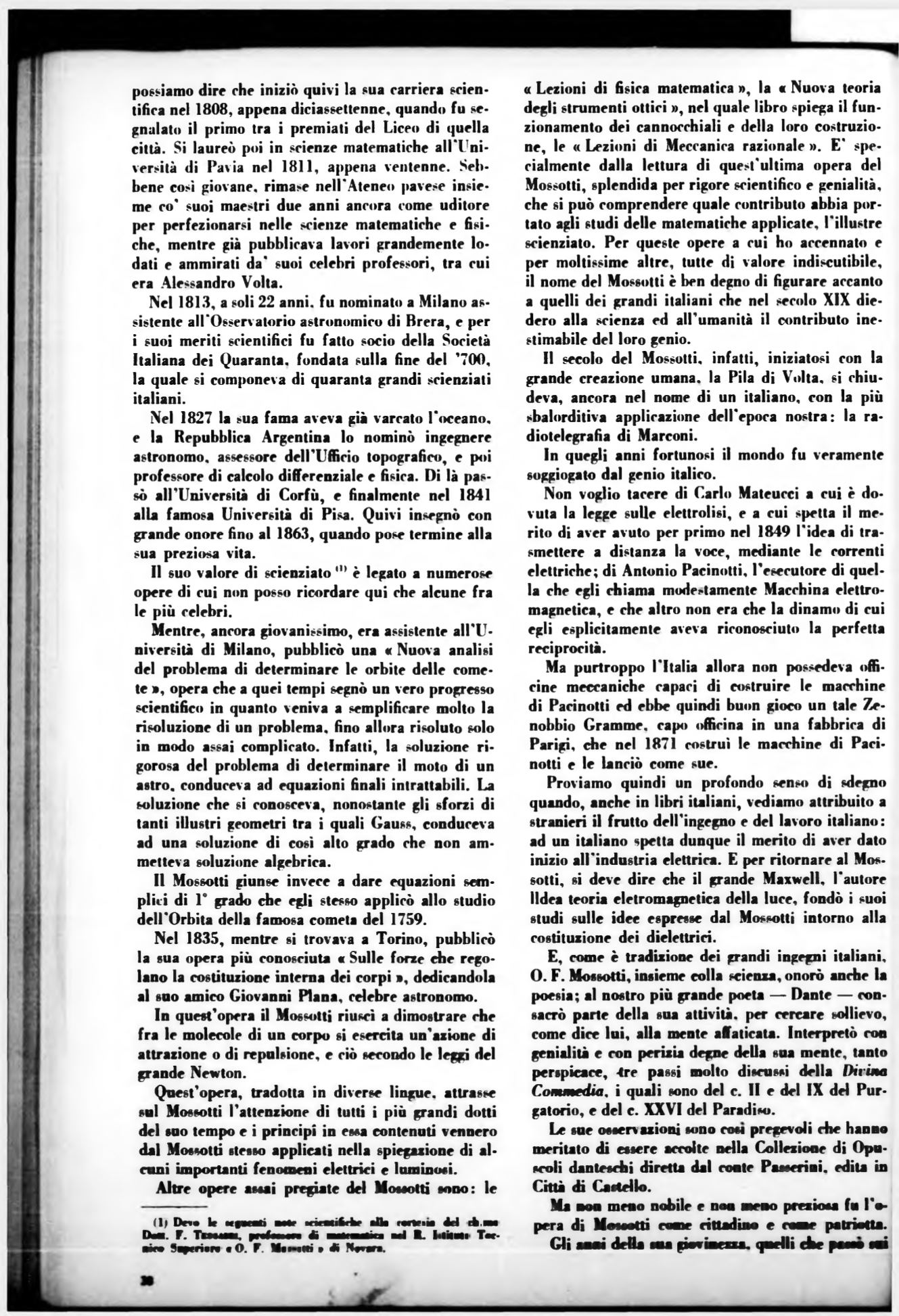
poliamo dire che iniziò quivi la .«ua carriera scien
tifica nel 1808, appena diciassettenne, quando fu se
gnalato il primo tra i premiati del Liceo di quella
città. Si laureò poi in scienze matematiche all'Uni-
versità di Pavia nel 1811, appena ventenne. Seb
bene così giovane, rimase nell'Ateneo pavese insie
me co' suoi maestri due anni ancora come uditore
per perfezionarsi nelle scienze matematiche e fisi
che, mentre già pubblicava lavori grandemente lo
dati e ammirati da' suoi celebri professori, tra cui
era Alessandro Volta.
Nel 1813, a soli 22 anni, fu nominato a Milano as
sistente all‘Osservatorio astronomico di Brera, e per
i suoi meriti scientifici fu fatto socio della Società
Italiana dei Quaranta, fondata sulla fine del '700,
la quale si componeva di quaranta grandi scienziati
italiani.
Nel 1827 la sua fama aveva già varcato l'oceano,
e la Repubblica Argentina lo nominò ingegnere
astronomo, assessore dell'Ufficio topografico, e poi
professore di calcolo differenziale e fisica. Di là pas
sò airUniversità di Corfù, e finalmente nel 1841
alla famosa Università di Pisa. Quivi insegnò con
grande onore fino al 1863, quando pose termine alla
sua preziosa vita.
Il suo valore di scienziato u> è legato a numerose
opere di cui non posso ricordare qui che alcune fra
le più celebri.
Mentre, ancora giovanissimo, era assistente all'U-
niversità di Milano, pubblicò una « Nuova analisi
del problema di determinare le orbite delle come
te », opera che a quei tempi segnò un vero progresso
scientifico in quanto veniva a semplificare molto la
risoluzione di un problema, fino allora risoluto solo
in modo assai complicato. Infatti, la soluzione ri
gorosa del problema di determinare il moto di un
astro, conduceva ad equazioni finali intrattabili. La
soluzione che si conosceva, nonostante gli sforzi di
tanti illustri geometri tra i quali Gauss, conduceva
ad una soluzione di così alto grado che non am
metteva soluzione algebrica.
Il Mossotti giunse invece a dare equazioni sem
plici di lv grado che egli stesso applicò allo studio
dell'Orbita della famosa cometa del 1759.
Nel 1835, mentre si trovava a Torino, pubblicò
la sua opera più conosciuta « Sulle forze che rego
lano la costituzione interna dei corpi », dedicandola
al suo amico Giovanni Plana, celebre astronomo.
In quest'opera il Mossotti riuscì a dimostrare che
fra le molecole di un corpo si esercita un'azione di
attrazione o di repulsione, e ciò secondo le leggi del
grande Newton.
Quest'opera, tradotta in diverse lingue, attrasse
sul Mossotti l'attenzione di tutti i più grandi dotti
del suo tempo e i principi in essa contenuti vennero
dal Mossotti stesso applicati nella spiegazione di al
cuni importanti fenomeni elettrici e luminosi.
Altre opere assai pregiate del Mossotti sono: le
(1 ) D evo le n p t l i M t r t r ic M iirW a lla
tmrì r tm
W rfc.—
Dm . F. f t — .
pmSmmm i i
M k M lic i ad L t it i ll i Tot-
aie» Sy rii H € O. F. M«i itti »
Ai
Nersrs.
« Lezioni di fisica matematica », la « Nuova teoria
degli strumenti ottici », nel quale libro spiega il fun
zionamento dei cannocchiali e della loro costruzio
ne, le « Lezioni di Meccanica razionale ». E' spe
cialmente dalla lettura di quest'ultima opera del
Mossotti, splendida per rigore scientifico e genialità,
che si può comprendere quale contributo abbia por
tato agli studi delle matematiche applicate, l'illustre
scienziato. Per queste opere a cui ho accennato e
per moltissime altre, tutte di valore indiscutibile,
il nome del Mossotti è ben degno di figurare accanto
a quelli dei grandi italiani che nel secolo XIX die
dero alla scienza ed all'umanità il contributo ine
stimabile del loro genio.
Il secolo del Mossotti, infatti, iniziatosi con la
grande creazione umana, la Pila di Volta, si chiu
deva, ancora nel nome di un italiano, con la più
sbalorditiva applicazione dell'epoca nostra: la ra
diotelegrafia di Marconi.
In quegli anni fortunosi il mondo fu veramente
soggiogato dal genio italico.
Non voglio tacere di Carlo Mateucci a cui è do
vuta la legge sulle elettrolisi, e a cui spetta il me
rito di aver avuto per primo nel 1849 l'idea di tra
smettere a distanza la voce, mediante le correnti
elettriche; di Antonio Pacinotti, l'esecutore di quel
la che egli chiama modestamente Macchina elettro-
magnetica, e che altro non era che la dinamo di cui
egli esplicitamente aveva riconosciuto la perfetta
reciprocità.
Ma purtroppo l'Italia allora non possedeva offi
cine meccaniche capaci di costruire le macchine
di Pacinotti ed ebbe quindi buon gioco un tale Ze-
nobbio Granirne, capo officina in una fabbrica di
Parigi, che nel 1871 costruì le macchine di Paci-
notti e le lanciò come sue.
Proviamo quindi un profondo senso di sdegno
quando, anche in libri italiani, vediamo attribuito a
stranieri il frutto dell'ingegno e del lavoro italiano:
ad un italiano spetta dunque il merito di aver dato
inizio all'industria elettrica. E per ritornare al Mos
sotti, si deve dire che il grande Maxwell, l'autore
lldea teoria eletromagnetica della luce, fondò i suoi
studi sulle idee espresse dal Mossotti intorno alla
costituzione dei dielettrici.
E, come è tradizione dei grandi ingegni italiani,
O. F. Mossotti, insieme colla scienza, onorò anche la
poesia; al nostro più grande poeta — Dante — con
sacrò parte della sua attività, per cercare sollievo,
come dice lui, alla mente affaticata. Interpretò con
genialità e con perizia degne della sua mente, tanto
perspicace, -tre passi molto discussi della
Divina
Commedia
. i quali sono del c. II e del IX del Pur
gatorio, e del c. XXVI del Paradiso.
Le sue osservazioni sono
c o n
pregevoli che hanno
meritato di essere accolte nella Collezione di Opu
scoli danteschi diretta dal conte Passerini, edita in
Città dì Castello.
Ma non meno nobile e non meno preziosa fa l'o
pera di Mossotti come cittadino e come patriotta.
Gli anni «Iella sua giovinezza, quelli che passa ani


















