
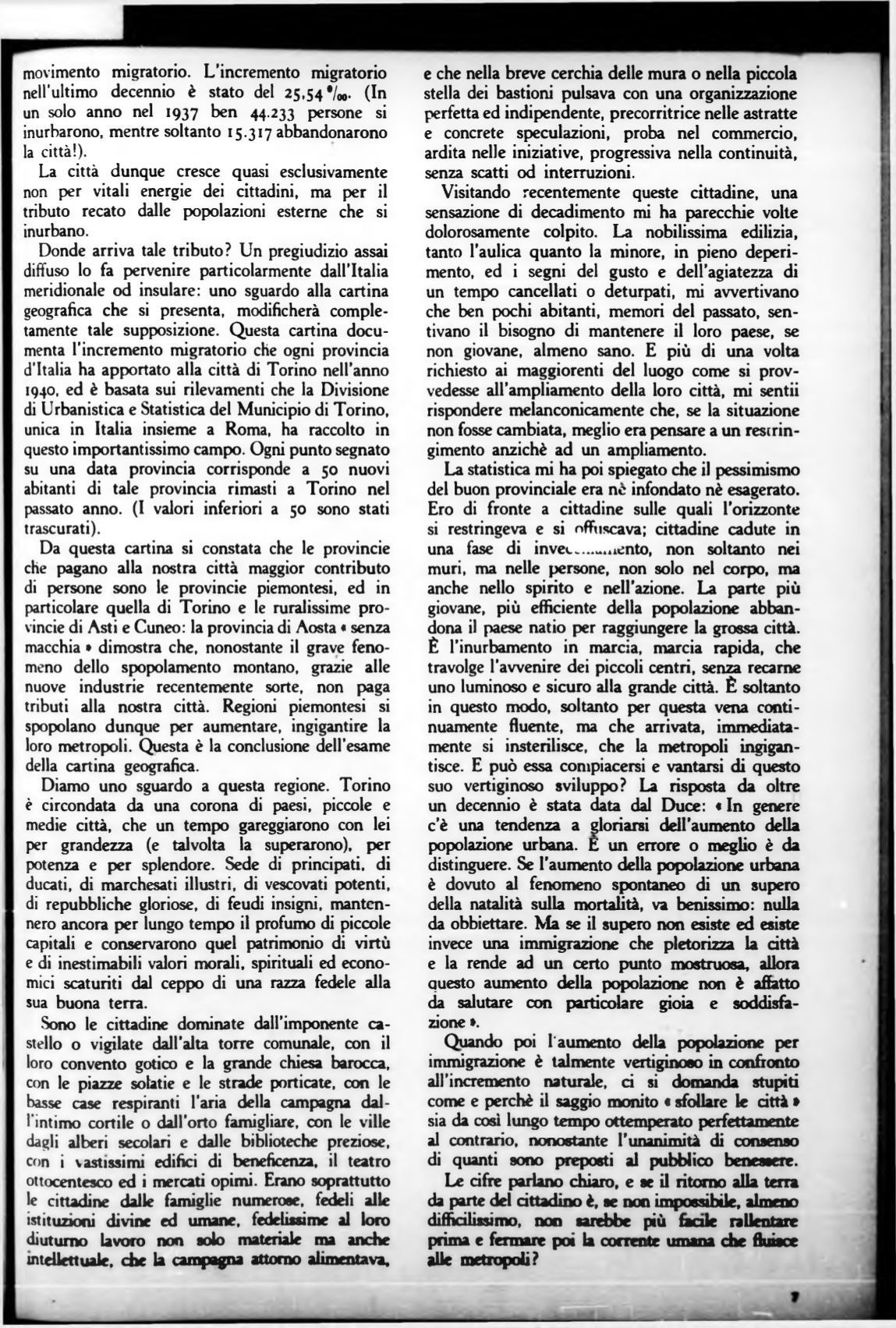
movimento migratorio. L ’incremento migratorio
nell’ultimo decennio è stato del 25,54 */<»• (In
un solo anno nel 1937 ben 44.233 persone si
inurbarono, mentre soltanto 15.317 abbandonarono
la città!).
La città dunque cresce quasi esclusivamente
non per vitali energie dei cittadini, ma per il
tributo recato dalle popolazioni esterne che si
inurbano.
Donde arriva tale tributo? Un pregiudizio assai
diffuso lo fa pervenire particolarmente dall’Italia
meridionale od insulare: uno sguardo alla cartina
geografica che si presenta, modificherà comple
tamente tale supposizione. Questa cartina docu
menta l’incremento migratorio che ogni provincia
d’Italia ha apportato alla città di Torino nell’anno
1940, ed è basata sui rilevamenti che la Divisione
di Urbanistica e Statistica del Municipio di Torino,
unica in Italia insieme a Roma, ha raccolto in
questo importantissimo campo. Ogni punto segnato
su una data provincia corrisponde a 50 nuovi
abitanti di tale provincia rimasti a Torino nel
passato anno. (I valori inferiori a 50 sono stati
trascurati).
Da questa cartina si constata che le provincie
che pagano alla nostra città maggior contributo
di persone sono le provincie piemontesi, ed in
particolare quella di Torino e le ruralissime pro
vincie di Asti e Cuneo: la provincia di Aosta « senza
macchia » dimostra che, nonostante il grave feno
meno dello spopolamento montano, grazie alle
nuove industrie recentemente sorte, non paga
tributi alla nostra città. Regioni piemontesi si
spopolano dunque per aumentare, ingigantire la
loro metropoli. Questa è la conclusione dell’esame
della cartina geografica.
Diamo uno sguardo a questa regione. Torino
è circondata da una corona di paesi, piccole e
medie città, che un tempo gareggiarono con lei
per grandezza (e talvolta la superarono), per
potenza e per splendore. Sede di principati, di
ducati, di marchesati illustri, di vescovati potenti,
di repubbliche gloriose, di feudi insigni, manten
nero ancora per lungo tempo il profumo di piccole
capitali e conservarono quel patrimonio di virtù
e di inestimabili valori morali, spirituali ed econo
mici scaturiti dal ceppo di una razza fedele alla
sua buona terra.
•Sono le cittadine dominate dall’imponente ca
stello o vigilate dall’alta torre comunale, con il
loro convento gotico e la grande chiesa barocca,
con le piazze solatie e le strade porticate, con le
basse case respiranti l’aria della campagna dal
l’intimo cortile o dall'orto famigliare, con le ville
dagli alberi secolari e dalle biblioteche preziose,
con i vastissimi edifici di beneficenza, il teatro
ottocentesco ed i mercati opimi. Erano soprattutto
le cittadine dalle famiglie numerose, fedeli alle
istituzioni divine ed
umane,
fedelissime
al loro
diuturno
lavoro non solo materiale ma anche
intellettuale, che la campagna attorno alimentava.
e che nella breve cerchia delle mura o nella piccola
stella dei bastioni pulsava con una organizzazione
perfetta ed indipendente, precorritrice nelle astratte
e concrete speculazioni, proba nel commercio,
ardita nelle iniziative, progressiva nella continuità,
senza scatti od interruzioni.
Visitando recentemente queste cittadine, una
sensazione di decadimento mi ha parecchie volte
dolorosamente colpito. La nobilissima edilizia,
tanto l’aulica quanto la minore, in pieno deperi
mento, ed i segni del gusto e dell’agiatezza di
un tempo cancellati o deturpati, mi avvertivano
che ben pochi abitanti, memori del passato, sen
tivano il bisogno di mantenere il loro paese, se
non giovane, almeno sano. E più di una volta
richiesto ai maggiorenti del luogo come si prov
vedesse all’ampliamento della loro città, mi sentii
rispondere melanconicamente che, se la situazione
non fosse cambiata, meglio era pensare a un restrin
gimento anziché ad un ampliamento.
La statistica mi ha poi spiegato che il pessimismo
del buon provinciale era nc infondato nè esagerato.
Ero di fronte a cittadine sulle quali l’orizzonte
si restringeva e si offuscava; cittadine cadute in
una fase di invecWkMiUilento, non soltanto nei
muri, ma nelle persone, non solo nel corpo, ma
anche nello spirito e nell’azione. La parte più
giovane, più efficiente della popolazione abban
dona il paese natio per raggiungere la grossa città.
È l’inurbamento in marcia, marcia rapida, che
travolge l’avvenire dei piccoli centri, senza recarne
uno luminoso e sicuro alla grande città. È soltanto
in questo modo, soltanto per questa vena conti
nuamente fluente, ma che arrivata, immediata
mente si insterilisce, che la metropoli ingigan
tisce. E può essa compiacersi e vantarsi di questo
suo vertiginoso sviluppo? La risposta da oltre
un decennio è stata data dal Duce: « In genere
c’è una tendenza a gloriarsi dell'aumento della
popolazione urbana. E un errore o meglio è da
distinguere. Se l’aumento della popolazione urbana
è dovuto al fenomeno spontaneo di un supero
della natalità sulla mortalità, va benissimo: nulla
da obbiettare. M a se il supero non esiste ed esiste
invece una immigrazione che pletorizza la città
e la rende ad un certo punto mostruosa, allora
questo aumento della popolazione non è affatto
da salutare con particolare gioia e soddisfa
zione *.
Quando poi l'aumento della popolazione per
immigrazione è talmente vertiginoso in confronto
all’incremento naturale, ci si domanda stupiti
come e perchè il saggio monito « sfollare le città »
sia da così lungo tempo ottemperato perfettamente
al contrario, nonostante l’unanimità di consenso
di quanti sono preposti al pubblico benessere.
Le cifre parlano chiaro, e se il ritorno alla terra
da parte del cittadino è, se non impossibile, almeno
difficilissimo, non sarebbe più frale rallentale
prima e fermare poi la corrente umana che fluisce
alle metropoli?


















