
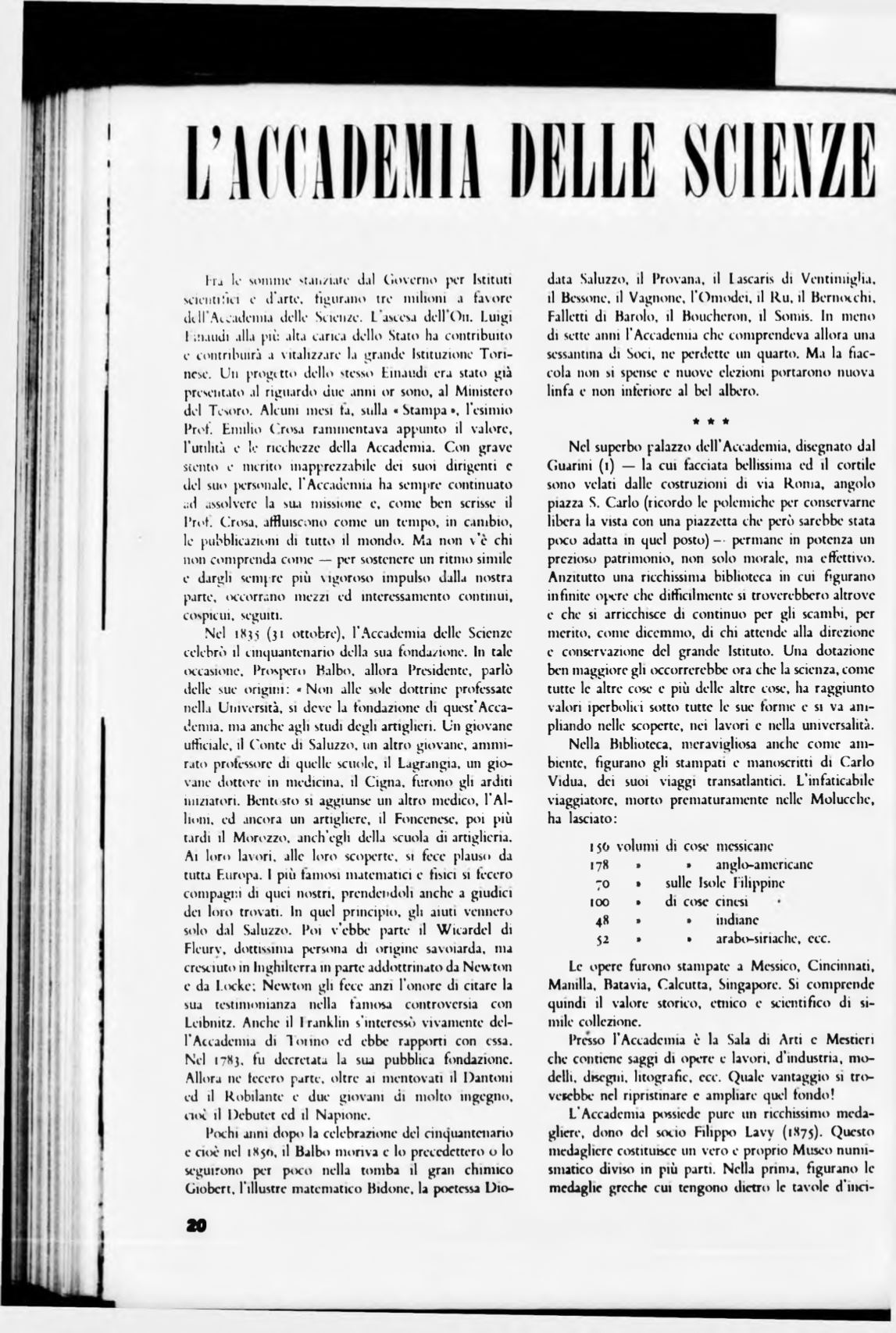
Fra
le
somme stanziare dal Governo per Istituti
scienti fu i e d’arte, figurano tre milioni a favore
d<.
1
Accademia delle Scienze. L ascesa dell O11. Luigi
1
mandi alla più alta carica dello Stato ha contribuito
e contribuirà a vitalizzare la grande Istituzione Tori
nese.
Un
progetto dello 'tessi' Einaudi era stato già
presentato al riguardo due anni or sono, al Ministero
del Tesoro. Alcuni mesi ta, sulla «Stampa», l’esimio
Prof. Emilio ('rosa rammentava appunto il valore,
l’ utilità e le ricchezze della Accademia. Con grave
stento e merito inapprezzabile dei suoi dirigenti c
del suo personale, l’ Accademia ha sempre continuato
ad assolvere la sua missione e, come ben scrisse il
Prof. Crosa, affluiscono come un tempo, in cambio,
le pubblicazioni di tutto il mondo. Ma non v’e chi
non comprenda come — per sostenere un ritmo simile
e dargli sempre più vigoroso impulso dalla nostra
parte, occorrano mezzi ed interessamento continui,
cospicui, seguiti.
Nel i S3s (31 ottobre), l’ Accademia delle Scienze
celebrò il cinquantenario della sua fondazione. In tale
occasione. Prospero Balbo, allora Presidente, parlò
delle sue origini: «Non alle sole dottrine professate
nella Università, si deve la fondazione di quest’ Acca
demia. ma anche agli studi degli artiglieri. Un giovane
ufficiale, il Conte di Sai uzzo, un altro giovane, ammi
rato professore di quelle scuole, il Lagran già, 1111 gio
vane dottore in medicina, il Cigna, furono gli arditi
iniziatori. Bentosto si aggiunse un altro medico, l’ Al-
lioni, ed ancora un artigliere, il Fonccncse, poi più
tardi il Morozzo, anch’egli della scuola di artiglieria.
Ai loro lavori, alle loro scoperte, si fece plauso da
tutta Europa. I più famosi matematici e fìsici si fecero
compagni di quei nostri, prendendoli anche a giudici
dei loro trovati. In quel principio, gli aiuti vennero
solo dal Saluzzo. Poi v’ebbe parte il Wicardel di
Fleurv, dottissima persona di origine savoiarda, ma
cresciuto in Inghilterra in parte addottrinato da Newton
e da Locke; Newton gli fece anzi l’onore di citare la
sua testimonianza nella famosa controversia con
Lcibnitz. Anche il I ranklin s’interessò vivamente del-
l’ Accademia di Tonno ed ebbe rapporti con essa.
Nel 17X3. tu decretata la sua pubblica fondazione.
Allora ne fecero parte, oltre ai mentovati il Dantoni
ed il Kobilante e due giovani di molto ingegno,
cioè il Debutet ed il Napione.
Pochi anni dopo la celebrazione del cinquantenario
e cioè nel 1X50, il Balbo moriva e lo precedettero o lo
seguirono per poco nella tomba il gran chimico
Giobcrt, l’illustre matematico Bidone, la poetessa D10-
data Saluzzo, il Provana, il Lascaris di Vcntimiglia.
il Bessone, il Vagnone, l’Omodei, il Ru , il Bernixehi,
Falletti di Barolo, il Bouchcron, il Somis. Iti meno
di sette anni l’ Accademia che comprendeva allora una
sessantina di Soci, ne perdette 1111 quarto. Ma la fiac
cola non si spense e nuove elezioni portarono nuova
linfa e non inferiore al bel albero.
★ ★ ★
Nel superbo p iazzo dell’ Accademia, disegnato dal
Guarnii (1) — la cui facciata bellissima ed il cortile
sono velati dalle costruzioni di via Roma, angolo
piazza S. Carlo (ricordo le polemiche per conservarne
libera la vista con una piazzetta che però sarebbe stata
poco adatta in quel posto) — permane in potenza un
prezioso patrimonio, non solo morale, ma effettivo.
Anzitutto una ricchissima biblioteca in cui figurano
infinite opere che difficilmente si troverebbero altrove
e che si arricchisce di continuo per gli scambi, per
merito, come dicemmo, di chi attende alla direzione
e conservazione del grande Istituto. Una dotazione
ben maggiore gli occorrerebbe ora che la scienza, come
tutte le altre cose e più delle altre cose, ha raggiunto
valori iperbolici sotto tutte le sue forme e si va am
pliando nelle scoperte, nei lavori c nella universalità.
Nella Biblioteca, meravigliosa anche come am
biente, figurano gli stampati e manoscritti di Carlo
Vidua, dei suoi viaggi transatlantici. L’infaticabile
viaggiatore, morto prematuramente nelle Molucche,
ha lasciato:
150 volumi di cose messicane
178
»
»
anglo-americane
70
»
sulle Isole Filippine
100
»
di cose cinesi
48
»
»
indiane
52
»
»
arabo-siriache, ecc.
Le opere furono stampate a Messico, Cincinnati,
Manilla, Batavia, Calcutta, Singapore. Si comprende
quindi il valore storico, etnico e scientifico di si-
nule collezione.
Presso l’Accadeima è la Sala di Arti c Mestieri
che contiene saggi di opere e lavori, d’industria, mo
delli, disegni, litografie, ecc. Quale vantaggio si tro
verebbe nel ripristinare e ampliare quel fondo!
L’ Accademia possiede pure un ricchissimo meda
gliere, dono del socio Filippo Lavy (1H75). Questo
medagliere costituisce un vero e proprio Musco numi
smatico diviso in più parti. Nella prima, figurano le
medaglie greche cui tengono dietro le tavole d’ inci
20


















