
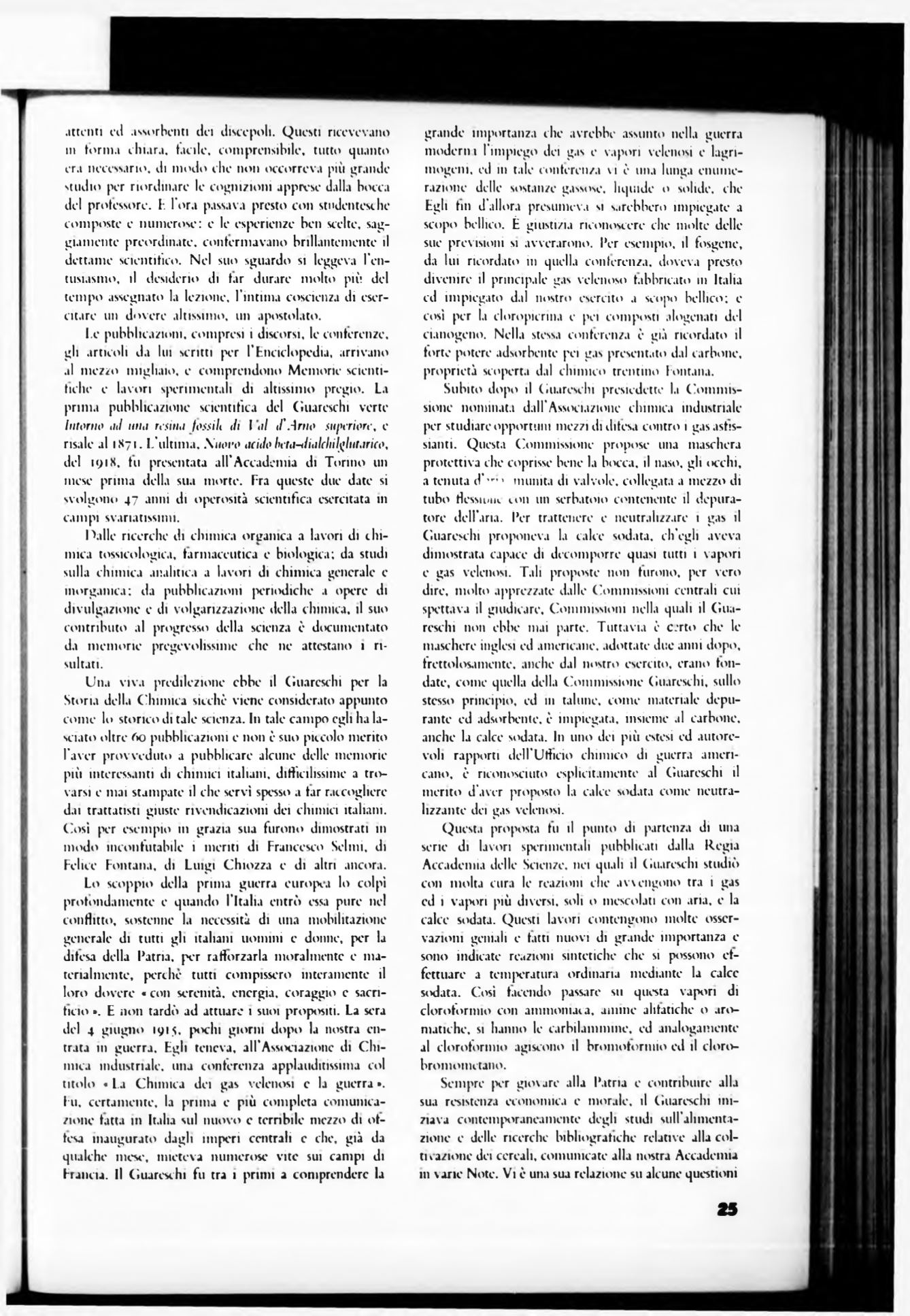
attenti od assorbenti dei discepoli. Questi ricevevano
in torma chiara, facile, comprensibile, tutto quanto
era necessario, di modo che non occorreva più grande
studio per riordinare le cognizioni apprese dalla bocca
del professore. E l’ora passava presto con studentesche
composte e numerose': e le esperienze ben scelte, sag
giamente preordinate, confermavano brillantemente il
dettame scientifico. Nel suo sguardo si leggeva l’en
tusiasmo, il desiderio di far durare molto più del
tempo assegnato la lezione, l’ intima coscienza di eser
citare un dovere altissimo, un apostolato.
Le pubblicazioni, compresi i discorsi, le conferenze,
gli articoli da lui scritti per l’ Enciclopedia, arrivano
al mezzo migliaio, e comprendono Memorie scienti
fiche e lavori sperimentali di altissimo pregio. La
prima pubblicazione scientifica del (ìuarcschi verte
Intorno
./</
iin,i h-sin,! fossili di
I
al d'Arno superiore,
e
risale al 1871. L'ultima,
Suovo acido beta-ili,ilchilglut.irico,
del 1918, tu presentata all’ Accademia di Torino un
mese prima della sua morte. Fra queste due date si
svolgono 47 anni di operosità scientifica esercitata 111
campi svariatissimi.
Halle ricerche di chimica oriranica a lavori di chi-
mica tossicologica, farmaceutica e biologica; da studi
sulla chimica analitica a lavori di chimica generale e
inorganica; da pubblicazioni periodiche a opere di
divulgazione e di volgarizzazione della chimica, il suo
contributo al progresso della scienza è documentato
da memorie pregevolissime che ne attcstano 1 ri
sultati.
Una viva predilezione ebbe il (ìuarcschi per la
Storia della Chimica sicché viene considerato appunto
come lo storico di tale scienza. In tale campo egli ha la
sciati' oltre fio pubblicazioni e non è suo piccolo merito
l’aver provveduto a pubblicare alcune delle memorie
più interessanti di chimici italiani, difficilissime a tro
varsi e mai stampate il che servì spesso a tar raccogliere
dai trattatisti giuste rivendicazioni dei chimici italiani.
Cosi per esempio 111 grazia sua furono dimostrati in
modo inconfutabile i meriti di Francesco Selmi, di
Felice Fontana, di Luigi Chiozza e di altri ancora.
Lo scoppio della prima guerra europea lo colpì
protondamente e quando l’ Italia entrò essa pure nel
conflitto, sostenne la necessità di una mobilitazione
generale di tutti gli italiani uomini e donne, per la
difesa della Patria, per rafforzarla moralmente e ma
terialmente, perche tutti compissero interamente il
loro dovere « con serenità, energia, coraggio c sacri
ficio ». E non tardò ad attuare 1 suoi propositi. La sera
del 4 giugno 1915, pochi giorni dopo la nostra en
trata in guerra, Egli teneva, all’Associazione di Chi
mica industriale, una conferenza applauditissima col
titolo « La Chimica dei gas velenosi c la guerra ».
Fu. certamente, la prima e più completa comunica
zione fatta in Italia sul nuovo c terribile mezzo di of
fesa inaugurato dagli imperi centrali c che, già da
qualche mese, mieteva numerose vite sui campi di
Francia. Il (ìuarcschi fu tra 1 pruni a comprendere la
grande importanza che avrebbe assunto nella guerra
moderna l’impiego dei gas e vapori velenosi e lagri-
mogeni, ed 111 tale conferenza \i è una lunga enume
razione delle sostanze gassose, liquide o solide, che
Egli fin d’allora presumeva si sarebbero impiegate a
scopo bellico. È giustizia riconoscere che molte delle
sue previsioni si avverarono. IVr esempio, il fosgene,
da lui ricordato in quella conferenza, doveva presto
divenire il principale gas velenoso fabbricato 111 Italia
cd impiegato dal nostro esercito a scopo bellico; e
così per la cloropicrma e pei composti alogcnati del
cianogeno. Nella stessa conferenza è già ricordato il
forte potere adsorbente pei gas presentato dal carbone,
proprietà scoperta dal chimico trentino Fontana.
Subito dopo il (ìuarcschi presiedette la Commis
sione nominata dall'Associazione chimica industriale
per studiare opportuni mezzi di difesa contro 1 gas asfis
sianti. Questa Commissione propose* una maschera
protettiva che coprisse bene la bocca, il naso, gli occhi,
a tenuta d’ ,r' < munita di valvole, collegata a mezzo di
tubo riessitele con 1111 serbatoio contenente il depura
tore dell'aria, l’er trattenere e neutralizzare 1 gas il
(ìuarcschi proponeva la calce sodata, ch’egli aveva
dimostrata capace di decomporre quasi tutti i vapori
e gas velenosi. Tali proposte non furono, per vero
dire, molto apprezzate dalle Commissioni centrali cui
spettava il giudicare. Commissioni nella quali il (ìua-
reschi non ebbe mai parte. Tuttavia è c.'rto che le
maschere inglesi ed americane, adottate due anni dopo,
frettolosamente, anche dal nostro esercito, erano fon
date, come quella della Commissione (ìuarcschi, sullo
stesso principio, cd in talune, come materiale depu
rante ed adsorbente, è impiegata, insieme al carbone,
anche la calce sodata. In uno dei più estesi ed autore
voli rapporti dell’Ufficio chimico di guerra ameri
cano, è riconosciuto esplicitamente al (ìuarcschi il
merito d’aver proposto la calce sodata come neutra
lizzante dei gas velenosi.
Questa proposta fu il punto di partenza di una
serie di lavori sperimentali pubblicati dalla Regia
Accademia delle Scienze, nei quali il (ìuarcschi studiò
con molta cura le reazioni che avvengono tra i gas
cd i vapori più diversi, soli o mescolati con aria, e la
calce sodata. Questi lavori contengono molte osser
vazioni geniali e fatti nuovi di grande importanza e
sono indicate reazioni sintetiche che si possono ef
fettuare a temperatura ordinaria mediante la calce
sodata. Così facendo passare su questa vapori di
cloroformio con ammoniaca, amine alifatiche o aro
matiche, si hanno le carbilaiiimine, ed analogamente
al cloroformio agiscono il bromoformio cd il cloro-
bromomctano.
Sempre per giovare alla Patria e contribuire alla
sua resistenza economica c morale, il (ìuarcschi ini
ziava contemporaneamente degli studi suralimenta
zione e delle ricerche bibliografiche relative alla col
tiva/ione dei cercali, comunicate alla nostra Accademia
111 varie Note. Vi è una sua relazione su alcune questioni
25


















