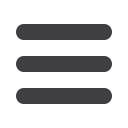
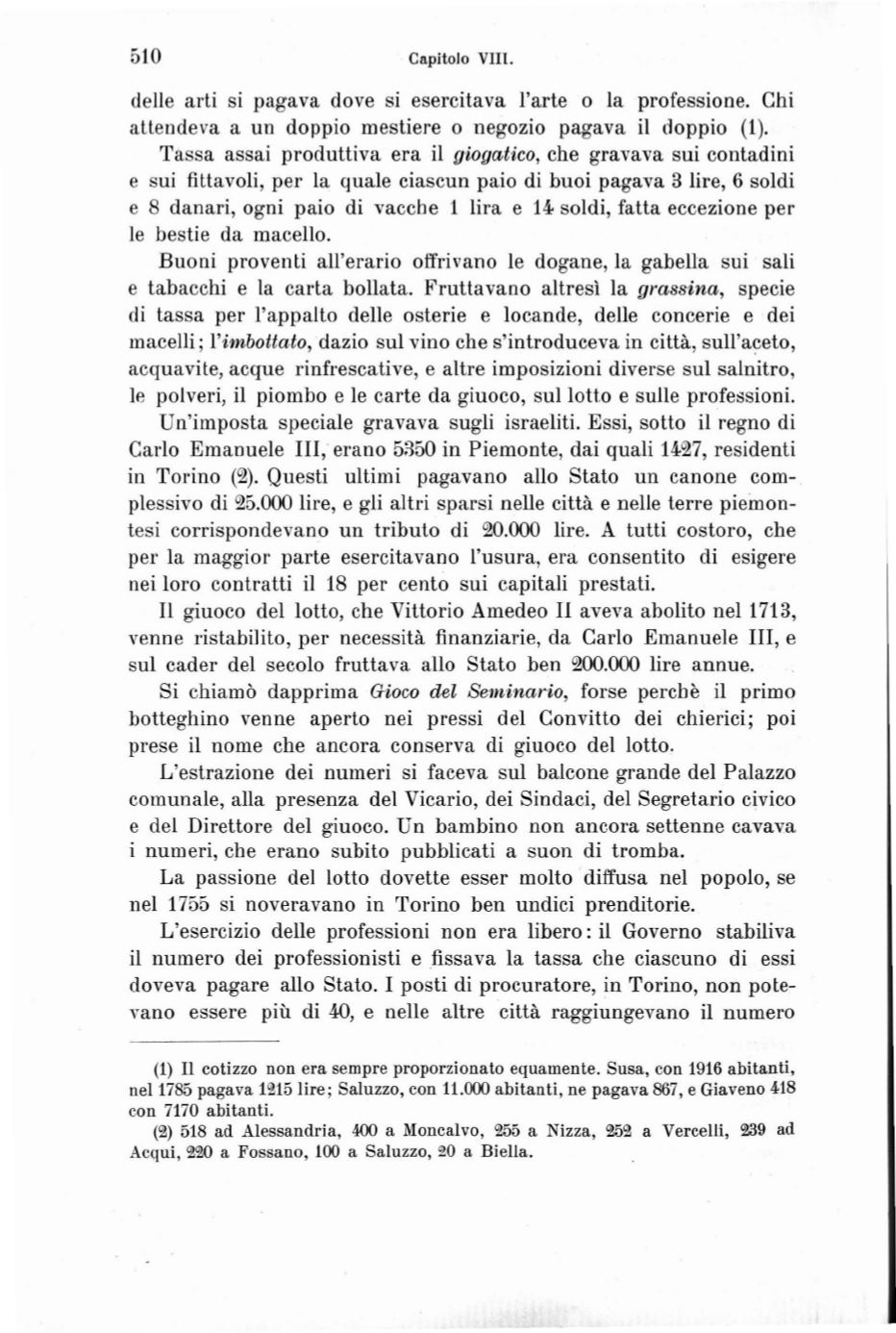
510
Capitolo VIII.
delle arti si pagava dove si esercitava l'arte o la professione. Chi
attendeva a un doppio mestiere o negozio pagava il doppio (1).
Ta ssa assai produttiva era il
giogatico,
che gravava sui contadini
e sui fittavoli , per la quale ciascun paio di buoi pagava 3 lire, 6 soldi
e 8 danari, ogni paio di vacche l lira e 14 soldi, fatta eccezione per
le bestie da macello.
Buoni proventi all'erario offrivano le dogane, la gabella sui sali
e tabacchi e la car ta bollata. Fruttavano altresì la
gra ssina,
specie
di tassa per l'appalto delle osterie e locande, delle concerie e dei
macelli;
l'imbottato,dazio
sul vino che s'introduceva in città, sull 'aceto ,
acquavite, acque rinfrescative, e altre imposizioni diverse sul salnitro,
le polveri, il piombo e le carte da giuoco, sul lotto e sulle professioni.
Un'imposta spe ciale gravava sugli israeliti. Essi, sotto il regno di
Carlo Emanuele III,·erano 5350 in Piemonte, dai quali 1427, re sidenti
in Torino (2). Questi ultimi pagavano allo Stato un canone com–
plessivo di 25.000 lire, e gli altri sparsi nelle città e nelle terre piemon–
tesi corrispondevano un tributo di 20.000 lire. A tutti costoro, che
per la maggior parte esercitavano l'u sura, era consentito di esigere
nei loro cont ratt i
il
18 per cento sui capitali prestati.
Il giuoco del lotto, che Vittorio Amedeo
Il
aveva abolito nel 1713,
venn e ristabilito, per necessità finanziarie, da Carlo Emanuele III, e
sul cader del secolo fruttava allo Stato ben 200.000 lire annue.
Si ch iamò dapprima
Gioco del Seminario,
forse perchè il primo
botteghino venne aperto nei pressi del Convitto dei chierici; poi
prese il nome che ancora con serva di giuoco del lotto.
L'estrazione dei numeri si faceva sul bal cone grande del Palazzo
comunale, alla presenza del Vicario, dei Sindaci, del Segretario civico
e del Direttore del giuoco. Un bambino non ancora settenne cavava
i num eri, che erano subito pubblicati a suon di tromba.
La pa ssione del lotto dovette esser molto diffusa nel popolo, se
nel 1755 si noveravano in Torino ben undici prenditorie.
L'eser cizio dell e profe ssioni non era libero: il Governo stabiliva
il numero dei professionisti e fissava la tassa che ciascuno di essi
doveva pagare allo Stato. I posti di pro curatore, in Torino, non pote–
vano essere più di 40, e nelle altre citt à raggiungevano il numero
(1) Il cotizzo non era sempre proporzionato equamente. Susa, con 1916 abitanti,
nel 1785 paga va 1215 lire ; Saluzzo, con 11.000 abitanti, ne pagava 867, e Giaveno 418
con 7170 abitanti.
(2) 518 ad Alessandria, 400 a Moncalvo, 255 a Nizza, 252 a Vercelli, 239 ad
Acqui, 220 a Fossano, 100 a Saluzzo, 20 a Biella.


















