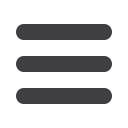
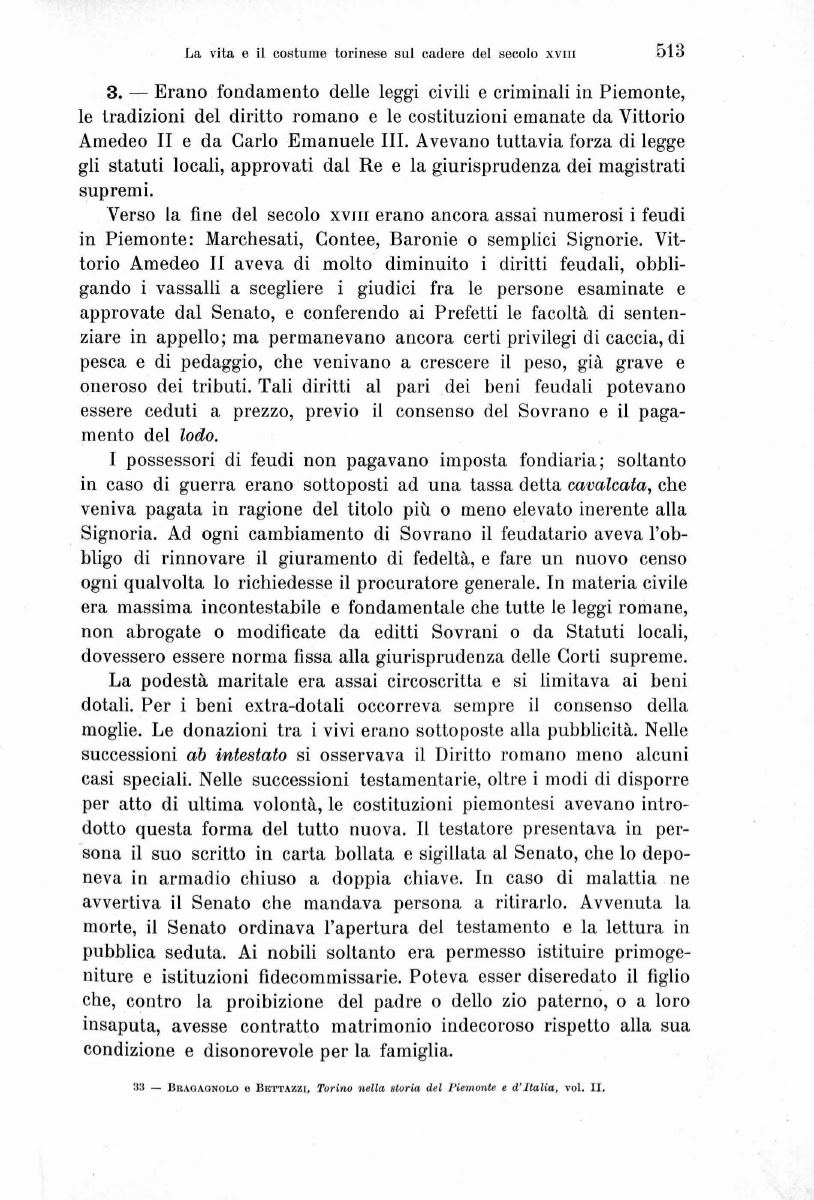
La vita e
il
costume torinese sul cadere del secolo
XVIIl
513
3. - Erano fondamento delle leggi civili e criminali in Piemonte,
le tradizioni del diritto romano e le costituzioni emanate da Vittorio
Amedeo II e da Carlo Emanuele III. Avevano tuttavia forza di legge
gli statuti locali, approvati dal Re e la giurisprudenza dei magistrati
supremi.
Verso la fine del secolo
XVIII
erano ancora assai numerosi i feudi
in Piemonte: Marchesati, Contee, Baronie o semplici Signorie. Vit–
torio Amedeo II aveva di molto diminuito i diritti feudali, obbli–
gando i vassalli a scegliere i giudici fra le persone esaminate e
approvate dal Senato, e conferendo ai Prefetti le facoltà di senten–
ziare in appello; ma permanevano ancora certi privilegi di caccia, di
pesca e di pedaggio, che venivano a crescere il peso, già grave e
oneroso dei tributi. Tali diritti al pari dei beni feudali potevano
essere ceduti a prezzo, previo il consenso del Sovrano e il paga–
mento del
lodo.
I possessori di feudi non pagavano imposta fondiaria; soltanto
in caso di guerra erano sottoposti ad una tassa detta
cavalcata,
che
veniva pagata in ragione del titolo più o meno elevato inerente alla
Signoria. Ad ogni cambiamento di Sovrano il feudatario aveva l'ob–
bligo di rinnovare
il
giuramento di fedeltà, e fare un nuovo censo
ogni qualvolta lo richiedesse il procuratore generale. In materia civile
era massima incontestabile e fondamentale che tutte le leggi romane,
non abrogate o modificate da editti Sovrani o da Statuti locali,
dovessero essere norma fissa alla giurisprudenza delle Corti supreme.
La podestà maritale era assai circoscritta e si limitava ai beni
dotali. Per i beni extra-dotali occorreva sempre il consenso della
moglie. Le donazioni tra i vivi erano sottoposte alla pubblicità. Nelle
successioni
ab intestato
si osservava il Diritto romano meno alcuni
casi speciali. Nelle successioni testamentarie, oltre i modi di disporre
per atto di ultima volontà, le costituzioni piemontesi avevano intro–
dotto questa forma del tutto nuova. Il testatore presentava in per–
-sona il suo scritto in carta bollata e sigillata al Senato, che lo depo–
neva in armadio chiuso a doppia chiave. In caso di malattia ne
avvertiva il Senato che mandava persona a ritirarlo. Avvenuta la
morte, il Senato ordinava l'apertura del testamento e la lettura in
pubblica seduta. Ai nobili soltanto era permesso istituire primoge–
niture e istituzioni fìdecommissarie. Poteva esser diseredato il figlio
che, contro la proibizione del padre o dello zio paterno, o a loro
insaputa, avesse contratto matrimonio indecoroso rispetto alla sua
condizione e disonorevole per la famiglia.
33 - BRAGAONOLO
e
BE1'TAZZI,
Torino nella storia del Piemonte e d'Italia.
vol.
II.


















