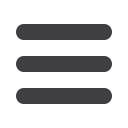
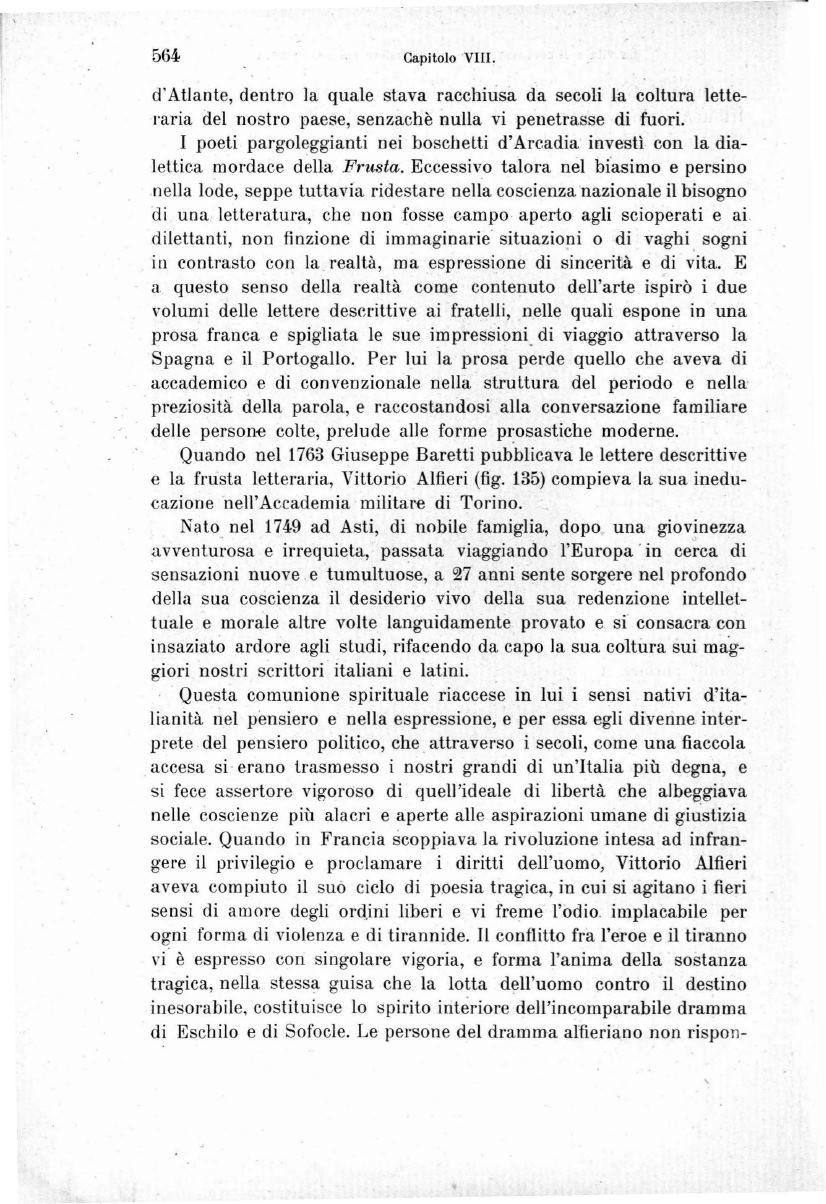
564
Capitolo VIII.
d'Atlante, dentro la quale stava racchiusa da secoli la coltura lette–
raria del nostro paese,
se nzach è
nulla vi pen etrasse di fuori.
I poeti pargol eggianti nei bo schetti d'Arcadia investì con la dia–
lettica mordace della
Frusta.
Eccessivo talora nel biasimo e persino
nella lode, se ppe tuttav ia ridestare nella cosc ienza nazionale
il
biso gno
di un a , letteratura, che non foss e campo, ap erto agli scioperati e ai
d ilett anti, non finzion e di immagin ari e' sit uazion i o di vagh i . sogn i
in contrasto con la , realtà , ma esp res sione di sincerit à e di vita. E
11
qu esto se ns o della re altà come contenuto dell'arte ispirò i du e
volumi delle lettere descrittive ai fratelli, nelle quali espone in una
pro sa franca e spigliata le sue impressioni. di viaggio attraverso la
Spagna e il Portogall o. Per lui la prosa perde quello che aveva di
a ccad emi co e di con venzionale nella ' struttura del periodo e nella
preziosit à della parola, e l'accostandosi alla convers azione familiar e
delle person-e colte, preJud e aIJ e form e prosastiche moderne.
Quando nel 1763 Giuseppe Baretti pubblicava le lettere descrittive
e la fru sta letteraria, Vittorio Alfieri (fig. 135) compieva la sua inedu–
cazione 'nell'Accademia militare di Torino.
Nato, ne l 1749 ad Asti , di nobile fami glia, dopo una giov.! nezza
avve nt urosa e irrequiet a, pa ssata viaggiando l'Europa ' in cerca di
sensazioni nuove .e tumultuose, a 27 anni se nte sorge re nel profondo '
della s ua coscienza il desiderio vivo della sua redenzione intellet–
tual e e morale a ltre volte lan guidamente pro vato e si consacra con
in saziato ardore agli s tud i, rifacendo da capo la sua colt ura sui mag–
giori no stri sc ritto ri itali ani e latini.
,
, Qu esta comu nione spiritua le riaccese in lui i sensi nativi d'ita–
lianità
nel pen siero e nella espressione,
e
per essa egli di venne inter–
p ret e del pen si ero politico , che , attraver so i secoli, come una fiaccola
, a ccesa si ' erano trasmesso i nostri grandi di un'Italia più degna, e
s i fece asse rto re vigoroso di , qu ell 'id eal e di libertà ch e alb eg:giava
nelle èosc ienze
più
alacri e ap erte all e aspirazioni umane di giustizia
socia le. Quando in F rancia scoppiava la rivoluzione intesa ad infran–
ge re il privil egio e proclam ar e i diritti dell'uomo, Vittorio Alfieri
aveva compiuto il suo ciclo di poesi a tragica , in cui si agitano i fieri
se ns i di amore degli ordini liberi e vi frem e l'odio, implacabile per
ogni forma di violenz a e di tirannide. Il conflitto fra l'eroe e il ti ranno
vi è es presso con singola re vigoria, e forma l'anima della sostanza
tragica, nella stessa guisa che la lotta dell'uomo cont ro il des tino
inesorabile, cos tituisce lo s pirito interiore dell'incomparabil e dramma
di Eschilo e di So focle. Le persone del dramma alfieri an o non r ispon-


















