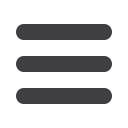
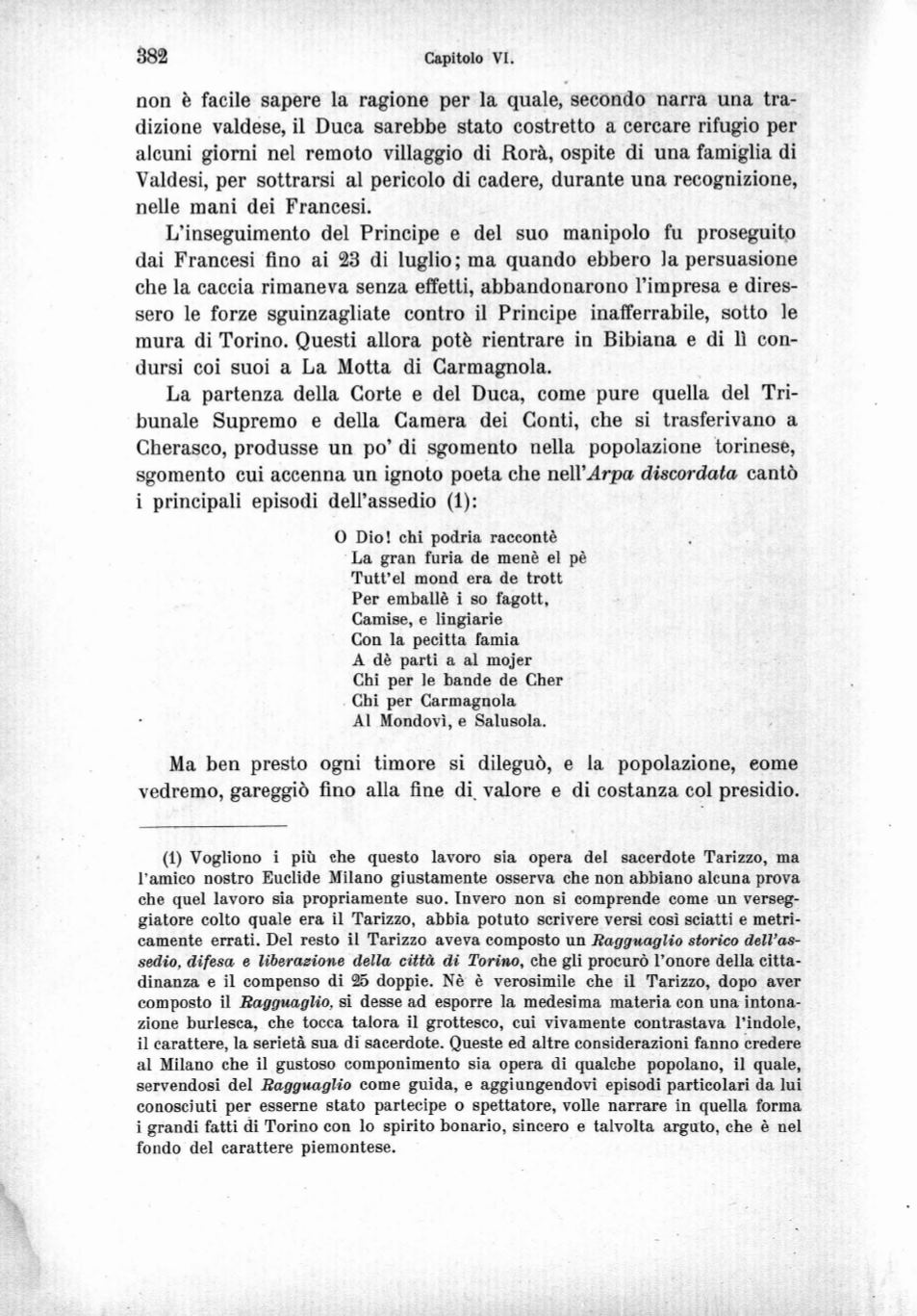
382
Capitolo VI.
non è facile sapere la: ragione per la quale,
seoondo'<narr à
una tra–
dizione valdese,
il
Duca sarebbe stato costretto a cercare rifugio per
alcuni giorni nel remoto villaggio di Rorà, ospite di una famiglia di
Valdesi, per sottrarsi al pericolo di cadere, durante una recognizione,
nelle mani dei Francesi.
L'inseguimento del Principe e del suo manipolo fu proseguito
dai Francesi fino ai 23 di luglio; ma quando ebbero la persuasione
che la caccia rimaneva senza effetti, abbandonarono l'impresa e dires–
sero le forze sguinzagliate contro il Principe inafferrabile, sotto le
mura di Torino. Questi allora potè rientrare in Bibiana e di
lì
con-
. dursi coi suoi a La Motta di Carmagnola.
La partenza della Corte e del Duca, come pure quella del Tri–
bunale Supremo e della Camera dei Conti, che si trasferivano a
Cherasco, produsse un po' di sgomento nella popolazione torinese,
sgomento cui accenna un ignoto poeta che
nell'Arpa discordala
cantò
i principali episodi dell'assedio (1):
o
Dio! chi podria raccontè
. La gran furia de menè el pè
Tntt'el mond era de trott
Per emballè i so fagott,
Camise, e lingiarie
Con la pecitta farnia
A dè parti a al mojer
Chi per le bande de Cher
. Chi per Carmagnola
Al Mondovi, e Salusola.
Ma ben presto ogni timore si dileguò, e la popolazione, eome
vedremo, gareggiò fino alla fine di, valore e di costanza col presidio.
(1) Vogliono i più che questo lavoro sia opera del sacerdote Tarizzo, ma
l'amico nostro Euclide Milano giustamente osserva che non abbiano alcuna prova
che quel lavoro sia propriamente suo. bivero non si comprende come
.un
verseg–
giatore colto quale era il Tarizzo, abbia potuto scrivere versi cosi sciatti e metri–
camente errati. Del resto il Tarizzo aveva composto un
Ragguaglio storico dell'as–
sedio , difesa
e
liberazione "dello: città di Torino,
che gli procurò l'onore della citta–
dinanza e
il
compenso di
~5
doppie. Nè è verosimile che
il
'I'arizzo, dopo aver
composto il
Ragguaglio,
si desse ad 'esporre la medesima materia con una intona–
zione burlesca, che tocca talora il grottesco, cui vivamente contrastava l'indole,
il carattere, la serietà sua di sacerdote. Queste ed altre considerazioni fanno credere
al Milano che il gustoso componimento sia opera di qualche popolano,
il
quale,
servendosi del
Ragguaglio
come guida, e aggiungendovi episodi particolari da lui
conosciuti per esserne stato parlecipe o spettatore, volle narrare in quella forma
i grandi fatti di Torino con lo spirito bonario, sincero e talvolta arguto, che è nel
fondo del carattere piemontese.


















