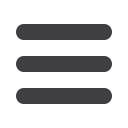
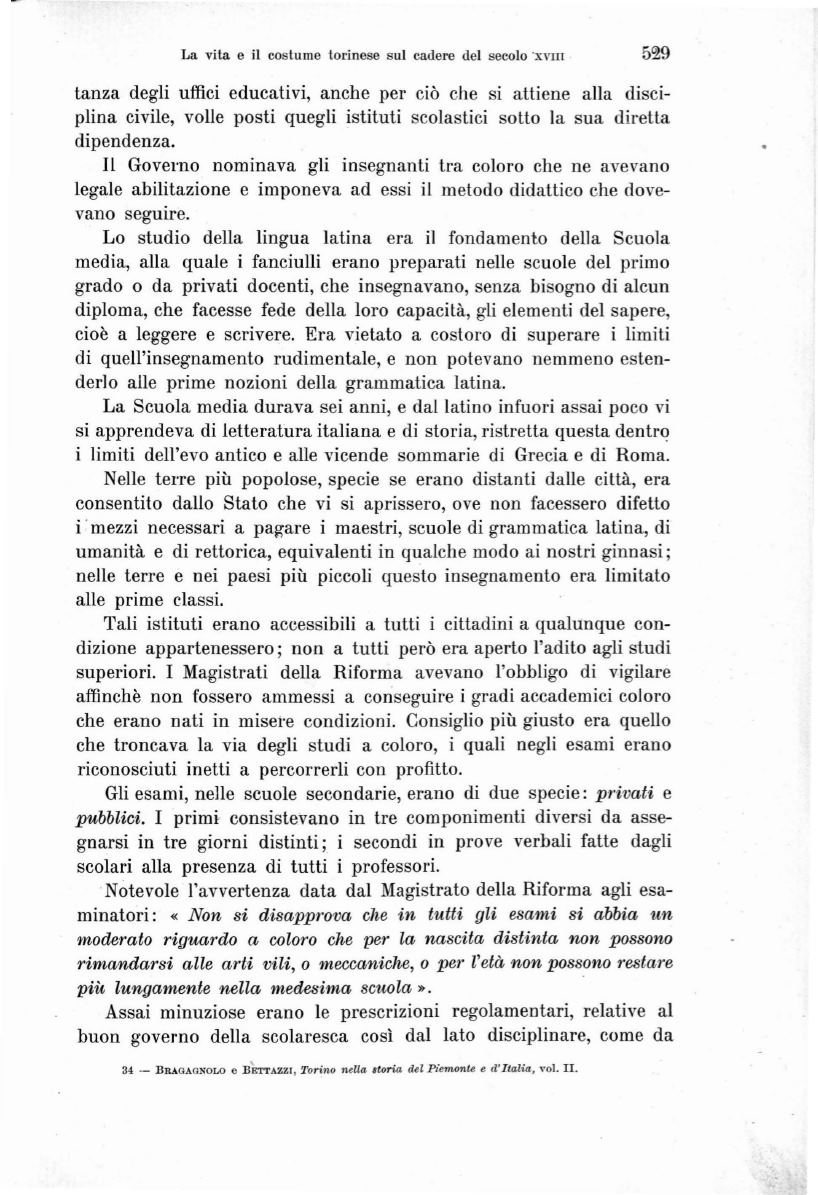
La vita e
il
costume torinese su l cadere del secolo
'XVIII
529
tanza degli uffici educativi, anche per ciò che si attiene alla disci–
plina civile, volle posti quegli istituti scolas tici sotto la sua dir etta
dipendenza.
Il Governo nominava gli ins egnanti tra coloro che ne avevano
legale abilitazione e imponeva ad essi
il
metodo didattico che dove–
vano seguire.
Lo studio della lingua latina era il fondam ento della Scuola
media, alla quale i fan ciulli erano preparati nelle scuol e del primo
grado o da privati docenti , che insegnavano, senza bisogno di alcun
diploma, che faces se fede della loro capacità, gli elementi del sa pere,
cioè a legger e e scrivere. Era vietato a costoro di superare i limiti
di quell'insegnamento rudimentale, e non potevano nemmeno esten–
derlo alle prim e nozioni della grammatica latina.
La Scuola media durava sei anni, e dal latino infuori assai poco vi
si apprendeva di letteratura italiana e di storia, ristretta questa dentro
i limiti dell'evo antico e alle vicend e sommarie di Grecia e di Roma.
Nelle terre più popolose, specie se erano distanti dall e città, era
consentito dallo Stato che vi si aprissero, ove non facessero difetto
i .mezzi necessari a pa gare i maestri, scuole di grammatica latina, di
umanità e di rettorica, equivalenti in qualche modo a i nostri ginnasi;
nell e terre e nei pa esi più piccoli questo insegnamento era limitato
alle prime classi.
'l'ali istituti erano accessibili a tutti i cittadini a qualunque con–
dizione appartenesse ro; non a tutti però era aperto l'adito agli studi
superiori. I Magistrati della Riforma avevano l'obbligo di vigilare
affìnchè
non fossero ammessi a conseg uire i gradi accad emici coloro
che erano nati in misere condizioni. Cons iglio più gius to era quello
che troncava la via degli studi a coloro, i quali negli esa mi erano
riconosciuti inetti a percorrerli con profitto.
Gli esami, nelle scuole secondarie, erano di du e specie :
privati
e
pubblici.
I primi cons istevano in tre componimenti diversi da asse–
gnarsi in tre giorn i distinti; i secondi in pro ve verbali fatte dagli
scolari alla presenza di tutti i profe ssori.
.Notevole l'avv ertenza data dal Magistrato della Riform a agli esa–
minatori:
«
Non si disapprova che in tutt i gli esami si abbia un
moderato riguardo a coloro che per la nascita di st'inta non possono
rimandarsi alle arti vi li, o meccaniche, o per l'età non possono restare
più, lungamente nella medesima scuola» .
Assai minuziose erano le pr escrizioni regolamentari, relative al
buon governo della scolaresca così dal lato disciplinare, come da
34 - BRAGAONOLO
o
BETTAZZI,
Torino nella ' toria <leI Piemonte e ,l'Italia,
vol. II.


















