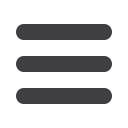
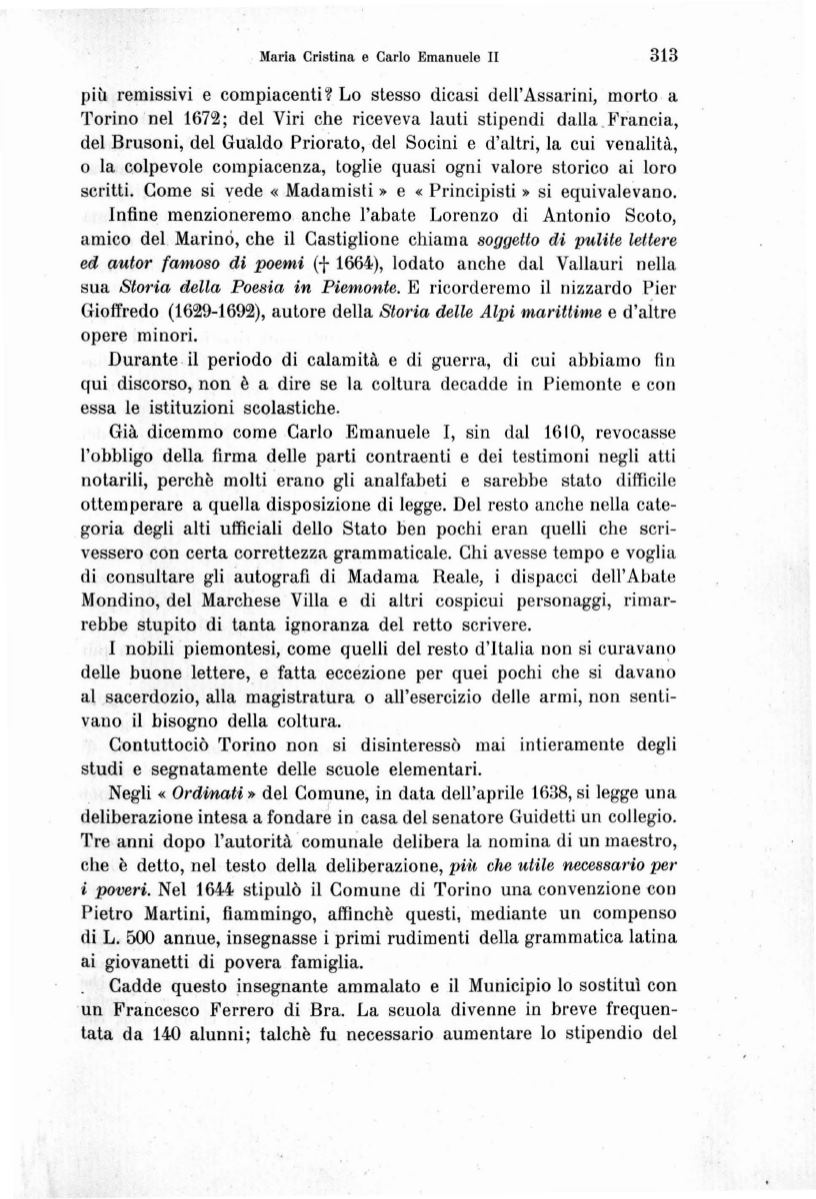
lIIaria Cristina e Carlo Emanuele II
313
pi
ù
remi ssivi e compiacenti
~
Lo stess o dicasi dell'Assarini, morto a
'l'orino ' nel 1672; del Viri che riceveva lauti stipendi dall aFranoia,
del Brusoni, del Gualdo
Priorato. idel
Socini e d'altri, la cui
venalità,
o la colpevole compiacenza, toglie quasi ogni valore storico ai lor o
scritti. Come si vede
«
Madami sti » e
«
Principisti » si equivalevano.
Infine menzioneremo anche l'abate Lorenzo di Antonio Scoto,
amico del. Marin o, che il Casti glione chiama
soggetto di pulite lettere
ed autor famoso di poemi
(t
1664), lodato anche dal Vallauri nella
sua
Storia della Poesia in Pi emonte.
E ricord eremo il nizzardo Pier
Gioffredo (1629-1692), autore della
Stori a delle Alpi marittime
e d'altre
opere minori.
Durante .
il
periodo di calamità e di guerra , di cui abbiamo fin
qui discorso, non è a dire se la coltura decadde in Pi emonte e con
essa le istituzioni scolas tiche .
Già dicemmo come Carlo Emanuele I, sin dal 1610, revo casse
l'obbligo della firma delle parti contraenti e dei testim oni negli atti
notarili, perchè molti 'erano gli analfab eti e sarebbe stato difficile
ottemperare a qu ella dispo sizione di legge. Del resto anche nella cate–
goria degli alti ufficiali dello Stato ben pochi eran quelli che sc ri–
vessero con certa corre tt ezza grammaticale. Chi avesse temp o e voglia
di cons ultare gli autografi di Madama Reale, i dispacci dell'Abate
Mondino, del Marchese Villa e di altri cospi cui personaggi, rimar–
rebbe stupito di tanta ignoranza del retto scrivere.
I nobili piemontesi, come quelli del resto d'Italia non si cur avan?
delle buone lettere, e fatta eccezione per qu ei pochi che si davan o
al sacerdozio, alla magistratura o all' esercizio delle armi, non senti–
vano il bisogno della coltura.
Contuttociò Torino non si disinter essò mai inti eramente degli
st udi e segnatamente dell e scuole elementari.
Negli
«
Ordinati»
del Comune, in data dell'aprile 1638, si legge una
deliberazione intesa a
fondar~
in casa del se na tore Guidetti un collegio.
Tre anni dopo l'autorità ' comunale delibe ra la nomin a di un maestro,
che è detto, nel testo della deliberazione,
piì~
che utile necessario per
i
poveri.
Nel 1644 stipulò il Comune di Torino una conve nzione con
Pietro Martini, fiammingo, affinchè que sti , mediante un compens o
di L. 500 annue, insegnasse i primi rudimenti della grammatica latina
ai giovanetti di povera fami glia .
Cadde qu esto insegnante ammalato e il Municipio lo sostituì con
'un Francesco Ferrero di Bra. La scuola divenne in br eve frequen–
tata da 140 alunni ; tal chè fu necessario aumentare lo stipendio del


















